Abbiamo posto alcune domande a Carlo Ginzburg, sul mestiere di storico e sul suo celebre libro Il formaggio e i vermi, recentemente riedito da Adelphi, del quale è apparsa la recensione su Pulp Libri. Pubblichiamo qui l’intervista, ringraziando il professor Ginzburg per la squisita cortesia.
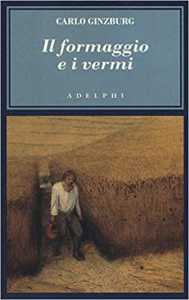 Nella prefazione a Il formaggio e i vermi, apparso per la prima volta a metà degli anni Settanta, lei parlava della diffusa persistenza di una concezione aristocratica di cultura da parte degli storici, che soltanto a fatica e con diffidenza cominciavano ad aprirsi alla discussione sul rapporto tra la cultura delle classi subalterne e quella delle classi dominanti, e auspicava la comprensione della circolarità e dell’osmosi tra i due livelli. Qual è oggi la situazione? La non subalternità di una cultura verso l’altra è un dato acquisito, o in ambito storiografico persiste un atteggiamento per così dire colonialistico, o almeno paternalistico?
Nella prefazione a Il formaggio e i vermi, apparso per la prima volta a metà degli anni Settanta, lei parlava della diffusa persistenza di una concezione aristocratica di cultura da parte degli storici, che soltanto a fatica e con diffidenza cominciavano ad aprirsi alla discussione sul rapporto tra la cultura delle classi subalterne e quella delle classi dominanti, e auspicava la comprensione della circolarità e dell’osmosi tra i due livelli. Qual è oggi la situazione? La non subalternità di una cultura verso l’altra è un dato acquisito, o in ambito storiografico persiste un atteggiamento per così dire colonialistico, o almeno paternalistico?
Più di quarant’anni dopo, com’era prevedibile, il tema del rapporto storico tra classi dominanti e classi subalterne si presenta in maniera molto diversa. Nella prefazione a Il formaggio e i vermi rinviavo alle riflessioni di Antonio Gramsci sulle “classi subalterne”, e alla lettura, filtrata dall’antropologia britannica, che ne aveva fatto Eric Hobsbawm. Nel frattempo le riflessioni di Gramsci hanno avuto un’amplissima eco internazionale: basti pensare al gruppo di storici indiani dei “Subaltern studies”, emerso negli anni Ottanta. Oggi però si è indebolito, o forse è scomparso del tutto, un elemento che aveva permesso di approfondire questo tema: il dialogo tra storici e antropologi, vivissimo negli anni Settanta e Ottanta.
Sempre nella prefazione, riferendosi a Michel Foucault e agli sbocchi di un certo filone di ricerche che a lui si rifaceva, lei parla di “irrazionalismo estetizzante”, notando che quel suo modo di procedere nell’analisi e nell’interpretazione denotava in realtà il rifiuto dell’analisi e dell’interpretazione. La pensa ancora così?
Su questo punto non ho cambiato idea. Ma un discorso complessivo sull’opera di Foucault dovrebbe tener conto di tutta la sua traiettoria, fino agli ultimi scritti. Un compito difficile, se condotto in una prospettiva non agiografica, come invece succede di solito.
 Il famigerato positivismo ingenuo che pendeva come una spada di Damocle sugli studiosi del passato è un pericolo ancora oggi esistente per gli storici odierni?
Il famigerato positivismo ingenuo che pendeva come una spada di Damocle sugli studiosi del passato è un pericolo ancora oggi esistente per gli storici odierni?
Il pericolo esiste sempre, senza dubbio – anche se lo scetticismo ipernarrativista, spesso altrettanto ingenuo, mi pare molto più pericoloso. E tuttavia evitare questi due pericoli non è semplice: come disse una volta Arnold Schönberg, tutte le strade portano a Roma, tranne la via di mezzo. Non esistono itinerari di ricerca predeterminati.
Come si è evoluto dal tempo in cui scrisse questo libro l’approccio alla cosiddetta “cultura popolare”? Sono stati fatti decisivi passi in avanti nella ricerca in questo campo di studi?
Come ho accennato nella postfazione alla nuova edizione de Il formaggio e i vermi, gli studi sulla “cultura popolare” sono stati recentemente liquidati, in quanto parte di un capitolo della ricerca che non ha più niente da dire. Sono convinto del contrario. Il termine “storia globale” può essere inteso in molti modi, ma una cosa è certa: per ricostruire la cultura e i comportamenti dei popoli colonizzati bisogna fare i conti con l’enorme documentazione prodotta dalle potenze colonizzatrici in Africa, in Asia, nelle Americhe. Questo progetto potrà, e dovrà, tener conto di ricerche di tutt’altro genere, fatte in ambito europeo. Tra questi, anche il tentativo di ricostruire la cultura di un uomo come Menocchio (è solo un esempio, naturalmente) attraverso il filtro dei processi inquisitoriali. I problemi di metodo non sono, nei due casi, troppo diversi. Diversa è naturalmente la scala. Ma, come ho sostenuto partendo da un saggio di Francesca Trivellato, le implicazioni della microstoria per la storia globale sono innegabili.
Lei rintraccia la cosmogonia di Menocchio (in particolare l‘immagine del formaggio) nel terreno di rapporti e migrazioni culturali che, all’epoca in cui scriveva questo suo lavoro, era ancora poco esplorato. Postula cioè l’esistenza di una tradizione cosmologica millenaria che congiunse il mito alla scienza, formulando l’ipotesi di una trasmissione diretta, orale, di generazione in generazione. Immagino che in questi 45 e oltre anni la ricerca storica abbia fatto significativi passi in avanti su questo tema. Se così, i risultati conseguiti hanno in qualche modo confermato o smentito le sue tesi?
Su questo punto, come avverto nella postfazione già ricordata a Il formaggio e i vermi, ho cambiato idea. Oggi distinguerei il filtro dai contenuti, insistendo sulla dimensione analogica, legata all’esperienza quotidiana, delle idee di Menocchio sull’origine del mondo: “Della più perfetta sustantia del mondo [gli angeli] furono dalla natura produtti, a similitudine che de un formaggio si producono i vermi.”
 A un certo punto, lei scrive: “Dalla cultura del proprio tempo e della propria classe non si esce, se non per entrare nel delirio e nell’assenza di comunicazione”. È davvero sempre così? Nemmeno l’arte, la creazione artistica, sfugge a questa “gabbia”, come lei la definisce?
A un certo punto, lei scrive: “Dalla cultura del proprio tempo e della propria classe non si esce, se non per entrare nel delirio e nell’assenza di comunicazione”. È davvero sempre così? Nemmeno l’arte, la creazione artistica, sfugge a questa “gabbia”, come lei la definisce?
Anche la creazione artistica (compresa quella più estranea alle convenzioni correnti) è un prodotto storico. Ma oggi correggerei quell’affermazione, troppo unilaterale, insistendo anche sulla complessità della ricezione, di cui lo stesso Menocchio è un esempio.
A me pare di scorgere nel celebre libro di Erich Auerbach, Mimesis (che viene annoverato nella cosiddetta critica stilistica), un antecedente della metodologia della microstoria. E, considerati i suoi interessi multidisciplinari, mi viene da pensare che per lei quel testo possa aver avuto un qualche ruolo nel processo che ha portato alla messa a punto di questa metodologia. È così?
È proprio così. Di Mimesis, che lessi per la prima volta a diciotto anni nella traduzione italiana, m’impressionò subito la scelta di interpretare un’opera isolandone un passo, per analizzarlo in maniera approfondita. All’incirca nello stesso periodo scopersi, grazie ai saggi di critica stilistica di Leo Spitzer, la potenza ermeneutica del particolare rivelatore. La mia traiettoria verso la microstoria è cominciata da Spitzer e Auerbach. Grazie a loro, credo, compresi l’importanza decisiva de I re taumaturghi di Marc Bloch: la ricostruzione, attraverso l’analisi di un caso marginale, delle radici del potere monarchico nel (lungo) Medioevo.
Riguardo allo stile con cui struttura i suoi saggi, mi pare che lei faccia un uso estensivo della digressione: parte da un assunto, chiaramente esplicitato nella premessa, quindi amplia il discorso, apparentemente allontanandosi dal punto in questione, per poi ritornare sull’assunto, che appare così verificato. È una tecnica, questa, strumentale alla sua erudizione, che le permette un approccio interdisciplinare alla materia trattata. Se questa analisi è corretta, vorrei chiederle se su questa forma abbia in qualche modo influito la sua conoscenza dei procedimenti letterari.
Certamente. Penso subito a Proust: nella Recherche la linea retta non esiste. Dalla madeleine si sprigiona un intero passato; in un testo s’intrecciano altri testi, altri contesti, che dovranno essere portati alla luce. Per districare questi intrecci la strada sarà inevitabilmente tortuosa.
Lei ha spesso messo in guardia dai pericoli, nella ricerca storica, di farsi guidare da pregiudizi ideologici, di sovrapporre uno schema precostituito alla realtà. Nella pratica, come evita questi rischi, insiti peraltro in ogni attività cognitiva?
Come ho scritto in saggio che conto di tradurre tra poco in italiano (Our Words, and Theirs, ossia “Le nostre parole, e le loro”) gli storici partono da schemi, ossia da domande legate al presente, formulate in termini inevitabilmente anacronistici. Il rapporto col passato non è mai diretto, è sempre mediato (tranne che per un positivista ingenuo). Ma nel corso della ricerca gli schemi di partenza possono, e debbono, essere modificati (cosa di cui lo scettico ipernarrativista non tiene conto). Se questo non succede, si rischia di trovare quello che si cerca, punto e basta. E questo non è abbastanza.
Cosa significa essere uno storico oggi, in quest’epoca di endemica dimenticanza?
Bisogna più che mai nuotare contro corrente.



