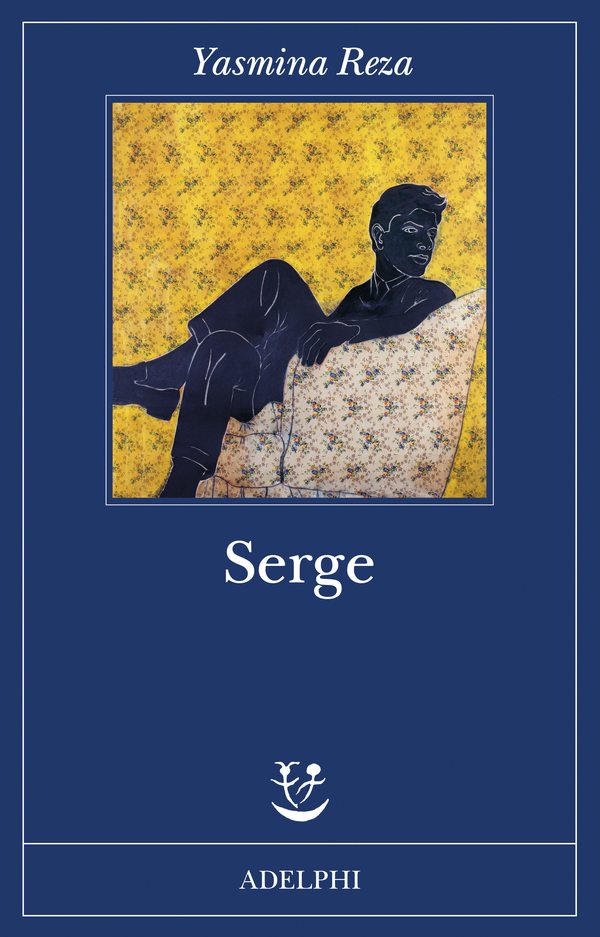Recensire Yasmina Reza è come recensire noi stessi, scarsità e miserie comprese e per di più messe in primo piano. Questa volta le sapienze intrinseche di questa scrittrice e drammaturga, certamente in piena letteratura, s’inoltrano nella specificità ebraica, spesso geniale e eternamente sconvolta dalla shoah: l’infrazione totale. La famiglia ebrea di Serge è narrata da uno dei suoi tre fratelli, Jean, ma il malessere dei loro confronti invade il lettore da ogni parte, con livelli di frenesie nevrotiche e disarmoniche relazioni a cui la scrittura di Reza ci ha abituati da diversi anni. Il suo livello di sensatezza aumenta sempre più, fa sentire prede e vittime di un mondo in cui la famiglia – esattamente come i Popper di cui qui si parla – si lega e slega con ritagli tanto miserevoli quanto infernali. In questo nuovo romanzo l’orecchio assoluto della scrittrice collabora attivamente con l’olfatto capace di percepire il delitto dei sentimenti nelle pieghe odorose dei rapporti umani, spesso furbesche e insolenti quando si tratta di familiari alle prese con i loro mostri.
In Serge, dopo funambolici dialoghi che riconosciamo anche nostri, in cui il genio degli ebrei si affaccia con modalità affini (e talvolta contrarie) a quelle messe in campo da Ph. Roth e W. Allen, i Popper tutti si ritrovano nel paesaggio atroce di Auschwitz: loro mettono in atto una specie di turismo dell’anima che ben presto si trasforma in un petulante intreccio di ovvietà e acidi pensieri su ciò che li circonda. Reza senza mezzi termini o scappatoie elenca i resti ferrosi, grigi e graffiati di una tragedia “trasformata” a Auschwitz (Oświęcim in polacco) in un percorso educativo ma inevitabilmente piegato dalla quotidianità becera dei visitatori. Mentre qualcuno ricorda che sono passati settantacinque anni da quando le camere a gas si sono fermate, altri rispondono “lasciaci mangiare due minuti”. Il giro si compie fra vagoni di legno e ferro isolati nel paesaggio vicino alla judenrampe dove arrivarono cinquecentomila deportati, fra i blocchi della morte e della tortura, le sale di gassificazione con le pareti rigate da tracce di graffi, mentre si ode lo sferragliare di un treno in transito ma è una registrazione.
La risposta a “è il peggior posto del mondo papà!”, è “sono aggredito dagli insetti”. La famiglia Popper disperde le sue voci nella cattività quotidiana e nei grappoli umani frenetici e muniti di zaini e borracce: gente in canottiere, tutine e sneakers colorate, un’invasione da cui nessun luogo del pianeta è immune. Monaci, cantanti rock, suore, scolaresche forse riluttanti a capire e forse intenti a cercare un panino imbottito. Past or Future, scritto a pennarello su un sasso. La presenza del male ancora circoscritta nel perimetro del luogo, evidentemente non privo di falle, fa sì che quest’ultimo diventi il teatro della resa dei conti: l’intreccio delle voci diventa un corrosivo alternarsi di botta e risposta in cui i solisti diventano predicatori e il gruppo mostra l’intera incertezza di fede e moralità. Un inseguimento a parole che non lascia scampo, in cui ci si strozza complice il caldo soffocante di quel giorno a Auschwitz. I legami fraterni, complessi e nevrotici si attestano su malumori e antipatie che nessuno ha voglia di sciogliere, e l’ebraismo diventa il centro in cui s’impantana una famiglia che cerca di attingere alla Storia senza alcun risultato, anzi esacerbando fino alla morte le arse vicende domestiche. Immediato, arriva lo sguardo di Reza a rappresentare sul teatro post–novecentesco cupe epifanie e la violenza di tutti, nessuno escluso.