Nel 1996, quando William T. Vollmann aveva pubblicato solo il romanzo di fantascienza d’esordio, You bright and Risen Angels, i primi due volumi dei Sette sogni, e cinque volumi di genere letterario indefinibile, in equilibrio tra fiction, memoria e saggistica, dà alle stampe questo L’atlante, perfetta summa della poetica di uno dei più prolifici autori contemporanei negli Stati Uniti: una specie di vetrina sulla sua produzione precedente, e un’allettante anticipazione di quello che ci si poteva aspettare in futuro.
La stessa struttura palindroma di L’atlante sembra testimoniare questa volontà di farne un ideale “ombelico”, un punto centrale della sua produzione narrativa già pubblicata e a venire. Per la nostra fortuna di lettori vollmann-dipendenti, con il passare degli anni questa centralità non è più vera: la maggior parte dei libri sono apparsi nella seconda parte della carriera dell’autore, dopo L’atlante. L’aspetto sorprendente è però il fatto che questo libro rimane comunque una specie introduzione allo scrittore, un campionario di stili, temi, generi, personaggi e punti di vista valido ancora oggi, oltre un quarto di secolo più tardi. Dunque, porta d’accesso, un primo passo nel mondo di un autore originale, spiazzante, che non si può fare a meno di amare o detestare? Di questo sarei meno sicuro. Vollmann non è un autore facile, occorre entrare in confidenza con la sua prosa, con il suo stile solo apparentemente distaccato, in realtà partecipe a fondo dell’ingiustizia e del dolore.
L’atlante ha questo titolo perché per volontà dell’autore ogni unità narrativa – non saprei come chiamare altrimenti quelli che non sono né racconti né capitoli – porta come sottotitolo un luogo fisico e un anno: per esempio, “Indovini. Yangon, Myanmar (1993)” oppure “Una visione. Big Bend, California, Usa (1994)”. Lo spunto di partenza è in genere autobiografico, l’autore è stato in ciascuno di questi luoghi, come sanno i lettori di Storie di Farfalla, La camicia di ghiaccio e altri fra i suoi primi libri; il contenuto dei capitoli-racconti non ha tuttavia relazione con altri libri, si tratta di esperienze vissute come in un backstage, durante una documentazione sul campo. Un campionario di personaggi, situazioni, dialoghi, che generano pensieri, immagini, sentimenti. Non sono riflessioni astratte, indotte da luoghi e fatti, ma accumulazioni di eventi riferiti con uno stile talvolta spoglio, sintetico, talaltra sorprendentemente vivido, con quella capacità che ha Vollmann di costruire immagini a partire dai colori.
 Vollmann scrive spesso in prima persona, confondendo il lettore sul livello di autobiografia del testo; senz’altro è stato in ciascuno dei paesi raccontati, e senza dubbio ha vissuto momenti, pericoli e emozioni, però occorre dire che il confine tra memoria e fiction è permeabile. Questo è la cifra caratteristica della sua poetica: l’esperienza personale diventa narrativa, letteratura e saggistica si sovrappongono, perché non c’è meno verità nella fiction rispetto alla realtà, e ogni resoconto non è una trascrizione obiettiva bensì un’interpretazione.
Vollmann scrive spesso in prima persona, confondendo il lettore sul livello di autobiografia del testo; senz’altro è stato in ciascuno dei paesi raccontati, e senza dubbio ha vissuto momenti, pericoli e emozioni, però occorre dire che il confine tra memoria e fiction è permeabile. Questo è la cifra caratteristica della sua poetica: l’esperienza personale diventa narrativa, letteratura e saggistica si sovrappongono, perché non c’è meno verità nella fiction rispetto alla realtà, e ogni resoconto non è una trascrizione obiettiva bensì un’interpretazione.
L’atlante ha, come detto, una struttura palindroma, e l’autore stesso nella prefazione autorizza il lettore a non rispettare l’ordine dei capitoli. Il punto di svolta centrale è rappresentato dal lungo racconto che porta il titolo della raccolta, e che spazia praticamente in tutti i continenti: una storia in equilibrio tra surreale e espressionismo (perché Vollman è un virtuoso espressionista), che slitta con sottili metonimie geografiche e narrative tra un luogo e l’altro, tra un tempo e un altro precedente, come la trascrizione di un lungo videoclip nel quale le immagini si accumulano senza consequenzialità logica, un caleidoscopio di suoni, colori, sentimenti, un elettroshock di bellezza versato direttamente nel cervello del lettore.
La scrittura di Vollmann cammina in equilibrio su una lama di rasoio: da una parte c’è un mondo di drogati, prostitute, violenza, degradazione, sudiciume, cattiveria, raccontati sempre con una sobrietà morale che si astiene da qualsiasi giudizio; dall’altra, momenti di illimitata bellezza, immagini che strappano il cuore, un’invenzione linguistica mai fine a se stessa – una profondità di significati che provoca vertigine, che si insinua nella coscienza del lettore e lavora sottotraccia, anche a distanza di tempo. Per il sottoscritto, uno dei capitoli più toccanti è Sotto l’erba, in cui Vollmann racconta per la prima volta la morte per annegamento della sorella, nel 1968, mentre era affidata alle sue cure di fratello maggiore: senza lirismo né autocommiserazione, senza realismo né politically correct, dimostra come l’irrequietezza, l’ipersensibilità e la denuncia dell’ingiustizia siano il prodotto di un senso di colpa senza limiti, che spinge lo scrittore a cercare la pietà anche nell’abiezione, la bellezza della vita nel vuoto dei sentimenti, il mistero nell’orrore.
William T. Vollmann / Una continua erranza
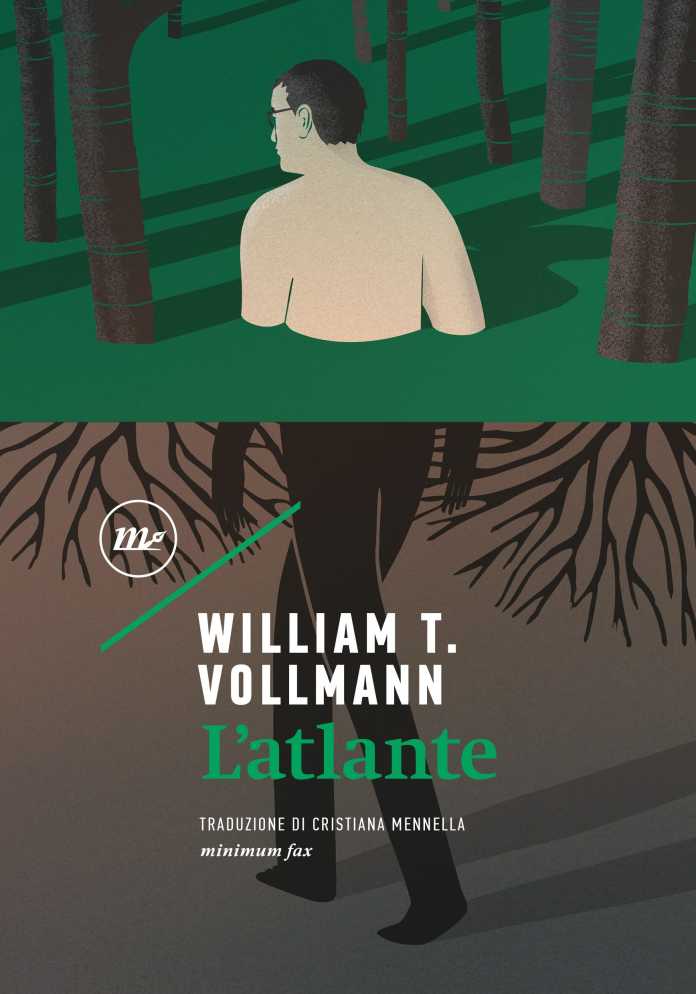
William T. Vollmann, L’atlante, tr. Cristiana Mennella, minimum fax, pp. 546, euro 20,00 stampa, euro 12,99 epub



