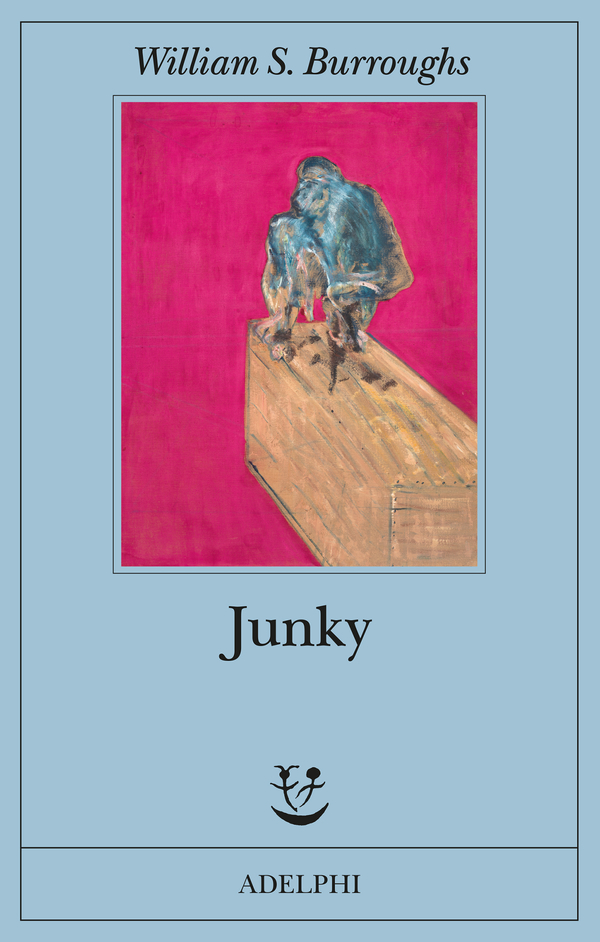Il primo romanzo pubblicato da William S. Burroughs emerge da una tortuosa trafila editoriale che questa definitiva edizione appena licenziata da Adelphi delinea nella sua interezza. La versione presente, Junky. Confessioni di un tossicodipendente irredento (curata da Oliver Harris), rispecchia l’edizione più recente Penguin del 1977 che completa la ristampa del 1973 dell’edizione originale Junkie, uscita nel 1952, sotto lo pseudonimo di William Lee, per la casa editrice pulp Ace Books (in Italia venne tradotta da Rizzoli nel 1962 e ristampata nel 1976 sotto il titolo di La scimmia sulla schiena), ripristinando le parti censurate o tagliate rispetto al manoscritto che l’autore avrebbe voluto far uscire come Junk, titolo modificato da Ace per evitare il possibile equivoco sul termine slang per “drogato” e il significato ordinario del sostantivo per “rifiuto”, “spazzatura”. Le edizioni Ace pubblicavano, come molti paperback popolari statunitensi degli anni ’50, due romanzi insieme sulle due facciate opposte del volumetto: il curioso destino della cronaca criminale e trasgressiva di dipendenza e spaccio descritta da Burroughs fu finire accoppiata proprio con l’antitetico Narcotic Agent, storia ugualmente semiautobiografica di uno sbirro della odiata sezione antinarcotici della polizia. Il testo è uno fra i più lineari e leggibili di Burroughs (in realtà l’unico che io sia mai riuscito a leggere fino in fondo) che, dato il contesto pulp cui era indirizzato, evita ogni sperimentalismo (ossia i futuri pseudo-dadaisti cut-up e fold-in che caratterizzeranno la sua prosa da The Naked Lunch in poi) per attestarsi su un più convenzionale, piacevole e secco stile hard-boiled.
Il rampollo viziato di una dinastia imprenditoriale altolocata e benestante (per chi volesse approfondire riguardo alla reale biografia di Burroughs, rimando a un mio pezzo di qualche anno fa su Carmilla) terminati gli studi in scuole elitarie e il tradizionale e aristocratico grand tour europeo, abbandona la famiglia – ma non il comodo assegno mensile che i genitori, forse proprio per tenere alla larga da loro questa imbarazzante pecora nera, continuano a passargli – e si abbandona alla deboche esperienziale nei bassifondi di New York. Affascinato dal crimine e dai criminali, dalle armi e dalla violenza, il giovane frequenta i peggiori delinquenti del milieu, ricettatori, rapinatori, magnaccia e, ovviamente spacciatori: venuto per caso in possesso di una partita di morfina da piazzare, decide di tenersene una parte per provarla. William Lee smentisce la leggenda usuale che basti una pera occasionale per restare agganciati: un neofita deve spararsi in vena una dose due volte al giorno per almeno un mese per ritrovarsi con la scimmia. È evidente dunque l’intenzionalità suicida con la quale il protagonista si lascia andare all’insorgere della dipendenza: come scrive, “La roba non è uno sballo. È uno stile di vita”.
 Il seguito è un susseguirsi di scene e di personaggi sordidi delineati con scarni tratti icastici, con un occhio da entomologo che non risparmia nessuno a cominciare da sé stesso. Fra aghi, pompette, contagocce, cucchiai, scorte, roba (questo il lessico e l’armamentario della tossicomania) si avvicendano dottori e farmacisti corrotti, che fanno il pizzo sulle ricette dei narcotici, spacciatori-tossicomani e tossicomani-spacciatori, non c’è differenza: “Non ho mai conosciuto un solo tossico che non spacciasse, né uno spacciatore che non facesse uso di stupefacenti”, e Bill Lee diventa uno di loro. Molla un compare in overdose soffiandogli i soldi che tanto non potrebbe spendere (ma lo incontra in strada il giorno dopo, si è ripreso, e non si arrabbia nemmeno con lui, quel che è successo è normale); si fa ricoverare a Lexington per un rehab; ci ricasca; lascia New York per il Texas; viene pizzicato; subisce un processo; scappa in Messico per evitare conseguenze legali; ricomincia tutto da capo: nuovi spacciatori e compari, sbirri corrotti, delatori; tenta di disintossicarsi da solo ma finisce solo per sostituire la roba con l’alcool e rischia di morire di intossicazione uremica; prova anche il peyote che però non lo convince, è un tipo da oppiacei. Le descrizioni disgustose di crisi di astinenza si susseguono; sfoga la frustrazione brutalizzando un povero gatto; prende a schiaffi la moglie che ha cercato di gettargli via le ultime scorte (il vero Burroughs la ucciderà nel 1951 con una revolverata in testa in circostanze mai chiarite: subirà un processo in Messico e se la caverà con una imputazione leggera per omicidio colposo); passa da una pera all’altra: morfina, eroina, codeina, speedball, mistura di ero e coca. Anche i fluidi corporei si mescolano: piscio, sangue, vomito, sperma; Bill rivela la propria omosessualità ma continua a chiamare “checche” gli altri omosessuali (e Queer, checca, sarà proprio il titolo del suo secondo romanzo, scritto quasi in contemporanea a questo ma pubblicato molti anni dopo). Il finale del libro lo coglie mentre progetta un viaggio in Amazzonia per provare lo yage, un allucinogeno che “si dice intensifichi la sensibilità telepatica”. Lo yage è il nome colombiano dell’Ayahuasca, enteogeno composto da Banisteripsis caapi e Psychotria viridis, contenente DMT, oggi ben noto e molto usato dagli psiconauti sotto la guida di veri o presunti sciamani. Burroughs negli anni seguenti riuscirà davvero a sperimentarlo, insieme al compare beat Allen Ginsberg, ma questo è ormai un altro libro (Lettere dello yage, Adelphi 2010).
Il seguito è un susseguirsi di scene e di personaggi sordidi delineati con scarni tratti icastici, con un occhio da entomologo che non risparmia nessuno a cominciare da sé stesso. Fra aghi, pompette, contagocce, cucchiai, scorte, roba (questo il lessico e l’armamentario della tossicomania) si avvicendano dottori e farmacisti corrotti, che fanno il pizzo sulle ricette dei narcotici, spacciatori-tossicomani e tossicomani-spacciatori, non c’è differenza: “Non ho mai conosciuto un solo tossico che non spacciasse, né uno spacciatore che non facesse uso di stupefacenti”, e Bill Lee diventa uno di loro. Molla un compare in overdose soffiandogli i soldi che tanto non potrebbe spendere (ma lo incontra in strada il giorno dopo, si è ripreso, e non si arrabbia nemmeno con lui, quel che è successo è normale); si fa ricoverare a Lexington per un rehab; ci ricasca; lascia New York per il Texas; viene pizzicato; subisce un processo; scappa in Messico per evitare conseguenze legali; ricomincia tutto da capo: nuovi spacciatori e compari, sbirri corrotti, delatori; tenta di disintossicarsi da solo ma finisce solo per sostituire la roba con l’alcool e rischia di morire di intossicazione uremica; prova anche il peyote che però non lo convince, è un tipo da oppiacei. Le descrizioni disgustose di crisi di astinenza si susseguono; sfoga la frustrazione brutalizzando un povero gatto; prende a schiaffi la moglie che ha cercato di gettargli via le ultime scorte (il vero Burroughs la ucciderà nel 1951 con una revolverata in testa in circostanze mai chiarite: subirà un processo in Messico e se la caverà con una imputazione leggera per omicidio colposo); passa da una pera all’altra: morfina, eroina, codeina, speedball, mistura di ero e coca. Anche i fluidi corporei si mescolano: piscio, sangue, vomito, sperma; Bill rivela la propria omosessualità ma continua a chiamare “checche” gli altri omosessuali (e Queer, checca, sarà proprio il titolo del suo secondo romanzo, scritto quasi in contemporanea a questo ma pubblicato molti anni dopo). Il finale del libro lo coglie mentre progetta un viaggio in Amazzonia per provare lo yage, un allucinogeno che “si dice intensifichi la sensibilità telepatica”. Lo yage è il nome colombiano dell’Ayahuasca, enteogeno composto da Banisteripsis caapi e Psychotria viridis, contenente DMT, oggi ben noto e molto usato dagli psiconauti sotto la guida di veri o presunti sciamani. Burroughs negli anni seguenti riuscirà davvero a sperimentarlo, insieme al compare beat Allen Ginsberg, ma questo è ormai un altro libro (Lettere dello yage, Adelphi 2010).