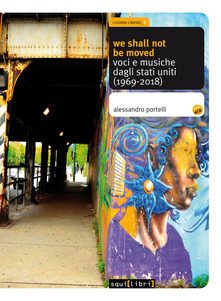Chiunque si sia interessato di musica popolare in genere, e in particolare di folk songs del Nord America, non può non aver incrociato Alessandro Portelli nelle sue ricerche. Infatti, oltre a essere uno dei maggiori esperti di letteratura anglo-americana, apprezzato in tutto il mondo, Portelli è stato il maestro che ha guidato più di una generazione alla scoperta della musica popolare. Quest’opera, We shall not be moved, voci e musiche dagli Stati Uniti, con i quattro CD a corredo, è il compendio di cinquant’anni del suo lavoro sul campo.
Quello che colpisce in questo testo è l’assoluta umiltà dell’autore, il quale appare solo come voce narrante di un’avventura letteraria e musicale che copre un arco temporale di quasi due secoli. A parlare sono soprattutto le donne e gli uomini che hanno fatto l’America, un’umanità variopinta e multietnica, che vive nelle proprie canzoni, siano esse canti sindacali, di lotta e di lavoro, oppure inni religiosi, gospel, blues, canti dei nativi americani, dei chicanos, degli asiatici. Molto utili, per avere un’idea più completa di questo lavoro, sono le registrazioni contenute nei quattro CD. L’opera, comunque, non è il settico resoconto di un accademico, Portelli ci conduce in questo viaggio attraverso la musica popolare americana con un’ottica di classe, percorrendo al contempo le tappe dei movimenti antagonisti negli Stati Uniti: dai grandi scioperi operai del secolo scorso, al movimento per i diritti civili degli afroamericani, alle manifestazioni contro la guerra nel Vietnam, fino ad arrivare a “occupy wall street”, alle manifestazioni di “black lives matter” contro la brutalità della polizia e a quelle degli studenti contro i massacri insensati nelle scuole.
Non a caso i cantori delle registrazioni sono al contempo i militanti di questi movimenti, i quali raccontano sia la genesi dei canti che interpretano, sia l’ambiente e la temperie nei quali i canti stessi si sono forgiati. Colpiscono l’estrema duttilità e adattabilità della musica popolare agli obiettivi che si prefigge l’espressione musicale: difatti, l’immenso repertorio degli inni religiosi, soprattutto delle chiese cristiane non cattoliche, viene ripetutamente “saccheggiato” dai sindacati e dalle organizzazioni operaie che adattano i testi e le musiche alle situazioni di lotta contingenti (i CD quindi riportano varie versioni di uno stesso canto). Analoga commistione si può osservare anche negli interpreti dei canti che sono contemporaneamente leader delle comunità religiose e militanti dei movimenti. Per esempio, le canzoni e gli interventi della controparata inaugurale di Richard Nixon del 1969 sono registrati in una chiesa metodista, mentre la “Ferrovia Sotterranea” – che portava gli schiavi verso la libertà durante la schiavitù – celava i suoi messaggi nei gospel cantati nelle chiese degli afroamericani. Non mancano nemmeno i tributi ai grandi interpreti della musica popolare, dall’hobo Joe Hill, a Woody Guthrie, Pete Seeger, Barbara Dane. Una delle ultime immagini del libro, infatti, è il ricordo di Pete Seeger novantenne, che canta “This land is my land” di Woody Guthrie – con le strofe censurate contro la proprietà privata – insieme con Bruce Springsteen (altro musicista amatissimo e studiato in molti saggi e libri da Portelli) all’inauguration day di Barack Obama.
Un altro aspetto peculiare che risalta dalla produzione musicale trattata in questo testo, è un diffuso sentimento di orgoglio di essere americani, pur se in modo antitetico e conflittuale con il potere; questo tipo di appartenenza quasi “patriottica” non è di facile comprensione per noi italiani, in quanto l’ideologia fascista si è appropriata del concetto di patria, stravolgendolo e facendolo oggetto di una retorica, giustamente chiamata in senso spregiativo “patriottarda”. Negli Stati Uniti, invece anche tra i più fieri oppositori all’establishment, permane questo senso di appartenenza, visto in un’ottica solidaristica, che lo si può far risalire ai germi sociali della guerra d’indipendenza, che d’altronde viene chiamata rivoluzione, per assonanza con la rivoluzione francese. È la nostalgia per quella che poteva diventare realmente la “terra degli uomini liberi”, quella che, in una canzone del tempo viene chiamata biblicamente la “terra dove scorre latte e miele”, anche se fin dall’inizio la “nascita della nazione” si fonda sul genocidio dei nativi – a questo proposito uno dei primi pamphlet a denunciare i massacri dei nativi è scritto da Benjamin Franklin, uno dei padri fondatori degli USA – e la si può trovare anche nelle canzoni della guerra civile, sia in quelle degli unionisti che dei confederati, produzione musicale molto interessante. Questa “appartenenza” arriva fino alla già citata “This land is my land” di Woody Guthrie e al rock urlato di “Born in the USA” di Bruce Springsteen.
Tutta l’opera comunque è soffusa di una nota di nostalgia e di rimpianto nel ricordo di movimenti che hanno subito la violenta repressione del potere costituito, ma l’ottimismo è rivoluzionario e quindi la speranza non viene mai meno perché il racconto conclude con le canzoni ritmate dai ragazzini delle medie a New York, durante la grande manifestazione dell’anno scorso contro le violenze nelle scuole a Washington Square, e quindi possiamo ben sperare che we shall overcome some day, perché l’autore ci dice che comunque noi non desistiamo, we shall not be moved.
Nel leggere i testi di questo libro torna in mente l’America descritta quasi un secolo fa nella sua autobiografia, da Big Bill Haywood degli IWW, gli Industrial Workers of the World, il sindacato rivoluzionario degli operai americani e al perdurare delle rivolte “intraprese dai diseredati per creare il paradiso qui in terra”, oggetto del recente saggio di M. Sersante e W. Montefusco Pensare la rivolta (DeriveApprodi, 2019).