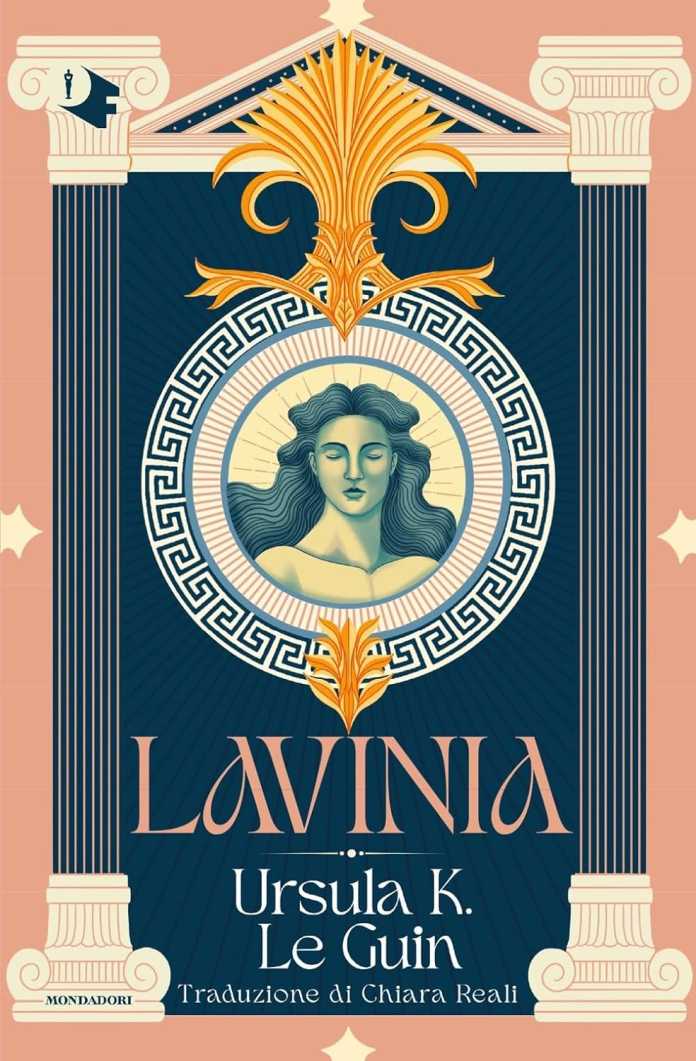“Chi è l’eroe?”
“Lo sai”.
“Uccide come un macellaio. Perché lo chiami eroe?”
Questo dialogo si svolge tra Lavinia, figlia di Latino, re del Lazio, e Virgilio, il poeta che la trasse fuori dall’oscurità della memoria, tra storia e leggenda, per darla in sposa a Enea e iniziare la saga che avrebbe prestato lustro al passato dei signori di Roma, trasformandone le origini in un poema immortale. Ed è Enea, quell’eroe che uccide come un macellaio, e come tale Virgilio lo racconta a una Lavinia diciottenne, alle soglie dell’incontro che le sarà fatale e sarà fatale alla storia del mondo, sotto le magiche fronde della selva Albunea, non distante da Laurento, la capitale del regno di Latino, un luogo prodigo di miracoli, dove la stirpe del re, dotata di poteri divinatori, va da tempo immemorabile a sacrificare il bestiame e ad ascoltare gli auspici. Il romanzo di Ursula Le Guin riracconta la storia tramandata da Virgilio e dalla vulgata romana, ma pone al centro della sua trama la figura di questa giovane donna che nell’Eneide non è molto più che una pallida comparsa, le conferisce personalità e sostanza, le affida la parola e il filo della narrazione: “La mia parte, la vita che mi ha dato nel poema, è così noiosa, se non per quel momento in cui i miei capelli prendono fuoco, così priva di colori, se non quando le mie guance nubili si infiammano come avorio chiazzato di porpora, così convenzionale che non lo posso più tollerare. Se devo continuare a esistere nei secoli dei secoli, allora almeno una volta devo iniziare a parlare. Non mi ha permesso di dire una parola. Devo prendermela da sola”.
 Un’operazione accurata, quella di Le Guin, che ricostruisce le usanze, i costumi, le dinamiche sociali degli abitanti di un Lazio antico, e li restituisce attraverso lo sguardo di Lavinia che è immersa in quella realtà e in quel flusso di eventi, conferendo alla sua figura grande spessore psicologico e al tempo stesso l’esemplarità di una testimone la cui voce viaggia attraverso i secoli e si offre a un pubblico moderno con la consapevolezza dell’oggi che si volge a contemplare l’ieri. Un’operazione accurata, abbiamo detto, ma anche rischiosa: per la plausibilità del personaggio e perché Lavinia è un chiaro anacronismo, troppo evoluta, troppo profonda di pensiero, troppo vicina a modelli che corrispondono alla modernità dell’autrice piuttosto che alla verosimiglianza storica. Eppure, proprio nello sciogliere questa contraddizione Le Guin si dimostra grande scrittrice: non pretende che si accetti acriticamente la sua ricostruzione del Lazio antico (ciò che, tra parentesi, fa la debolezza di opere analoghe, magari anche divertenti (pensiamo a Lest Darkness Fall di L. Sprague De Camp, per restare nell’ambito del fantastico), in cui il medioevo appare come un pastiche di luoghi comuni, con implausibilità stridenti e cadute di credibilità), le incoerenze che modernizzano i suoi personaggi, la complessità interiore di figure nelle quali si proiettano le sue istanze, ma, al contrario, ostentando gli anacronismi che il suo romanzo accampa e assegnando a passaggi fondati sulla visionarietà e la vertigine il ruolo di indicatori della sua direzione e del suo senso. Lavinia, allora, assurge a emblema di tutti i silenzi che hanno costellato la storia con vicende che ci sono giunte attraverso voci fragorose. In lei è racchiuso il germe di una possibilità diversa, di un’alternativa a quella scia di sangue di cui gli uomini, i maschi – da suo padre Latino al suo pretendente Turno a colui che sarà suo sposo, Enea – hanno costellato il proprio cammino, con la complicità di quelle donne che, come Amata, madre di Lavinia e moglie di Latino, li hanno assecondati senza ribellarsi, per scelta, per debolezza o per impotenza. Lavinia è diversa, e la sua diversità si attualizza attraverso una serie vertiginosa di paradossi temporali come quelli che le dischiude la sequenza di immagini delle quali si fregia lo scudo di Enea: “Questa è la Roma del mio poeta, quindi, la grande città rappresentata in molte delle immagini. Osservo più da vicino il centro dello scudo, la battaglia navale. Sulla poppa di una nave c’è un uomo dal volto bello e glaciale. Dalla sua testa esce del fuoco, una cometa si libra sopra di lui. Probabilmente è colui che è stato reso grande, l’augusto. Continuo a guardare e vedo cose che non avevo mai osservato prima. La città, o qualche grande città, è in rovina, completamente distrutta, bruciata. Vedo un’altra città distrutta, e un’altra ancora. Enormi incendi scoppiano in fila, uno dopo l’altro, e avvolgono tra le fiamme un’intera campagna. Enormi macchine da guerra arrancano sul terreno, si tuffano nel mare e sfrecciano nell’aria. La terra stessa brucia in pesanti nuvole nere. Un’immensa nube di distruzione si alza tonda sul mare alla fine del mondo. Lo so che è la fine del mondo”.
Un’operazione accurata, quella di Le Guin, che ricostruisce le usanze, i costumi, le dinamiche sociali degli abitanti di un Lazio antico, e li restituisce attraverso lo sguardo di Lavinia che è immersa in quella realtà e in quel flusso di eventi, conferendo alla sua figura grande spessore psicologico e al tempo stesso l’esemplarità di una testimone la cui voce viaggia attraverso i secoli e si offre a un pubblico moderno con la consapevolezza dell’oggi che si volge a contemplare l’ieri. Un’operazione accurata, abbiamo detto, ma anche rischiosa: per la plausibilità del personaggio e perché Lavinia è un chiaro anacronismo, troppo evoluta, troppo profonda di pensiero, troppo vicina a modelli che corrispondono alla modernità dell’autrice piuttosto che alla verosimiglianza storica. Eppure, proprio nello sciogliere questa contraddizione Le Guin si dimostra grande scrittrice: non pretende che si accetti acriticamente la sua ricostruzione del Lazio antico (ciò che, tra parentesi, fa la debolezza di opere analoghe, magari anche divertenti (pensiamo a Lest Darkness Fall di L. Sprague De Camp, per restare nell’ambito del fantastico), in cui il medioevo appare come un pastiche di luoghi comuni, con implausibilità stridenti e cadute di credibilità), le incoerenze che modernizzano i suoi personaggi, la complessità interiore di figure nelle quali si proiettano le sue istanze, ma, al contrario, ostentando gli anacronismi che il suo romanzo accampa e assegnando a passaggi fondati sulla visionarietà e la vertigine il ruolo di indicatori della sua direzione e del suo senso. Lavinia, allora, assurge a emblema di tutti i silenzi che hanno costellato la storia con vicende che ci sono giunte attraverso voci fragorose. In lei è racchiuso il germe di una possibilità diversa, di un’alternativa a quella scia di sangue di cui gli uomini, i maschi – da suo padre Latino al suo pretendente Turno a colui che sarà suo sposo, Enea – hanno costellato il proprio cammino, con la complicità di quelle donne che, come Amata, madre di Lavinia e moglie di Latino, li hanno assecondati senza ribellarsi, per scelta, per debolezza o per impotenza. Lavinia è diversa, e la sua diversità si attualizza attraverso una serie vertiginosa di paradossi temporali come quelli che le dischiude la sequenza di immagini delle quali si fregia lo scudo di Enea: “Questa è la Roma del mio poeta, quindi, la grande città rappresentata in molte delle immagini. Osservo più da vicino il centro dello scudo, la battaglia navale. Sulla poppa di una nave c’è un uomo dal volto bello e glaciale. Dalla sua testa esce del fuoco, una cometa si libra sopra di lui. Probabilmente è colui che è stato reso grande, l’augusto. Continuo a guardare e vedo cose che non avevo mai osservato prima. La città, o qualche grande città, è in rovina, completamente distrutta, bruciata. Vedo un’altra città distrutta, e un’altra ancora. Enormi incendi scoppiano in fila, uno dopo l’altro, e avvolgono tra le fiamme un’intera campagna. Enormi macchine da guerra arrancano sul terreno, si tuffano nel mare e sfrecciano nell’aria. La terra stessa brucia in pesanti nuvole nere. Un’immensa nube di distruzione si alza tonda sul mare alla fine del mondo. Lo so che è la fine del mondo”.
E così, allora, il romanzo procede nel duplice piano della riflessione su uno dei miti fondativi centrali per la costruzione della tanto decantata identità occidentale (e italiana in particolare, e più che mai di questi tempi), e la riflessione altrettanto cruciale sulle modalità del fantastico e sulle possibilità che esso possiede per scardinarlo, quel mito, e offrire alla nostra società dei modelli più umani e fecondi. Quelli che si reggono sulla consapevolezza di come le figure dei macellai e degli eroi quasi sempre coincidano, e di come siano altri i modelli davvero proficui e virtuosi, gli ideali ai quali rifarsi.