La Fortezza Europa esternalizza e cerca di chiudere i propri confini all’ingresso di migranti: a est lungo gli sbarramenti sulla Rotta Balcanica, a sud sul Mediterraneo. Con ulteriori confini marca il territorio interno: Ventimiglia, Trieste, Calais, Slovenia, Croazia, Grecia, le enclave spagnole di Ceuta e Melilla in Marocco. Le frontiere sono teatro di violazioni continue dei diritti umani, aree di trafficanti, violenza e morte. È indubbio. Periodicamente veniamo sollecitati (e alla fine assuefatti) alle manifestazioni più spaventose: le sistematiche ecatombi nel Mediterraneo, i morti saltati sulle mine o caduti nei crepacci nei paesi della ex-Jugoslavia. La narrazione pubblica degli effetti della necropolitica europea oscilla per lo più fra la cronaca della presunta invasione e il richiamo alla mera pietà.
Contro mappa
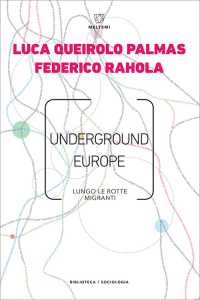 Underground Europe va oltre questi fatti indubitabili e rovescia il punto di vista raccontando un’altra Europa: quella in cui i migranti, attraverso una miriade di pratiche disperse, si rivelano soggetti attivi, bucando le frontiere, aprendo varchi, fino a ri-abitare e rigenerare luoghi in prossimità dei confini. Quei confini che, a corrente alternata, vengono resi illegali dalla parte “destra” dello Stato o ambiguamente porosi dalla parte “sinistra” quando sceglie di mettere in campo politiche di accoglienza che allargano le forme di regolarizzazione, secondo uno stop and go (gli autori usano l’espressione “guinzaglio” e “strappo”) modulato, principalmente, sugli interessi dei singoli Stati e del mercato del lavoro e in un tentativo di mediazione con le lotte e le pressioni esercitate dai migranti e dalle coalizioni che si formano spontaneamente lungo quella che si configura come una vera e propria contro mappa. È questo il tracciato che i due autori ripercorrono combinando storiografia e etnografia, attraverso uno sguardo militante.
Underground Europe va oltre questi fatti indubitabili e rovescia il punto di vista raccontando un’altra Europa: quella in cui i migranti, attraverso una miriade di pratiche disperse, si rivelano soggetti attivi, bucando le frontiere, aprendo varchi, fino a ri-abitare e rigenerare luoghi in prossimità dei confini. Quei confini che, a corrente alternata, vengono resi illegali dalla parte “destra” dello Stato o ambiguamente porosi dalla parte “sinistra” quando sceglie di mettere in campo politiche di accoglienza che allargano le forme di regolarizzazione, secondo uno stop and go (gli autori usano l’espressione “guinzaglio” e “strappo”) modulato, principalmente, sugli interessi dei singoli Stati e del mercato del lavoro e in un tentativo di mediazione con le lotte e le pressioni esercitate dai migranti e dalle coalizioni che si formano spontaneamente lungo quella che si configura come una vera e propria contro mappa. È questo il tracciato che i due autori ripercorrono combinando storiografia e etnografia, attraverso uno sguardo militante.
Dal libro emerge così, accanto a un’Europa sigillata come un’enorme trappola tesa a imbrigliare il movimento di decine di migliaia di migranti, uno spazio- tempo abitato in una cooperazione improvvisata e molecolare che si dispiega in tutte le occasioni di frontiera, e permette, nonostante i rischi e i pericoli, di bucare i confini, di provare ad andare oltre: verso una “libertà percepita” – forse solo immaginata – che si costituisce attraverso il viaggio stesso.
Un esempio su tutti: il grande campo di Calais sorto spontaneamente a ridosso della Manica (10.000 persone) non era un luogo vuoto di pura attesa – come vorrebbe la vulgata mainstream – ma una vera e propria “città” con una organizzazione interna, le sue contraddizioni, stratificazioni etniche e di classe, luoghi di culto, commercio di beni, luoghi di socialità e una propria forza organizzativa e potenzialmente vertenziale. Una città organizzata sul tempo del riposo (il giorno) e il tempo di fuga: il tentativo di attraversare la Manica (la notte). Per questi motivi, che si sottraevano alla governance della migrazione secondaria interna all’Europa, nel 2016 il campo di Calais viene spettacolarmente “sgomberato umanitariamente” e gli abitanti redistribuiti su tutto il territorio francese.
Gli autori rilevano che durante gli ultimi giorni di vita del campo arrivarono moltissime persone consapevoli che dallo sgombero e dai ricollocamenti in strutture statali avrebbero potuto ricavare qualche beneficio: tutti i richiedenti asilo hanno infatti avuto un permesso di 5-10 anni in Francia, in deroga al regolamento di Dublino che blocca e obbliga i migranti a fare richieste d’asilo nel primo Paese in cui lasciano le impronte. Sono i momenti go (o di “strappo” se si vedono dal punto di vista dei migranti) che si alternano a quelli puramente repressivi e forniscono occasioni di lotta e organizzazione collettiva come dimostrato dai citati richiedenti asilo capaci di approfittare della polverizzazione di un assetto per disegnarne un altro: diffondendo rapidamente le informazioni e cogliendo “opportunisticamente” il proprio momento.
Calais la vediamo replicata in moltissimi altri luoghi, dal City Plaza di Atene, ai campi e agli squat in Bosnia, ai campi di lavoro in Italia; non dei non luoghi ma luoghi vissuti, luoghi di sosta e riposo, luoghi paradossalmente sicuri per i propri abitanti che, in continuazione, anche nelle situazioni più derelitte e repressive, si riorganizzano per linee interne, socialità e resistenze.
Dove c’è un campo istituzionale, esiste sempre anche un campo spontaneo (al di là della qualità dell’accoglienza che in questo libro viene affrontata solo marginalmente); campi autogestiti che nascono e crescono attorno a tentativi autonomi di oltrepassare le maglie istituzionali dei procedimenti d’asilo: tentativi di autodeterminazione dei tempi e dei luoghi per la realizzazione dei propri progetti di vita.
Accanto al “linguaggio della vittima” che i migranti devono imparare a padroneggiare per convincere le commissioni che valutano le richieste d’asilo (come racconta acutamente Elvira Mujčić nel suo romanzo Consigli per essere un bravo immigrato), nel libro di Querirolo Palmas e Rahola emergono, potenti, linguaggi altri che dicono la politicità, la fantasia, la soggettività, ma anche – paradossalmente – il gusto del rischio e dell’avventura esemplarmente raccontato a proposito dei giovani nord africani che tentano il passaggio a Ceuta: “nelle loro conversazioni, usano colloquialmente il termine rizki per definire se stessi e lo sport estremo che praticano nel tentativo di salire illegalmente sui traghetti”.
Un gioco dunque, seppur mortale, e non è un caso che la stessa parola game venga usata da chi cerca di arrivare in Italia dalla Bosnia: tentativi ripetuti decine di volte con il rischio sempre presente di essere rimandati in Slovenia dall’Italia attraverso gli ormai famigerati “respingimenti informali” e di essere violentemente picchiati e derubati di tutto dalla polizia croata che fa il lavoro sporco per conto dell’Europa. Eppure un gioco: vitale e sempre pronto a rinascere e ridefinirsi aggirando le chiusure e i divieti. Gioco che è anche una guerra che richiede autodisciplina, una tattica e una strategia uguale e contraria alla guerra feroce che gli Stati e le frontiere hanno dichiarato ai migranti.
Underground Railroad
Underground Europe fa riferimento esplicito all’Underground Railroad, la ferrovia sotterranea che seguivano gli schiavi fuggiaschi durante la guerra civile verso il Nord degli Stati Uniti e il Canada.
Gli autori non sono i primi a fare un parallelo fra le due esperienze, approfondiscono le differenze storiche fra le due vie sotterranee a cui dedicano il primo capitolo del loro lavoro, sottolineando con forza che la Underground Railroad non fu mera espressione dello slancio filantropico di un gruppo di bianchi ‘redenti’, decisi ad aiutare gli schiavi in fuga; non si tratta infatti di una narrazione pacificata ma di una vicenda contesa ed essenzialmente Black, che segna la storia degli Stati Uniti attraverso l’insubordinazione degli schiavi pronti a disertare il sistema delle piantagioni. Per intendersi: la rete di solidarietà degli abolizionisti bianchi poggiava sul protagonismo dei Neri, tanto degli schiavi in fuga quanto delle comunità nere del nord. Proiettare la Underground Railroad nel presente significa per gli autori riconoscere nelle contro mappe percorse oggi dai migranti lo stesso protagonismo di allora, fuori da ogni retorica vittimaria e da ogni visione ingenuamente “umanitaria”. In ogni tappa del libro emergono così figure di migranti capaci di creare vie di fuga e relazioni di resistenza materiale che coinvolgono anche i solidali. E se la storia della democrazia americana nelle sue contraddizioni, tuttora brucianti, dipende dal contributo essenziale degli afroamericani, ugualmente la storia postcoloniale Europea – oggi – dipende dalla presenza di soggetti migranti e richiedenti asilo che possono aprire un nuovo spazio politico egualitario non razzializzato e gerarchizzato.
The refugee
Nel 1855 Benjamin Drew, abolizionista radicale, dà alle stampe A North-side of Slavery. The refugee: narratives of fugitives slaves in Canada (scaricabile in rete). Si tratta di un testo in cui lo scrivente fa un passo indietro per dare voce ai fuggitivi e agli ex schiavi, limitandosi a trascriverne le esperienze e le storie: “more or less in the speakers’ own words”. Solo attraverso le loro parole, sottolinea Drew nell’introduzione, si possono comprendere certe scelte, come, ad esempio, quella di lasciare la famiglia per andare in Canada (che era una monarchia) piuttosto che rimanere negli Stati Uniti. Per la prima volta gli schiavi raccontano e costruiscono una storia di sé che non sia quella cucita sui loro corpi dal loro padrone(1). Gli intervistati spiegano chi sono, da dove vengono e perché sono fuggiti ma, significativamente, per tutelare le vie dei prossimi fuggitivi, non rivelano mai come siano arrivati in Canada. La necessità dei fuggitivi di rendersi invisibili e cancellare le proprie tracce spiega anche le difficoltà degli storici nel ricostruire una mappa precisa dei luoghi e della consistenza reale della Underground Railroad, e, per inciso, lascia grande spazio alla immaginazione di scrittori come Colson Whithead, Ta-Nehisi Coates, lo stesso Thomas Pynchon, …
Queirolo Palmas e Rahola adottano nel loro lavoro lo stesso metodo di Drew: restituendo voce alla soggettività migrante, nella necessità “di rileggere i movimenti di migranti e profughi dentro e contro la borderland europea (…) andando alla ricerca di un punto di rottura, di ‘irruzione delle forze’ (e cioé di un soggetto plurale, una coalizione, una possibile abolition democracy), facendo riaffiorare storie sepolte, saperi assoggettati, soggetti squalificati – di ieri e di oggi”.
Coalizione
Tutte le stazioni della Europe Underground agglutinano una variegata coalizione di solidali che, mettendo da parte divergenze ideologiche, identitarie e di appartenenza, si ritrovano sull’obbiettivo immediato: la solidarietà con i migranti e il contrasto alle politiche confinarie. Chiunque abbia avuto a che fare con i richiedenti asilo e i rifugiati ha avuto a che fare anche con chiese, moschee, centri sociali, medici, scout, volontari di ONG o di cooperative, gente che lavora nell’accoglienza e concepisce il proprio lavoro al di là del salario, studenti e pensionati, cittadini indignati del trattamento riservato agli stranieri. Gli autori, nel loro viaggio, ne rendono conto tappa per tappa, ne rilevano le contraddizioni e i diversi approcci, i rapporti coi migranti a volte incerti, a volte più strutturati; è anche questa una mappa variegata di aggregazioni che si formano su emergenze e poi tornano sotterranee o proseguono nel tempo. Coalizioni di persone, trasgressori di leggi ingiuste o obbedienti a una legge altra che riconosce l’uguaglianza, il diritto al movimento, la ricerca di una vita migliore.
Queste coalizioni sono soggette alla stessa politica di stop and go dei migranti: a volte le pratiche dei solidali vengono tollerate o viste benignamente – soprattutto quando, di fatto, svolgono funzioni suppletive di quelle spettanti alle istituzioni in tema di accoglienza, a volte vengono criminalizzate e messe sotto accusa, specie se oltrepassano i confini della semplice carità e riescono a veicolare (e rendere potenzialmente riproducibili) pratiche di solidarietà attiva e di messa in discussione delle frontiere materiali e simboliche. I casi più eclatanti sono quelli della criminalizzazione delle navi che soccorrono i migranti nel Mediterraneo e quello di Riace e del suo sindaco Lucano, accusato e messo sotto inchiesta fino alla distruzione del suo modello di accoglienza, salvo poi ritirare le accuse a lavoro finito.
Nelle ultime settimane sotto stati messi sotto accusa per favoreggiamento della immigrazione clandestina (fino a 10 anni di carcere) Gian Andrea Franchi che da anni pubblicamente porta avanti una pratica umanitaria e politica verso i richiedenti asilo che arrivano a Trieste, punto terminale della Rotta Balcanica, e quattro esponenti di Mediterranea Saving Humans. Le accuse sono labili ma il messaggio politico è chiarissimo e il dispositivo di criminalizzazione è sempre pronto ad attivarsi: diffamando, screditando coloro che non si limitano all’esercizio della carità\beneficenza; forse nella convinzione reale della magistratura che trattare da soggetti di diritto i migranti sia effettivamente un gesto di favoreggiamento anche se non c’è lucro alcuno da parte di chi lo compie.
Extra libro. Una riflessione in forma di domande

La Underground Railroad è stata anche una storia di donne e di femminismo.
«Ho condotto in salvo schiavi per la Underground Railroad per 8 anni, e posso dire, al contrario di molti, che il treno che conducevo non ha mai deviato dalla sua strada e non ho mai perso un passeggero» dichiara Harriett Tubman (1822-1913) ex schiava e straordinaria “conduttrice” di fuggitivi che fu anche una convinta attivista per il suffragio femminile.
A loro volta, “lavorando all’interno del movimento abolizionista le donne bianche approfondirono la conoscenza della natura dell’oppressione umana – e del proprio assoggettamento. Affermando il proprio diritto a opporsi alle schiavitù – a volte apertamente, altre volte in maniera implicita – contro la propria esclusione dall’arena politica. Non riuscivano ancora a denunciare in maniera collettiva le proprie sofferenze, ma almeno potevano perorare la causa di un popolo che era, allo stesso modo, oppresso” scrive Angela Davis in Donna, razza, classe (Alegre, 2018) dove ricostruisce la storia del controverso rapporto fra il femminismo bianco statunitense e quello Nero.
Underground Europe rileva e commenta positivamente, oggi, la stessa presenza egemonica di donne nelle diverse coalizioni. Eppure anche questa sarebbe una storia da dire e approfondire. Cosa significa questa “egemonia” delle donne? Cosa muove le donne solidali, che rapporti intercorrono fra le istanze di libertà dei migranti e quelle delle donne solidali? Cosa mettono in gioco le donne in questa partita, in cosa le riguarda? Come si confrontano con culture a volte francamente patriarcali? Che rapporti si instaurano con le donne che – seppure in modo minoritario – attraversano questi stessi confini e con le donne che giungono in Europa seguendo le rotte del lavoro sessuale fra sfruttamento e scelte di autodeterminazione?
Le badanti, babysitter, prostitute, hanno in comune il ‘sacrificio’ del corpo (in un senso o nell’altro) in nome del benessere di mariti nullafacenti, figli che devono crescere (e possibilmente andare a scuola), genitori anziani, interi clan famigliari. Il tutto raddoppiato dal lavoro nelle nostre case. Sarebbe interessante sentire le loro voci a proposito dello spazio di avventura e desiderio che gli autori riscontrano insieme ad altre spinte alla migrazione nei giovani uomini.
La retorica che vuole le donne depositarie naturali della cura (peraltro in piena crisi del welfare) e del maternage, o peggio, dotate di una propensione ad occuparsi delle “vittime” è decisamente insufficiente; le riflessioni che attraversano il movimento femminista devono necessariamente attraversare anche queste pratiche ed esperienze.
NOTE
- Per una interpretazione estrema del rapporto fra storia e schiavitù, l’articolo di Marco Petrelli su “Afropessimism” di Frank B. Wilderson III.
Le immagini, tranne quella di Harriet Tubman sono tratte dal libro Underground Europe



