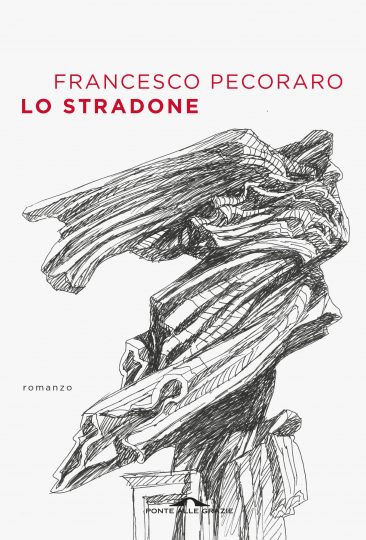Il caffè non è buono – dice il narratore – nell’unico bar che ancora resiste prima del curvone. Si fumano Marlboro rosse, i pensionati camminano spenti e malvestiti, chiusi in un opaco malumore tra sprazzi di razzismo qualunquista, evitando sui marciapiedi gli accumuli di immondizia e le deiezioni abbandonate dei cani. Siamo nel quadrante delle fornaci, nella sacca operaia che ha fatto a mani nude i mattoni e i laterizi che hanno ingrandito la città di Dio, nel quartiere che non è un quartiere, non è una borgata, non è aggregato urbano in armonia con il resto del territorio. Una comunità sub-urbana con una storia diversa.
Tutto questo lo troviamo ne Lo Stradone, l’ultima opera di Francesco Pecoraro, selezionato nella cinquina del Campiello di quest’anno. L’opera fa seguito, dopo sei anni di silenzio,al suo precedente romanzo La vita in tempo di pace (Ponte alle Grazie, 2013) vittorioso al Premio Viareggio e incluso nella cinquina finalista del premio Strega 2014. Ancor prima Pecoraro si era fatto notare con la silloge poetica Primordio vertebrale (Ponte Sisto, 2012), l’opera ibrida Questa e altre preistorie, (Le lettere, 2008) e la raccolta di racconti Dove credi di andare (Mondadori, 2007) che si aggiudicò il Premio Napoli e il Premio Giuseppe Berto per l’Opera Prima.
Per chi conosce la poetica di questo noto scrittore, poeta e architetto romano, non è difficile riconoscere in quest’ultimo scritto l’identità dei luoghi e dei personaggi che fanno capolino dietro le sue sibilline definizioni – tinte insieme di epica e di ironia – quali la Città di Dio (Roma), il Tempio della Redenzione (la cattedrale di San Pietro), lo Stradone (la zona di Valle Aurelia), l’Ultimo Segretario (Enrico Berlinguer).
Il narratore ne Lo stradone è uno storico dell’arte, accademico fallito nelle sue aspirazioni, e finito ad occupare una stanza in un ministero. Il personaggio è del tutto funzionale a incarnare lo spirito degli ultimi quattro decenni da cui proveniamo, la sfrenata competizione giovanile e il carrierismo anni Ottanta, le conseguenti speculazioni orgiastiche e la deriva tangentista, fino ad arrivare all’individualismo opaco, miope e rassegnato dell’epoca attuale. Ci sono senz’altro molte somiglianze fra il critico senza nome che ci racconta lo Stradone e i narratori seriali che l’autore mette in campo ne La vita in tempo di pace, Dove credi di andare e Questa e altre preistorie. Ma questo più che un senso di ripetitività suggerisce un’autenticità irrimediabile del sentire dell’autore, che replica individui simili tra loro come automi, parte costitutiva e rappresentativa di quel “ceto medio esteso” da Pecoraro così ben teorizzato e descritto, colpevole di aver assorbito e annullato, nel corso di un sessantennio, ogni differenza di classe, di pensiero, di caratterizzazione ideologica o culturale, vendendosi al più bieco consumismo.
Il quartiere che Pecoraro sceglie di descrivere è emblematico di tale appiattimento in una sbiadita e squallida uniformità, del fatto che la perdita di consapevolezza e unicità riguardi anche zone cittadine con un passato particolare, a suo modo glorioso, e sacche di umanità speciali, differenti, che un tempo si distinguevano per compattezza morale e fierezza della propria unicità (proletaria). In una digressione storica leggiamo:
Tutto qui era strano e diverso. La sacca non era una vera borgata, non nasceva da emarginazione e povertà, non era stata costruita nella disperazione della mancanza di lavoro: era un brano spontaneo di città operaia, nato vicino alla fabbrica, a causa della fabbrica, con il fine di tenersi il lavoro in fabbrica. […] Così come non era periferia. La sacca non riconosceva la città di Dio come centro, casomai la vedeva come territorio straniero, alieno, non comunista, dominato dai preti.
E anche ora il tessuto sociale borghese delle palazze in cortina che avanzano da est non fa breccia in ciò che rimane del quadrante degli ex fornaciari, nello Stradone appunto, scialbo agglomerato che ha prevalso a partire dall’epoca di edilizia sui piccoli villaggi auto-costruiti dagli operai nel primo Novecento. Ora c’è lo Stradone, abitato da un’umanità terminale e stremata che sopravvive di pensione e cappuccino, si diletta con i gratta e vinci o con le slot machines, guarda stancamente il fondoschiena alle ragazze dell’est che si avvicendano al banco a fare i caffè. Lo Stradone sconta la sua punizione di oblio e squallore, la sua unicità proletaria e industriale, che non ha saputo evolversi né in borgata popolare né in completa riqualificazione borghese e residenziale. Il quadrante con la sua sacca di umanità era funzionale a costruire, ampliare, ammodernare, riqualificare. Ma non ha usufruito di tutto ciò che ha donato al resto della città, rimanendo un agglomerato incoerente di baracche, poi sostituite da palazzoni IACP, contornati da distese di macchia attualmente lasciate all’immondizia, ai senza tetto baraccati, agli animali selvatici.
Pecoraro declina la dialettica tra degrado attuale e memoria a suo modo epica del luogo in modo magistrale. Non vi è trama alcuna nel suo libro se non una serie di inquadrature cinematografiche che danno lo spunto a riflessioni o digressioni soprattutto di natura territoriale, storica e sociale, ma anche di natura personale. Ne deriva un testo destrutturato come il quartiere e l’umanità che si vuole descrivere, un disegno senza margini, un concerto polifonico di fraseggi stonati, cacofonici ma dello stesso tenore, che si inseguono e si rispondono, amplificandosi a vicenda fino a creare qualcosa che non assomiglia a una melodia, ma al suono stesso di certa umana contemporaneità.
L’autore non si eleva assolutamente, né pare volerlo fare, dal livello di desolazione della massa che lo circonda, cui anzi si mescola apposta, fingendo di identificarvisi pienamente, in un gioco al ribasso evidentemente autopunitivo nei confronti del proprio percepito insuccesso umano – culturale – accademico – sentimentale.
E ora a fronte di tutto questo, qui al settimo piano della palazzata sullo Stradone, circondato da una città sostanzialmente di merda — costruita pria da poteri assoluti, poi da non-poteri piccolo-borghesi, con qualche elemento di socialismo—, dove un’intera esistenza di consenziente (la mia) viene ricompensata con una discreta pensione e un accesso privilegiato al servizio sanitario, mi accorgo della piccolezza codarda di una vita spesa esclusivamente in una serie di tentativi —falliti—di affermazione personale, nel tradimento di ogni istanza di cambiamento, anzi di rovesciamento dello status quo, che pure, da giovane, mi aveva infervorato…
Laddove ne La vita in tempo di pace vi erano tratti più volutamente compiuti, un’alternanza ritmata tra brevi lampi narrativi e considerazioni tecniche ai limiti della saggistica, il tutto ancora percepibile come un ordine organizzativo del testo, ne Lo stradone la narrazione assume un assetto anarchico, con digressioni che si innalzano nel flusso dei pensieri senza dover rendere conto di struttura alcuna. Non vi è una linea temporale definita né un approfondimento psicologico dei personaggi, che appaiono come marionette o continue comparse, sfuggenti e a un tempo archetipiche, foriere di messaggi piatti e bidimensionali, funzionali alla concettualità egualmente centrifuga e deflagrante della narrazione.
Si può parlare di lunghi frammenti di prosa, riconducibili alla struttura che hanno spesso i post tematici che appaiono sul web, afferenti a tre modalità espressive: il flash-back autobiografico, la descrizione cinematografica della condizione presente, le argomentazioni di natura architettonico-urbanistica, storica e sociale, che si ricollegano alle prime due voci mediate da qualcosa che somiglia alla nostalgia, alla vergogna e condanna dell’attuale, al rimpianto per ciò che non è stato.
Come non rivedere affiorare nel testo Pasolini, nella miscela tra la crudezza d’indagine antropologica, deplorazione di ogni retorica borghese,affermazione continua di una legittima libertà individuale, benché tormentata da ombre interiori e personali fantasmi. E come non pensare alla letteratura neo-realista, al nichilismo di Céline, al disincanto e allo sguardo sui vinti di Malaparte, fino al razionalismo metodologico Calvino, che esplicitava addirittura i tre piani della narrazione: l’esperienza visiva, che si estrinseca nel testo descrittivo, l’esperienza antropologica che coinvolge simboli e linguaggio e prende forma nel racconto, e infine i momenti di pura speculazione sull’universo, il fluire del tempo, il rapporto con l’individuo, lo sgomento dell’infinito.
La definizione di romanzo risulta stretta a questo testo sovversivo, caotico, che rifugge apparentemente ogni definizione o investitura, ogni retorica funzionale, ogni progettualità concettuale che sia finalizzata a qualcosa di costruttivo, reattivo alla mera osservazione e registrazione dei luoghi e dei fatti. Pecoraro pare dunque non affidare al suo testo alcuna missione, lasciarlo acefalo di propositi e privo di direzione, ma questo non lo priva della caratteristica di essere un capolavoro foriero di un profondo messaggio.
Contrariamente a La vita in tempo di pace che ha una vaga struttura temporale, benché a doppio binario, finendo la vicenda con movimento retrogrado all’infanzia del Dopoguerra e con incedere ortogrado a una morte annunciata, Lo stradone si chiude invece senza punti di arrivo né eventi clamorosi, se non – piccolo avvenimento finale – la costruzione del Centro Commerciale Aura. La voce narrante come uomo colto disprezza e compra a un tempo, nel senso che vitupera la capacità di incidere sul territorio e aggregarsi ormai solo in questo genere di strutture, ma sa anche che ormai l’unica vera compagnia e conforto dell’uomo moderno è rappresentata dalla merce. Dunque il centro commerciale è il nuovo tempio pagano, dove si consuma un fugace appagamento dello spirito.
Tutti erano segretamente contenti che si facesse qualcosa per distaccarsi una volta per tutte dal passato, sia pure costruendo muri in falso tufo, rivestendo edifici in falso travertino…ma con vere scale mobili, e però messe a cazzo
Resta il sorriso amaro dell’uomo di architettura e di lettere che osserva gli eventi in incognito, e partecipa all’inaugurazione con atteggiamento un po’ critico e un po’ no, abbracciando la novità come unica provvisoria illusione, come unica vaga possibilità di riqualificazione, mentre l’interrogativo, non espresso, sul destino della società e dell’uomo stesso rimane tra i denti e incombe come un’ombra, con il peso insostenibile delle cose non dette, delle domande cui – al momento – non sembra esserci risposta.