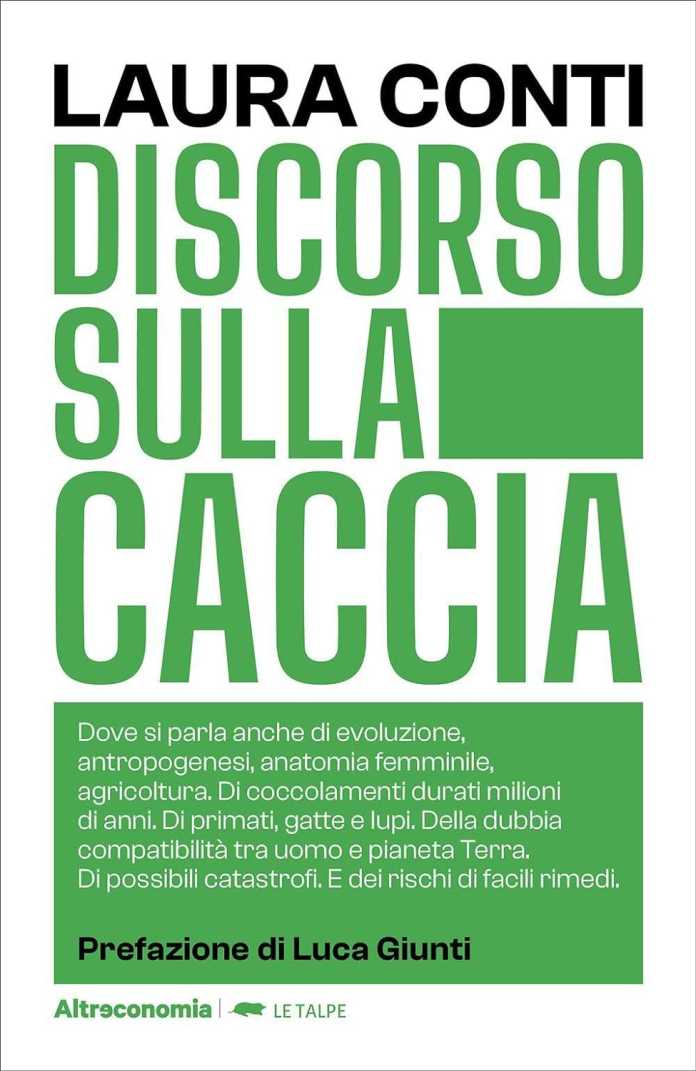Scritti a distanza di oltre trent’anni, due saggi affrontano la crisi ecologica del nostro pianeta. Attraverso due epoche, due generazioni ne parlano da angolature anche retoricamente opposte: il posto che come umani occupiamo nel mondo naturale e quello che lo stesso mondo occupa, a sua volta, dentro di noi. Riflessioni non sovrapponibili né necessariamente componibili, come appunto, quella di una politica anomala per i suoi tempi, Laura Conti – medico, ex partigiana, pioniera dell’ambientalismo italiano, fondatrice di Legambiente, scomparsa nel 1993 – e di una coppia di autori contemporanei, Francesco Boer e Andrea Pilloni. Vale la pena di provare a leggerli in parallelo.
Discorso sulla caccia, ora ristampato da Altreconomia, vede la luce nel 1990, all’indomani della nuova legge sull’attività venatoria (n. 157/92) e del duplice referendum sulla caccia, promosso dalle organizzazioni ambientaliste e dalla Sinistra. Il referendum è fortemente voluto dai Verdi, che pochi giorni prima del voto boicottano anche la discussione parlamentare sulla nuova legge avanzata nel frattempo da PCI, DC, e dagli altri partiti, per evitare le urne. I due quesiti propongono la cancellazione della vecchia legge sulla disciplina della caccia (n. 968/77) e il diritto di accesso dei cacciatori ai fondi privati (art. 842, Cod. Civile). Entrambi i referendum mancano di poco il quorum (43%), assieme a un terzo quesito sull’uso dei pesticidi in agricoltura. Conti, che da ultimo prende le distanze dal referendum sulla caccia, lo considera inutile se non controproducente, e difende a spada tratta la nuova legge n. 157/92 (tuttora in vigore e oggi nuovamente oggetto di una raccolta di firme per la sua abolizione) che, dice, sarebbe subentrata comunque, anche in caso di vittoria.
Sul piano del diritto, l’innovazione introdotta fu notevole: la fauna selvatica divenne “patrimonio indisponibile dello Stato”, ponendo fine al “diritto alla caccia”. Resta la licenza che le autorità regionali, ora responsabili del “patrimonio faunistico”, rilasciano autorizzando un “prelievo” in funzione della sua effettiva gestione. Soprattutto la legge intese legare i cacciatori (al tempo circa 1.300.000, oggi meno della metà e prevalentemente over 60) al proprio territorio, mettendo fine, almeno sulla carta, al turismo venatorio. La posizione al riguardo di Conti anticipa in parte la nascente diatriba tra parlamentarismo e “movimentismo” referendario che attraversa gli anni ’90, ma questo oggi importa meno delle crepe di una legge che, oltre ad aver evidenziato tutti i suoi limiti nella gestione istituzionale del territorio, cade ormai lontanissima dalla sensibilità comune e dal rifiuto generalizzato della caccia.
La parte interessante infatti non è la sua difesa ma la lucidissima premessa che Conti discute dettagliatamente nella prima parte del pamphlet: il problema vero, dice, non è la caccia, storicamente residuale e nell’età moderna subalterna all’attività agricola, che demanda ad essa l’abbattimento degli animali considerati nocivi (uccelli, volpi, ungulati selvatici, ecc.) al di fuori dello sterminio sistematico di insetti e ratti, affidati alla chimica, ma l’agricoltura stessa. In un’epoca in cui la crisi climatica è ancora castamente chiamata “effetto serra” – il primo report IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) è solo di due anni prima – evulsa dall’orizzonte mentale di qualsiasi politico del tempo, si tratta di una premessa visionaria. Conti ricorda come la diffusione del paesaggio agricolo distrugga sistemicamente la biodiversità del territorio e come l’industrializzazione delle filiere e degli allevamenti animali da macello stia operando inesorabilmente da moltiplicatore dei gas serra. Lo fa, da par suo, in modo documentato e meticoloso, da “amica della scienza” che indica ai compagni di PCI e Legambiente, con cui ha appena rotto, la Contraddizione Principale, e forse anche con un pizzico di perfidia nel ricordare ai verdi anti-caccia i milioni di bovini, ovini e polli silenziosamente macellati ogni anno. Dimostrando una statura e un’autonomia intellettuale oggi francamente impensabili per qualsiasi deputato o consigliere regionale, sgancia una bomba con troppe implicazioni – sociali, antropologiche, politiche – perché la mentalità progressista del suo tempo ci possa fare i conti.

Trent’anni e cinque report IPCC dopo, L’ecosistema in noi di Boer e Pilloni ha buon gioco ad insinuarsi tra le crepe che, nel frattempo, le numerose crisi dell’Antropocene hanno scavato nelle società industriali avanzate e nel soggetto-tipo che l’economia del consumo e del profitto ha globalizzato. È con questo soggetto che dopotutto siamo oggi, volenti o nolenti, chiamati a identificarci, magari con riluttanza o riserva mentale. Per ridiscutere il nostro posto nel mondo, il saggio prende infatti le mosse dalla nostra materiale porosità alla presenza non umana: una mosca che penetra l’habitat asettico e climatizzato di un’abitazione mettendo in crisi le fragili infrastrutture che assicurano quotidianamente un illusorio senso di controllo. Può essere una mosca, ma anche un virus o i 40 miliardi di batteri che attribuiamo normalmente al nostro perimetro corporeo e, in pratica, al nostro ego. Siamo invece, come dice il titolo, un ecosistema aperto su altri ecosistemi. Per prenderne atto non serve neppure ritirarsi a vivere in un capanno nel bosco o a studiare “l’internet dei funghi” che collega per chilometri le radici delle piante, anche se magari può aiutare.
L’idea generale è quella di superare la polarizzazione che nel senso comune oppone tuttora natura e cultura, restituendo l’essere umano all’orizzonte biologico a cui appartiene senza per questo negare o minimizzare le sue caratteristiche di specie. Il libro stesso si impone, pagina dopo pagina, con un lessico studiato in funzione di un preciso gioco di corrispondenze e di esclusioni lessicali. Non tutto ciò che è “umano”, secondo gli autori, è ad esempio “artificiale”: lo è un giardino all’inglese, non lo è la pista di un ex aeroporto restituita alla vegetazione “casuale”. Appartiene alla sfera “artificiale” solo la tendenza più autoreferenziale e riduzionistica della nostra cultura che nega a priori le interazioni con la “natura”. Questa a sua volta esiste e non è semplicemente un costrutto, anche se il suo perimetro può variare anche attraverso l’azione antropica. Né, se per questo, la natura “si vendica” per i torti subiti, come nei film ecohorror, quando semmai manifesta la crisi dei suoi ecosistemi nei suoi esiti più devastanti per le nostre civiltà.
L’interdipendenza e l’omeostasi dell’organico – rappresentata nella tradizione immanentistica occidentale dal concetto di “anima mundi” o, più recentemente, non solo in campo scientifico, dall’ipotesi Gaia – non va però rigettata, ma semmai coltivata e rilanciata anche nell’immaginario condiviso dal discorso pubblico. Così gli autori non esitano a usare anche il termine “anima” per avvicinare provocatoriamente alla nostra sensibilità i fenomeni emergenti dalla complessità dall’organico e degli ecosistemi biologici.
Grande assente del libro, invece, il villain tradizionale di qualsiasi trattato ambientalista: inutile cercare infatti la parolina “capitalismo” perché volutamente espunta dal lessico, benché, ovviamente, non si neghi che “nella mentalità che gli è connaturata, il capitalismo è la quintessenza dell’artificialità”. Una scelta meditata, e non di mera comunicazione, ma semmai di coerenza rispetto agli obiettivi e all’impianto – piuttosto diretto e attento anche al lettore “non studiato” – del libro: “Il capitalismo non è il destino terminale dell’umanità: si può e si deve sconfiggerlo, ma per farlo occorre riconoscere che esso è l’espressione di una tendenza degenerativa più profonda”.