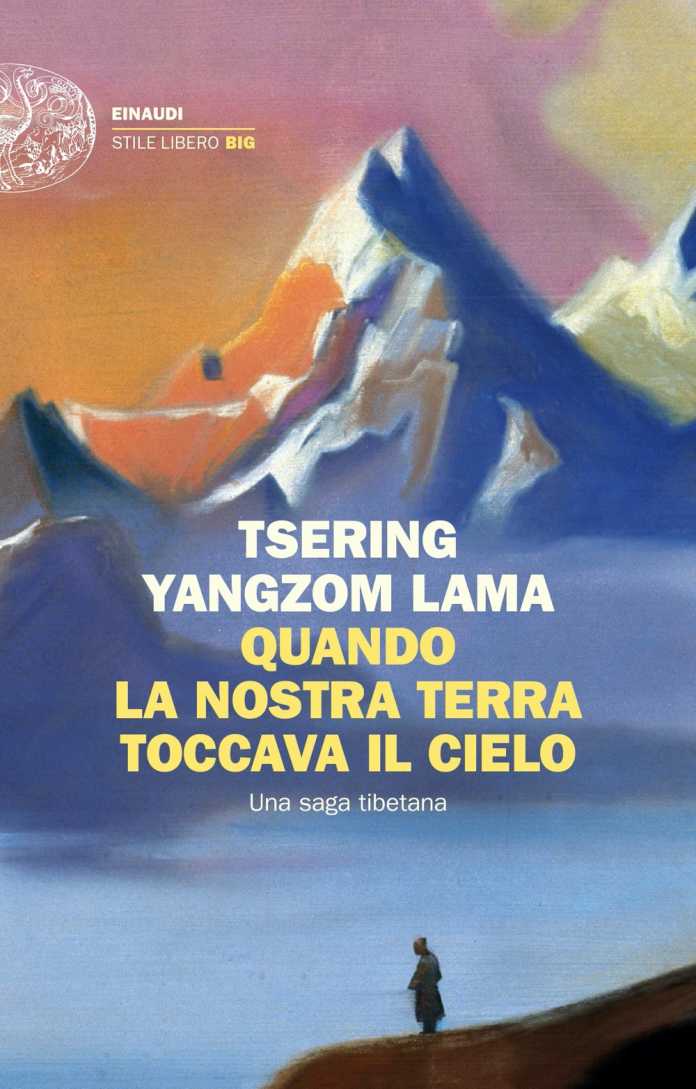Si parla tanto di migrazioni, fin troppo, visto che lo si fa senza cognizione di causa, senza empatia o compassione, spesso con scopi personalistici e politici poco o per niente puliti. Si parla tanto anche di integrazione e accoglienza, fin troppo, visto che lo si fa nello stesso modo. Allora questo romanzo, che di certo non ha ambizioni rivoluzionarie o di denuncia, ci fa pensare a questi temi in modo diverso, personale, anche intimo. Innanzitutto, si capisce che chi non ha provato a essere costretto ad andarsene dalla propria terra, non ha idea di cosa voglia dire. Se toccasse a noi prendere quel che riusciamo del poco o tanto che possediamo, e andare a vivere in un campo profughi, beh, credo che anche noi cercheremmo di ricostruire quello che avevamo e quello che eravamo. Alle volte, quello che eravamo e quello che avevamo sono la stessa cosa. E ogni ricostruzione, per quanto fatta con cura e dedizione, non ci restituisce quanto abbiamo perso.
 Quando la nostra terra toccava il cielo è il racconto di tre donne, due sorelle fuggite dal Tibet invaso dall’esercito cinese, e la figlia di una di loro. Le perdite sono incolmabili: i genitori, molti abitanti del piccolo villaggio in cui sono cresciute, che muoiono durante il viaggio o appena raggiunto il Nepal; le tradizioni, le divinità, una cultura che si era costruita nei secoli in un’interazione con un ambiente unico e particolarissimo. La vita nel campo profughi è triste e difficile, non tanto per le condizioni materiali, che questo popolo è sempre stato poco ricco e molto lavoratore, ma per il fatto di essere un campo profughi, un non-luogo, inizialmente transitorio ma poi via via sempre più definitivo. Ognuno cerca di ricreare la propria casa, il cibo familiare, le relazioni, il culto delle divinità. Chi può cerca di andarsene, immaginarsi e poi mettere in atto una vita nuova. Lo fa con la forza della disperazione invece che con lo slancio dell’avventura. Perché tutti vorrebbero solo tornare indietro, se mai potessero.
Quando la nostra terra toccava il cielo è il racconto di tre donne, due sorelle fuggite dal Tibet invaso dall’esercito cinese, e la figlia di una di loro. Le perdite sono incolmabili: i genitori, molti abitanti del piccolo villaggio in cui sono cresciute, che muoiono durante il viaggio o appena raggiunto il Nepal; le tradizioni, le divinità, una cultura che si era costruita nei secoli in un’interazione con un ambiente unico e particolarissimo. La vita nel campo profughi è triste e difficile, non tanto per le condizioni materiali, che questo popolo è sempre stato poco ricco e molto lavoratore, ma per il fatto di essere un campo profughi, un non-luogo, inizialmente transitorio ma poi via via sempre più definitivo. Ognuno cerca di ricreare la propria casa, il cibo familiare, le relazioni, il culto delle divinità. Chi può cerca di andarsene, immaginarsi e poi mettere in atto una vita nuova. Lo fa con la forza della disperazione invece che con lo slancio dell’avventura. Perché tutti vorrebbero solo tornare indietro, se mai potessero.
Ed è così che il “santo senza nome”, una piccola statua neppure bella, viene ritrovata all’improvviso e sembra generare e alimentare la speranza di riscatto e di ritorno. Poi la statua viene rubata, come se fosse un messaggio di resa. Ma molto fortunosamente viene anche ritrovata, nelle mani di un collezionista, dalla figlia andata a studiare in Canada, e recuperata, anche se in modo non del tutto lecito. Il “santo senza nome” prende un valore simbolico altissimo, incarna la spiritualità profonda del popolo tibetano, che continua a brillare in qualsiasi condizione. Un anelito verso quel cielo che dal Tibet sembra di poter toccare, e che vince sulle difficoltà materiali, sulle perdite e sulle mancanze, sulla nostalgia e sullo struggimento. Tanto che viene da pensare che non sia solo lecito, non solo comprensibile, ma del tutto giusto che i migranti sentano il bisogno di conservare e tramandare le loro tradizioni e la loro cultura. Poi certo, quando le ferite non saranno più insopportabilmente dolorose, quando la forza della vita avrà avuto il sopravvento, quando le nuove generazioni avranno intrapreso il percorso dell’integrazione, allora e solo allora ci sarà una nuova cultura, delle nuove tradizioni, che mescolano le origini e fanno dialogare i punti di vista diversi. Ci vuole del tempo e ci vuole anche di volerlo.
Questo romanzo, che ci assorbe e trasporta lontano, in un mondo tutto da immaginare e a tutt’oggi inaccessibile, ci insegna dunque molto. E lo fa ovviamente senza volerlo, senza averlo deciso sulla carta. Lo fa rispondendo al bisogno di raccontare e di rendere partecipi. Dello spaesamento e della speranza, di quello che è uguale per tutti gli uomini e le donne a tutte le latitudini, dell’amore e del coraggio che a tutti viene richiesto per vivere.
Diceva Gaber, di cui ci stiamo ricordando anche grazie al bel documentario che sta circolando da un paio di mesi: “Libertà è partecipazione”. Anche la lettura è partecipazione. Libera e personale. Con il suo carico emotivo e affettivo, con l’empatia e la compassione (in senso letterale) che forse ci renderà migliori anche nei confronti di quei migranti che al momento facciamo così fatica ad accogliere. Conoscere le loro storie sicuramente ci potrà avvicinare. Per questo è importante che si pubblichino romanzi e racconti da mondi diversi dal nostro, e che tutti noi li si accolga nelle nostre librerie con curiosità, interesse, attenzione. E partecipazione.