È il 25 aprile 1969. Sono le ore 19:03, manca mezz’ora alla chiusura ufficiale della 47esima Fiera Campionaria di Milano alla presenza delle autorità. Al padiglione FIAT, mentre è in corso la proiezione di una serie di diapositive su antichi modelli di automobili, c’è una violenta deflagrazione. Mentre si prestano i primi soccorsi ai numerosi feriti, non gravi, alle 20:40, alla Stazione Centrale, nell’Ufficio Cambi della Banca Nazionale delle Comunicazioni, si susseguono altre tre esplosioni. Molti danni, nessun ferito. Solo poche ore dopo gli inquirenti dell’Ufficio Politico della questura di Milano, diretto da Antonino Allegra, segnalano senza esitazioni la pista anarchica. Nei giorni successivi il commissario Luigi Calabresi procede al fermo e poi all’arresto di alcuni giovani, cani sciolti vicini ai movimenti anarchici. L’inchiesta si conclude con il rinvio a giudizio di otto persone e coinvolgerà, con l’accusa di falsa testimonianza, anche l’editore militante Giangiacomo Feltrinelli. Si apre così un lungo processo nel quale è possibile leggere in filigrana tutte le dinamiche – indagini a senso unico, imputati pre-confezionati, ricorso a infiltrati e falsi testimoni, depistaggi – che torneranno poi nelle drammatiche sequenze della strage di piazza Fontana: come se i fatti di aprile costituissero solo la “prova generale” del disegno eversivo che sarà perfezionato nel dicembre dello stesso anno. Un quadro che emerge in tutta la sua evidenza leggendo Prima di Piazza Fontana. La prova generale edito da Laterza, opera del giornalista trentino Paolo Morando, già autore di alcuni originali saggi che scandagliano la storia recente del paese. Una ricostruzione documentata e serissima di un episodio rimasto quasi in ombra nella pur ricchissima pubblicistica sulla strategia della tensione.
Prima di Piazza Fontana. La prova generale ricostruisce nel dettaglio gli eventi dell’aprile 1969, retrodatando di diversi mesi, dunque, rispetto a Piazza Fontana il grave vulnus della democrazia registrato al tempo nel nostro Paese. Perché questa storia non era stata mai raccontata – non in forma così esaustiva – pur essendo strettamente collegata a quello che accadrà dopo il 12 dicembre e cosa aggiunge alle vicende già note?
Per più ragioni. Primo, perché dal punto di vista giudiziario è stata risolta da tempo: è infatti del 1982 la sentenza di Cassazione che conferma la condanna di Franco Freda e Giovanni Ventura per gli attentati del 25 aprile, per quelli sui treni di agosto e per diversi altri. Secondo, perché da allora l’attenzione si è concentrata sulla strage del 12 dicembre: dal punto di vista della giustizia e, viste le sentenze insoddisfacenti, da quello storico e giornalistico. Terzo, perché tutto ciò che è avvenuto da allora in poi ha ovviamente travolto il resto: appunto la strage, la manovra contro gli anarchici, la morte di Pinelli, una vicenda giudiziaria infinita. Dopo di che, oggi continuo a chiedermi quello che mi chiedevo mentre scrivevo il libro: come è possibile che in cinquant’anni anni nessuno si sia accorto della rilevanza di questa storia? La vicenda del 25 aprile, io credo, aggiunge infatti un tassello importante all’infinita questione di Piazza Fontana. Anzi, illumina un quadro più ampio: in particolare, i modi e i tempi della macchinazione antianarchica, che non nasce all’indomani della strage, ma che era stata già avviata. E che anzi, per attecchire nell’opinione pubblica prima ancora che a livello investigativo, aveva bisogno proprio di un contesto già messo a punto.
L’Ufficio Affari Riservati di Federico Umberto D’Amato (ovvero i servizi segreti interni), con il suo uso spregiudicato delle fonti confidenziali e dei testimoni, appare sulla scena con mesi di anticipo rispetto la presenza, di recente documentata, all’interno dell’Ufficio Politico della questura di Milano nei giorni immediatamente successivi al 12 dicembre. Come e quando è iniziata l’operazione che attraverso i treni e la Fiera di Milano condurrà poi a piazza Fontana?
Formalmente inizia poche ore dopo il secondo attentato del 25 aprile, perché la bomba alla Stazione centrale esplode alle 20:40 e il primo rapporto della polizia, firmato dal capo dell’Ufficio politico della Questura di Milano, Antonino Allegra, è datato ancora 25 aprile. Quindi siamo a prima di mezzanotte. Nella sostanza, però, inizia molto prima. Sono numerosi gli elementi che documentano come l’attività dei giovani anarchici poi incriminati fosse da tempo sotto osservazione, anche attraverso l’utilizzo di infiltrati. In più però, nel mio libro, documento come l’intera operazione sia iniziata molto prima, addirittura nel 1968, quando ad agosto e a dicembre alla Rinascente di Milano vennero rinvenute inesplose due bombe che vennero attribuite agli anarchici. E proprio quelle due bombe, nel primo rapporto di Allegra, vengono messe in connessione con quelle del 25 aprile. Ma una serie di circostanze fin qui mai analizzate, e a cui dedico un intero capitolo, suggerisce che i mancati attentati alla Rinascente fossero di tutt’altra mano: nel migliore dei casi una classica operazione “di seconda linea”, come le chiamava Freda, nel peggiore una manovra ordita proprio dagli Affari Riservati.
Nel libro si parla del “Documento Greco”, apparso sulla stampa estera pochissimi giorni prima della strage di piazza Fontana. Che cosa conteneva questo rapporto e quale funzione doveva avere?
Si tratta di una presunta informativa di un agente segreto greco, di stanza in Italia, al capo della giunta militare di Atene, il colonnello Georgios Papadopoulos, e da questi girato all’ambasciatore greco in Italia Dimitrios Pampuras, con lettera accompagnatoria datata 15 maggio 1969 e firmata dal direttore del ministero degli Esteri Michail Kottakis. Tutto questo arriva nelle mani di un giornalista inglese, Leslie Finer, in formato microfilm, da una fonte coperta appartenente all’ambiente della resistenza moderata al regime dei colonnelli. Il documento è lungo e ricchissimo di elementi impossibili da sintetizzare, ma in sostanza tratteggia un disegno di golpe militare sull’esempio greco da attuare anche in Italia. In più, nella seconda parte intitolata “Azione specifica”, si legge questo: “Le azioni che erano previste per un’epoca anteriore non hanno potuto essere realizzate che il 25 di aprile. La modifica dei nostri piani è stata necessaria perché si è presentata difficoltà per quanto riguarda l’accesso al padiglione della Fiat. Le due azioni hanno avuto un notevole effetto”. Si tratta quindi delle bombe del 25 aprile. La Corte d’assise di Catanzaro, nel primo processo per Piazza Fontana, concluderà che il rapporto è un falso, realizzato probabilmente dai servizi segreti britannici, ma un ottimo falso, perché mescola circostanze effettivamente riscontrabili ad allusioni con più di un fondamento, nel tipico stile dei servizi segreti. Se così fosse, l’obiettivo attraverso la sua pubblicazione era far sapere in Italia che oltre Manica la situazione era seguita, e che non era il caso di esagerare. Comunque sia, tale documento sarà oggetto di un dibattimento giudiziario ben prima del processo di Catanzaro: avviene infatti proprio in quelle per le bombe del 25 aprile, quando Finer viene chiamato a testimoniare.
Nel novembre 1962 la sentenza del processo ai giovani anarchici milanesi che avevano sequestrato a Milano il viceconsole spagnolo Isu Elias riconosceva l’alto valore morale dell’atto condannando gli imputati a pene che andavano dai 20 giorni ai 7 mesi di reclusione. Sette anni dopo gli anarchici diventano belve sanguinarie a cui addebitare propositi stragisti. Cosa è successo in questi sette anni?
Intanto va detto che quel sequestro non fu in alcun modo cruento: fu un’azione dimostrativa unica e irripetibile, che duro pochissimi giorni, messa in atto da un gruppo di giovani senza alcun apparato organizzativo eversivo alle spalle, con l’obiettivo di mobilitare l’attenzione pubblica contro il regime franchista e le condanne a morte che aveva emesso nei confronti di alcuni giovani anarchici. Cosa diversa erano le azioni dei mesi tra il 1968 e il 1969, numerose, con attentati che restavano dimostrativi, dunque senza la possibilità di ferire nessuno e con obiettivi politici precisi e rivendicazioni puntuali, ma sempre di esplosioni si trattava. Questa pratica consolidata, diciamo così, che comunque non era dell’intero movimento anarchico ma di una sua sola parte, forniva un capro espiatorio perfetto a cui addossare la responsabilità di azioni dimostrative che non erano tali: appunto bombe in luoghi pubblici non rivendicate, pensate apposta per seminare il terrore ovunque nella popolazione. Ma più in generale, in quei sette anni, era il quadro politico a essere cambiato, e con esso la società italiana: i governi del centrosinistra, la contestazione giovanile, le lotte operaie… Qualcuno a un certo punto deve aver pensato che era il caso di metterci un freno.
Che profilo avevano gli imputati del processo per le bombe alla Fiera di Milano e che percorsi hanno poi fatto? Sembrano come svaniti nel nulla, la loro voce finora non era stata mai ascoltata…
 È così. Nessuno finora aveva mai dato loro voce: lo faccio nell’ultima sezione del libro, con lunghe interviste. In tutti questi anni quei giovani non sono rimasti ai margini del discorso pubblico, non ne hanno proprio mai fatto parte. Il solo Paolo Braschi, negli ultimi anni di vita, ha avuto occasione di riparlare di quella vecchia storia che lo aveva coinvolto, ma in incontri un po’ “underground”, in ambienti anarchici. Paolo Faccioli è da anni apicoltore, anche scrivendone in libri e riviste di settore, e solo lo scorso anno ha pubblicato una autobiografia per un piccolo editore, in cui però la vicenda del 25 aprile è citata come uno tra i tenti elementi della propria vita. Angelo Della Savia vive appartatissimo in Lunigiana, quasi da eremita. Tito Pulsinelli si è da tempo trasferito in Venezuela, pur conservando un profilo militante come commentatore della politica sudamericana, soprattutto in Internet, con taglio “bolivariano”. Giuseppe Norscia è scomparso nel 2006, in Olanda. Mentre la sua compagna di allora, Clara Mazzanti, solo qualche mese fa ha pubblicato un libro bellissimo fin dal titolo, Venga con noi (Colibrì, 2019), in cui racconta la sua odissea giudiziaria. Ne ho curato la prefazione e lo consiglio a tutti. Ecco, il suo caso è quello che rappresenta al meglio la parabola di questi giovani, in qualche modo triturati dalla grande storia e poi gettati al di fuori della grande narrazione pubblica. Con conseguenze personali, in alcuni casi, pesantissime.
È così. Nessuno finora aveva mai dato loro voce: lo faccio nell’ultima sezione del libro, con lunghe interviste. In tutti questi anni quei giovani non sono rimasti ai margini del discorso pubblico, non ne hanno proprio mai fatto parte. Il solo Paolo Braschi, negli ultimi anni di vita, ha avuto occasione di riparlare di quella vecchia storia che lo aveva coinvolto, ma in incontri un po’ “underground”, in ambienti anarchici. Paolo Faccioli è da anni apicoltore, anche scrivendone in libri e riviste di settore, e solo lo scorso anno ha pubblicato una autobiografia per un piccolo editore, in cui però la vicenda del 25 aprile è citata come uno tra i tenti elementi della propria vita. Angelo Della Savia vive appartatissimo in Lunigiana, quasi da eremita. Tito Pulsinelli si è da tempo trasferito in Venezuela, pur conservando un profilo militante come commentatore della politica sudamericana, soprattutto in Internet, con taglio “bolivariano”. Giuseppe Norscia è scomparso nel 2006, in Olanda. Mentre la sua compagna di allora, Clara Mazzanti, solo qualche mese fa ha pubblicato un libro bellissimo fin dal titolo, Venga con noi (Colibrì, 2019), in cui racconta la sua odissea giudiziaria. Ne ho curato la prefazione e lo consiglio a tutti. Ecco, il suo caso è quello che rappresenta al meglio la parabola di questi giovani, in qualche modo triturati dalla grande storia e poi gettati al di fuori della grande narrazione pubblica. Con conseguenze personali, in alcuni casi, pesantissime.
Negli atti del processo ricorrono allusioni alla sessualità degli imputati, sempre rappresentata come promiscua o “contronatura”, come se lo stigma di una sessualità non conforme alla morale del tempo si dovesse inevitabilmente sovrapporre con la “devianza” nella pratica politica e viceversa. Cosa ci racconta questa ossessione per il sesso nelle aule giudiziarie italiane del tempo?
Più che nelle aule giudiziarie, direi nei verbali di polizia e nelle sentenze istruttorie. A dibattimento, un giovane pubblico ministero come Antonino Scopelliti e avvocati di grande valore come Giuliano Spazzali fecero piazza pulita di queste, come chiamarle?… propensioni della macchina repressiva. Però sì, il clima era quello. Ne è testimonianza un tragico fatto di cronaca che proprio negli stessi mesi ebbe un’incredibile risonanza: l’uccisione di Ermanno Lavorini e l’incredibile affresco, soprattutto mediatico, della pineta di Viareggio e dei suoi frequentatori. In un clima del genere, suggerire rapporti omosessuali tra i giovani anarchici era mettere altra carne sul fuoco della loro “mostrificazione”, e uso questo termine non a caso, pensando a Pietro Valpreda e naturalmente al film “Sbatti il mostro in prima pagina”, per il quale il regista Marco Bellocchio si ispirò anche alla vicenda delle bombe del 25 aprile.
Fino al film di Marco Tullio Giordana Romanzo di una strage del 2012 il cinema italiano non aveva mai affrontato direttamente Piazza Fontana. Ma la ricostruzione offerta sembra procedere ricorrendo all’equilibrismo ed evocando, per esempio, la discutibile teoria della “doppia bomba”. Più in genere si rileva un approccio cauto e “moderato”. Qual è il nodo oscuro che, anche oggi a distanza di tanti anni, non si può ancora sciogliere pubblicamente?
Il nodo oscuro è evidente: la mano di uomini dello Stato dietro a quella della manovalanza neofascista. È questo il punto su cui non si è mai riusciti a fare piena luce, anche se gli elementi accumulatisi soprattutto negli ultimi anni sono incontrovertibili. Poi, se vogliamo, l’eredità pesante di altre vicende stratificatesi sopra alla strage. E mi riferisco al delitto Calabresi. Nel film di Giordana, le due figure di Giuseppe Pinelli e del commissario Luigi Calabresi sono in qualche modo allineate l’una con l’altra, ognuno con il proprio ruolo (anarchico uno, poliziotto l’altro), entrambi alla fine vittime. Ed è così, entrambi lo sono ed è un punto che non va mai dimenticato. Ma le loro morti, con le rispettive dinamiche e i rispettivi esiti giudiziari, non possono essere accomunate. E non credo che ci sia bisogno di spiegarne il perché. Nelle indagini sulle bombe del 25 aprile, e su tutti i diciotto attentati che vennero attribuiti ai giovani anarchici, l’operato dell’Ufficio politico della Questura di Milano e del commissario Calabresi fu tutt’altro che limpido, e lo si scoprì clamorosamente solo due anni dopo a dibattimento, gettando ulteriori ombre sulla morte di Pinelli. Calabresi compare però personalmente nell’inchiesta, e mi riferisco alla sua presenza durante gli interrogatori dei giovani fermati stando ai verbali, a partire dal pomeriggio di lunedì 28 aprile. Ma già dalla sera del 25 il suo capo Allegra aveva indirizzato tutto verso gli anarchici. Calabresi è dunque un funzionario che riceve un’indicazione da un superiore, che esegue con zelo, anche troppo secondo gli imputati, ma non è il “motore” della macchinazione. Che muove invece da un livello superiore.
“Mezzo secolo dopo credo che finalmente si possa essere liberi di ricordare questi due uomini senza più contrapporli” scrive in un post Mario Calabresi il 15 dicembre scorso, ricordando suo padre Luigi e Giuseppe Pinelli. Il livellamento simbolico operato nel tempo tra due vicende e due storie personali legate tra loro ma molto diverse, appare funzionale anche a un livellamento sul piano storico. Un episodio in un progetto di rimozione del conflitto in atto già da tempo. Quali sono secondo lei gli esiti di questo progetto di rimozione del conflitto oggi in Italia e quali gli antidoti?
L’esito mi sembra palmare: l’annegare vicende complicatissime che hanno segnato la storia del Paese, oltre che tante storie personali in maniera tragica, in un unico grande calderone indistinto. Con il risultato, per esempio, di far sì che una quindicina d’anni fa la maggioranza di un campione di studenti milanesi delle scuole superiori, in un sondaggio sulla loro conoscenza di Piazza Fontana, rispose attribuendo la strage alle Brigate Rosse, con al secondo posto la mafia e con gli anarchici al terzo, addirittura davanti ai fascisti. L’antidoto è uno solo: coltivare la memoria. Anche attraverso i libri. Sulla reale efficacia dell’antidoto, e penso alle cronache quotidiane, per esempio recenti ricerche sul giudizio che gli italiani hanno di Mussolini e del fascismo, sulla loro conoscenza della Shoah, ho purtroppo dubbi sempre maggiori. Ma è uno sforzo che va comunque fatto.
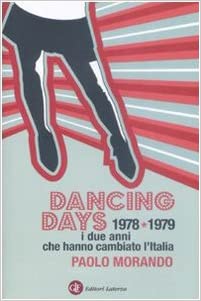 Nella recentissima fiction Io ricordo, Piazza Fontana, trasmessa in prima serata su Rai 1, si raccontano, pur facendo ricorso agli usuali espedienti emotivi, alcune delle responsabilità accertate e delle reticenze che hanno accompagnato l’inchiesta, dai servizi segreti al neofascismo fino allo Stato. Resta invece ancora sfumato il ruolo della polizia che quasi appare incorsa in un errore giudiziario piuttosto che parte attiva, nei limiti delle sue funzioni, di un piano di più ampio respiro politico. Il processo per le bombe alla Fiera di Milano da lei documentato sembra raccontare una storia molto diversa.
Nella recentissima fiction Io ricordo, Piazza Fontana, trasmessa in prima serata su Rai 1, si raccontano, pur facendo ricorso agli usuali espedienti emotivi, alcune delle responsabilità accertate e delle reticenze che hanno accompagnato l’inchiesta, dai servizi segreti al neofascismo fino allo Stato. Resta invece ancora sfumato il ruolo della polizia che quasi appare incorsa in un errore giudiziario piuttosto che parte attiva, nei limiti delle sue funzioni, di un piano di più ampio respiro politico. Il processo per le bombe alla Fiera di Milano da lei documentato sembra raccontare una storia molto diversa.
Sì. Ed è una storia che non si capisce fino in fondo se prima non si mette un punto fermo, relativo alla gerarchia in cui allora operavano gli Uffici politici, che non rispondevano al questore, bensì direttamente all’Ufficio Affari Riservati del Ministero degli Interni. Allegra, per essere chiari, era un terminale milanese di D’Amato e Russomanno, non era un “dipendente” dei vari Parlato e Guida, i questori che si succedettero a Milano in quel 1969. Questo è un punto fondamentale, peraltro certificato inequivocabilmente dalla ricerca di Gabriele Fuga ed Enrico Maltini sulla morte di Pinelli: tra il 12 e il 16 dicembre, in questura a Milano, comandavano gli Affari riservati, non il questore. Quindi gli ipotetici errori giudiziari della polizia sono da addebitare a chi muoveva i fili, gli Affari Riservati. E dunque parlare di errori giudiziari è del tutto improprio. D’altra parte l’ostinazione appunto degli Affari Riservati nell’imbastire e sostenere la pista anarchica a partire dal 25 aprile e fino a Piazza Fontana, al di là del buon senso e arrivando al punto di costruire false prove, come, per esempio, l’incredibile vicenda dei vetrini nella borsa della bomba inesplosa alla Banca Commerciale, ci indica tutto fuorché la buona fede. E non cito l’interminabile sequela delle prove nascoste o sottratte alla magistratura, perché non finiremmo più.
 Il nuovo libro integra il lavoro sulla memoria paese da lei intrapreso con Dancing Days (Laterza, 2009) e proseguito con ’80. L’inizio della barbarie (Laterza, 2016). È una modalità di ricerca originale che riempie i vuoti, rintraccia connessioni più o meno sotterranee o apparentemente marginali all’interno della storia recente del paese, connessioni che illuminano sui percorsi mai casuali attraverso i quali si arriva agli scenari attuali. Il problema italiano della memoria sembra aggravarsi con il tempo lasciando fluire inesattezze e bugie, omettendo, aggiustando… dal suo punto di vista lo ritiene l’effetto di una patologia culturale o di una gestione “politica” della memoria attraverso il lucido controllo della comunicazione e dell’intrattenimento?
Il nuovo libro integra il lavoro sulla memoria paese da lei intrapreso con Dancing Days (Laterza, 2009) e proseguito con ’80. L’inizio della barbarie (Laterza, 2016). È una modalità di ricerca originale che riempie i vuoti, rintraccia connessioni più o meno sotterranee o apparentemente marginali all’interno della storia recente del paese, connessioni che illuminano sui percorsi mai casuali attraverso i quali si arriva agli scenari attuali. Il problema italiano della memoria sembra aggravarsi con il tempo lasciando fluire inesattezze e bugie, omettendo, aggiustando… dal suo punto di vista lo ritiene l’effetto di una patologia culturale o di una gestione “politica” della memoria attraverso il lucido controllo della comunicazione e dell’intrattenimento?
Non saprei dire se si tratta di esiti effettivamente perseguiti come tali o se si tratta di eterogenesi dei fini. Il risultato però è quello che ho già detto, cioè nel migliore dei casi l’annacquamento, e gli strumenti sono appunto quelli, le omissioni e gli aggiustamenti. Patologia culturale o lucido disegno? E nel secondo caso, da parte di chi? I “poteri forti”, il “grande vecchio”? Anche i vecchi a un certo punto muoiono, quindi bisognerebbe presupporre quanto meno una staffetta dichiarata, ovviamente occulta. È una tesi affascinante, che ci porterebbe molto lontano. Se vogliamo, potremmo farla partire da Portella della Ginestra, passando per la morte di Enrico Mattei e altre che con quest’ultima sono state messe in connessione, per arrivare alla P2 e a chi davvero la creò, fino a giungere a Silvio Berlusconi, quindi appunto alla sfera che fonde irrimediabilmente in sé la comunicazione e l’intrattenimento, una sfera in cui l’informazione è appunto annacquata. E poi eccoci ai giorni nostri della disintermediazione, dell’uno vale uno, dell’agorà dei social che tutto livella. Ma siamo in Italia, non dimentichiamolo. Siamo un popolo che sa essere cinico e furbo, ma siamo anche un popolo di grandissimi cialtroni. Ipotizzare l’esistenza di un “grande vecchio” appaga la sete di senso, e pensando a tutto quello che è accaduto e accade in questo sciagurato Paese ce n’è un gran bisogno, ma può anche essere altamente deresponsabilizzante. Detto questo, l’unica cosa da fare è aprire bene gli occhi e guardarsi attorno: anche i “grandi vecchi”, specie se italiani, quindi anche loro un po’ cialtroni, qualche traccia la lasciano sempre.



