Prendo in mano l’ultima traduzione dell’Ulysses, di Mario Biondi per La nave di Teseo. Pesa. È un blocco di più di mille pagine. Scoraggiante, per chi ha in mente di accostarsi alla lettura, già oppresso da quell’”effetto intimidatorio dei classici” di cui parlava Bertolt Brecht. Però, quando lo apro, si sfoglia bene, nonostante la massa, è morbido e ha un buon odore. Più o meno ha le stesse pagine della traduzione canonica di Giulio De Angelis (1960), mentre quella di Enrico Terrinoni (2012) ne conta quasi duecento in meno, è di formato meno imponente, più maneggevole, ma i caratteri sono più piccoli. E ha le note in fondo al libro, senza numeri nel testo, così non è facile consultarle, devo andare un po’ a tentoni, in base al numero di pagina. Questa ha le note a piè di pagina, di solito non sono neanche troppo corpose, rallentano la lettura, ma non la interrompono, dopo aver letto la nota sotto non è troppo complicato riprendere il filo della lettura; e con qualcosa in più. Andare a cercarle in fondo al libro comporta una vera e propria interruzione, per cui va a finire che non le leggo, o non tutte.
Vedo che da quella di De Angelis, riproposta nel 2018, e di Bona Flecchia (1995, praticamente introvabile), ci sono tre traduzioni in meno di dieci anni: Terrinoni (2012), Gianni Celati (2013), Biondi (2020). Forse sarà da chiedersi come mai.
Intanto, se, come dice Enrico Terrinoni, nella sua traduzione, rispetto a quella “storica di De Angelis, il numero delle parolacce è raddoppiato”, in questa trovo raddoppiato il raddoppio. Laddove Biondi usa un registro parlato, il tono è decisamente basso, e anche con qualche coloritura dialettale. Provo a fare qualche raffronto:
Janey Mack, I’m choked. (Oxford World’s Classics, p. 11)
Cazzarola, soffoco! (Biondi, p. 38)
Porca Eva, qua non respiro! (Celati, p. 17)
Gesummio, soffoco. (Terrinoni, p. 41)
Mondo cane, soffoco. (De Angelis, p. 20)
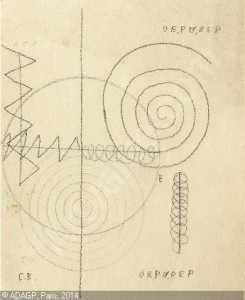
Il termine “cazzarola” è di origine romanesca, anche se è diventato di uso comune. Nel contesto blasfemo del primo capitolo la rasatura di Mulligan è rappresentata, già nelle primissime parole, come imitazione della messa cattolica, (“una ciotola di schiuma da barba su cui erano posati in forma di croce uno specchio e un rasoio.”, p. 25): in questo caso la forma scelta da Terrinoni – “Gesummio” – più neutra, meno incisiva, forse si adatta meglio, perché lascia emergere quanto l’espressione irlandese ‘Janey Mack’ non vorrebbe che apparisse, ossia il nome sacro invocato invano. E una pagina dopo compare: “Capperi, siora”, che percepisco come inflessione veneta. Ancora, nel capitolo 8, p. 257, la parola “sfruculia” evoca immediatamente la parlata partenopea. Capitolo 13, p. 565: “Qualche fettone domani mattina lo calpesta”; “fettone” per flatfoot, “piedipiatti”, come traducono tutti gli altri, è di uso meridionale per indicare un piede grosso.
Questa tonalità della traduzione rimane abbastanza costante e caratterizza buona parte della lingua dei personaggi e ambienti popolari. Il problema non è ovviamente il tasso di ‘volgarità’, o se si vuole, di colloquialità. Si tratta invece delle questioni poste dalla coppia che Lawrence Venuti chiama “domestication” / “foreignization” (“domesticazione” / “straniazione”, forse più congruente “stranierazione”), e rinvia alle scelte strategiche operanti in ogni traduzione. Di fronte a un testo in lingua straniera posso seguire due linee essenziali: cercare di rendere il testo conforme ai canoni della lingua e della cultura di destinazione, eventualmente con deviazioni dalle norme linguistiche che possono anche comportare la perdita di informazioni e riferimenti alla lingua e alla cultura di partenza. O invece puntare a una pratica di resistenza rispetto alle convenzioni dominanti in un dato momento, privilegiando la conservazione e perfino l’esaltazione dell’alterità del testo straniero, eventualmente a rischio di cadere nella difficoltà di lettura o nell’incomprensibilità. Ed è bene rimarcare che la scelta ha sempre e comunque una connotazione politica: assimilazione o riconoscimento dell’Altro.
Mi pare che Biondi propenda per una forma di domesticazione, con l’uso di registri facilmente percepibili da un comune parlante-lettore italiano. Prende di petto il labirinto linguistico dell’Ulisse e cerca di renderlo più appropriabile, più “democratico” (ancora Terrinoni), aderente a un’idea della lingua italiana – e della realtà italiana – meno omogenea e ricomposta. Mettere in tensione anche le sfumature regionali con lo standard ufficiale dovrebbe essere un modo per cercare di rendere il conflitto tra le particolarità dell’anglo-irlandese e dello slang gaelico da un lato, e lo standard inglese simbolo e pratica di dominio dall’altro. Che è un aspetto fondamentale della lingua di Joyce, ciò che ne fa una lingua politicamente “minore” nel senso deleuziano, non una lingua minoritaria, un dialetto recuperato, ma “una minorazione della lingua maggiore, un delirio che porta via, una lingua stregata che fugge dal sistema dominante”.
 Mai, per nessuno come per Joyce, è vero quanto afferma Marcel Proust: “I bei libri sono scritti come in una lingua straniera. Sotto ogni parola ciascuno mette il suo senso o, per lo meno, la propria immagine, che è spesso un controsenso”. Vero, palpabile e imbarazzante, fonte di insonni tormenti per chi traduce, ma anche apertura di uno spazio di libertà, da quando – da qualche decennio almeno – si è fatta giustizia dell’obbligo di “invisibilità” del traduttore (Lawrence Venuti).
Mai, per nessuno come per Joyce, è vero quanto afferma Marcel Proust: “I bei libri sono scritti come in una lingua straniera. Sotto ogni parola ciascuno mette il suo senso o, per lo meno, la propria immagine, che è spesso un controsenso”. Vero, palpabile e imbarazzante, fonte di insonni tormenti per chi traduce, ma anche apertura di uno spazio di libertà, da quando – da qualche decennio almeno – si è fatta giustizia dell’obbligo di “invisibilità” del traduttore (Lawrence Venuti).
Tuttavia, in questo caso il risultato lascia un po’ perplessi: lo scarto tra registro basso, con qualche inflessione dialettale, e standard italiano, e la tensione tra anglo-irlandese e inglese appaiono difficilmente comparabili sullo stesso piano. Si avverte un sapore vagamente “vernacolare”, che rischia di mettere in ombra proprio il carattere di vera e propria lotta dell’anglo-irlandese di Joyce contro la dominazione storico-politica dell’inglese. Tanto più che le varianti irlandesi – come per esempio la soppressione del pronome relativo in funzione di soggetto della frase – non sono riattivabili e percepibili in italiano:
Here’s this nobleman [who] passed before. (Oxford World’s Classics, p. 358)
Ecco qui il nobile personaggio che è passato prima. (Biondi, p. 556)
Ecco quel signore distinto passato prima. (Celati, p. 515)
Ecco il nobiluomo ch’è passato prima. (Terrinoni, p. 371)
Ecco quel nobile che è passato dianzi. (De Angelis, p. 507)
A proprio agio mi pare la lingua di Biondi quando è alle prese con la composizione sonora delle allitterazioni – seppur in parte diverse nelle due lingue – e il flusso di senso, risolti senza perdere la struttura e il ritmo della frase:
Groangrousegurgling Toft’s cumbersome whirligig turns slowly the room right roundabout the room. (Oxford World’s Classics p. 537)
Gembrontgorgogliando la goffa giostra Toft fa girare lentamente la stanza su se stessa. (Biondi, p. 795)
La giostra di Toft, mastodontico carosello, lamento-ruglioso-gorgogliante, gira a destra tutta la stanza lentamente intorno alla stanza che gira. (Celati, p. 724)
La pesante giostra di Toft fa girar lentamente la stanza proprio intorno alla stanza (Terrinoni, p. 557)
La giostra Toft pesante e gracchiorugliogorgogliante, gira lentamente la stanza torno torno alla stanza. (De Angelis, p. 751)
Ed è così più o meno in tutto il capitolo 15, sotto il segno di Circe, in cui domina la magia notturna del sogno nelle contorsioni della “transluding” – neologismo che combina “translation”/traduzione e la radice di “ludic”/giocoso o “ludicrous”/comico, creato dallo stesso Joyce in Finnegans Wake.
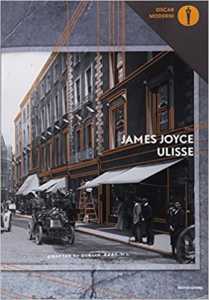 Questa dimensione di gioco è costantemente presente in Ulisse, e coinvolge non solo la scrittura, ma anche la lettura. Traduttore e lettore sono entrambi coinvolti nelle provocazioni di una continua “esitazione del significato in un perpetuo ‘più tardi’”, come dice Stephen Heath. Un esempio banale. Siamo verso la fine del capitolo 13, Nausicaa. Tutto il capitolo è costruito su una serie di monologhi di una donna, Gerty Mac Dowell, e di Bloom, sulla spiaggia di Sandymount. Le catene di pensieri offrono prospettive diverse sulla realtà e mettono in discussione qualunque visione univoca: come nelle buche, “Non si sa mai cosa si trova”. Bloom a questo punto scrive per Gerty un messaggio sulla sabbia:
Questa dimensione di gioco è costantemente presente in Ulisse, e coinvolge non solo la scrittura, ma anche la lettura. Traduttore e lettore sono entrambi coinvolti nelle provocazioni di una continua “esitazione del significato in un perpetuo ‘più tardi’”, come dice Stephen Heath. Un esempio banale. Siamo verso la fine del capitolo 13, Nausicaa. Tutto il capitolo è costruito su una serie di monologhi di una donna, Gerty Mac Dowell, e di Bloom, sulla spiaggia di Sandymount. Le catene di pensieri offrono prospettive diverse sulla realtà e mettono in discussione qualunque visione univoca: come nelle buche, “Non si sa mai cosa si trova”. Bloom a questo punto scrive per Gerty un messaggio sulla sabbia:
- A. (Oxford World’s Classics, p. 364)
SONO. UN. (Biondi, p. 565)
SONO. UN. (Celati, p. 524)
- A. (Terrinoni, p. 377)
SONO. UN. A. (De Angelis, p. 516)
Le interpretazioni-traduzioni sono le più disparate: per Terrinoni potrebbe anche essere “I a ma”, “Io una ma”, dove ma starebbe per “mamma” e la volontà di essere madre di Bloom, che più avanti (Terrinoni, p. 481) partorisce in sogno otto bambini. Per Biondi invece è un semplice e letterale “Io sono un …”, indeterminato. Sotto questo aspetto, Ulysses non è solo un testo, ma anche, per Declan Kiberd, un metodo di “ addestramento alla sua decodifica”.
Infine, l’ineludibile dormiveglia di Marion-Molly Bloom. Qui mi soffermo solo su un curioso problema di traduzione: il rapporto tra lingua scritta e lingua parlata, anzi pensata:
and Gibraltar as a girl […] yes and how he kissed me under the Moorish wall and I thought well as well him as another and then I asked him with my eyes to ask again yes (Oxford World’s Classics, p. 732)
e Gibilterra da ragazza […] sì e come mi ha baciato lui sotto le mura moresche così ho pensato oh bè va bene lui come un altro e poi gli ho fatto segno con gli occhi di chiedermelo di nuovo sì (Biondi, p. 1067)
e Gibilterra quando ero ragazza […] e lui mi ha baciata sotto il muro moresco io pensavo be’ va bene lui come un altro poi gli chiedo con gli occhi di chiedermi ancora sì (Celati, p. 988)
e Gibilterra da ragazza […] sì e come mà baciato sotto le mura moresche e ò pensato bè lui o un altro che cambia e poi gliò chiesto con gli occhi di chiederlo ancora sì (Terrinoni, p. 741)
e Gibilterra da ragazza […] sì e come mi baciò sotto il muro moresco e io pensavo be’ lui vale un altro e poi gli chiesi con gli occhi di chiedere ancora sì (De Angelis, p. 1025)
 Il flusso di pensieri dovrebbe essere libero da convenzioni grafiche. In questo caso Biondi è più normalizzatore e si attiene alla scrittura convenzionale, come De Angelis e Celati. La scelta di Terrinoni appare più coerente con la “popolarità” del linguaggio di Molly, per sua stessa ammissione, più “defamiliarizzante” e audace. Non fino in fondo: come Joyce, lascia le lettere maiuscole per i nomi di persone e di luoghi. Non mi pare che si pensi con le maiuscole.
Il flusso di pensieri dovrebbe essere libero da convenzioni grafiche. In questo caso Biondi è più normalizzatore e si attiene alla scrittura convenzionale, come De Angelis e Celati. La scelta di Terrinoni appare più coerente con la “popolarità” del linguaggio di Molly, per sua stessa ammissione, più “defamiliarizzante” e audace. Non fino in fondo: come Joyce, lascia le lettere maiuscole per i nomi di persone e di luoghi. Non mi pare che si pensi con le maiuscole.
Ma insomma, alla fin fine, che dire di quest’altra traduzione? In termini rudimentali, se ne sentiva la necessità, Ulisse ha qualcosa da dire anche nel nuovo millennio, riesce a schivare «l’assoluta inefficacia di un classico» – espressione con cui Max Frisch, per ironia della sorte, liquidava lo stesso Brecht?[1] Senza entrare nel dettaglio, non sarà un caso che uno dei poeti alla ricerca di nuovi percorsi, come Kenneth Goldsmith, decida di seguirlo, registrando e pubblicando i pensieri di tutta una giornata, il 16 giugno, lo stesso giorno di Bloom e Molly. E di assumere la copia come emblema della poesia di oggi.
“Chaosmos of Alle”: è l’espressione coniata in Finnegans Wake, combinazione e alternanza, sempre provvisoria, di caos e cosmos, di mescolanza e ordine, per rappresentare la pluralità di voci, di lingue, di registri, di prospettive, di intersezioni, di interferenze, che fanno parlare di una totale assenza di stile in Joyce. Semmai vi opera una pratica che Heath definisce “plagiarismo”, in cui non si esprime il soggetto stabile di uno stile, ma un soggetto disperso in una molteplicità di stili, di ordini di discorso, “aperti a tutto un campo di forme culturali, letteralmente rubate e rotte in una frammentazione continua della scrittura.” Un esempio canonico, tra gli altri, è il capitolo 14, Oxen of the Sun, in cui Joyce copia parodisticamente le lingue della tradizione letteraria inglese, puntualmente indicate dal traduttore nelle note a piè di pagina. Tutta l’opera di Joyce potrebbe essere definita in questa discontinuità che non si distende in una linea di sviluppo, ma piuttosto in una spirale, un alternarsi continuo di “ritorno e distacco, di disseminazione, in cui ogni testo reinscrive gli altri in modo da attingere a una distanza di parodia, derisione, aneddoto.” Il testo non è più, se mai lo è stato, l’origine e la sorgente primaria da cui emanano i pensieri, le emozioni dell’autore e il suo rapporto con la realtà, ma è uno spazio intertestuale in cui si stabilisce anche l’equivalenza tra scrittura e lettura. Come il soggetto che scrive, anche chi legge, e chi parla, è disperso in una pluralità di possibili posizioni e funzioni, in un’attività di assemblaggio continuo, continuamente attraversato da discorsi ed enunciati di cui nessuno può dirsi proprietario esclusivo. Accade ogni giorno nella fantasmagoria del mondo “politopico, polifonico planetario”, in cui viviamo, come sostiene Haroldo de Campos, “sotto il segno divoratore della traduzione latu senso”.
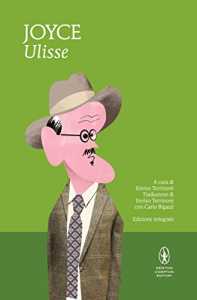 E che dire della nuova traduzione? È migliore delle altre o no? Domanda a cui, messa così, nessun traduttore si sentirebbe di rispondere, e infatti non risponde mai nessuno in modo altrettanto categorico.
E che dire della nuova traduzione? È migliore delle altre o no? Domanda a cui, messa così, nessun traduttore si sentirebbe di rispondere, e infatti non risponde mai nessuno in modo altrettanto categorico.
Tra le due alternative – avvicinamento/assimilazione dell’Altro o distanziamento/riconoscimento – è sempre possibile una infinita gradazione, che corrisponde poi alla natura stessa della traduzione. Senza per questo apparire salomonicamente ignavi e relativisti, tocca concordare con Terrinoni sul fatto che ogni traduzione aggiunge qualcosa. La sua carica culturalmente e politicamente significativa dipende poi dal momento, dai contesti, dalle contraddizioni che determinano le ragioni stesse della traduzione e il rapporto tra i due procedimenti fondamentali.
Questa traduzione perciò va letta, non fosse altro che come pretesto per ri/giocare Joyce con il nuovo interprete. E tenendo a mente la smagliante definizione di Augusto de Campos, anch’egli poeta, e traduttore, e fratello di Haroldo: nella “traduzione creativa” o “transcreazione”- “transluding” – la relazione tra il traduttore e il testo originale è quella che si sviluppa tra “l’esecutore di un brano musicale e lo spartito del compositore, a favore della massima libertà dell’interpretazione musicale”. La stessa che si sviluppa tra testo tradotto e lettore.

[1] Cit. in C. Cases, Introduzione, in B. Brecht, Me-ti Libro delle svolte, Giulio Einaudi editore s.p.a, Torino 1970, p. XL-XLI.



