In occasione della pubblicazione dell’ultimo romanzo di Erickson, Shadowbahn, edito dal Saggiatore (che verrà recensito oggi pomeriggio), riproponiamo oggi uno speciale sullo scrittore americano uscito sul numero 84 di PULP Libri (marzo-aprile 2010, pp. 12-19).
A rischio di cadere nel banale voglio partire da una constatazione che forse avete già sentito fare: l’America è la terra dei sogni. Se questo è vero, e penso proprio che lo sia, Steve Erickson (che quest’anno va per la sessantina) è uno degli scrittori più americani che abbia mai letto.
Si potrebbe spiegare così come mai l’opera di questo curioso romanziere e critico cinematografico abbia stentato a raggiungerci. Tutto pareva essere partito bene quando il primissimo romanzo di Erickson, uscito negli Stati Uniti nel 1985, era stato tradotto da Pironti (piccola casa editrice pionieristica, per quel che riguarda gli americani, come poche altre) solo cinque anni dopo col titolo Momenti perduti. Poi, mentre lo scrittore losangelino pubblicava altri cinque romanzi (vedasi la bibliografia ragionata), da noi c’era una lunga pausa, finché nel 1999 Fanucci, allora nella sua stagione più illuminata, traduceva Arc d’X (sei anni dopo la sua uscita in America); quello stesso anno Frassinelli pubblicava Il mare arriva a mezzanotte, quasi in simultanea con l’uscita negli Stati Uniti. Pareva giunto il momento della scoperta di Erickson; però così non fu. Ancora nove anni dovevano passare prima che Bompiani pubblicasse Zeroville (uscito in America nel 2007).
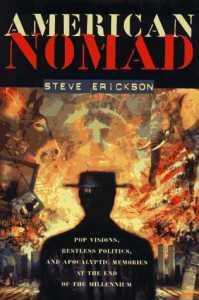 Siamo così a un totale di quattro romanzi tradotti (dei quali due da lunga pezza fuori stampa) contro otto scritti dall’autore; a questi vanno aggiunte due raccolte di saggi di qualità considerevole, Leap Year e American Nomad, inedite in Italia; e dire che la seconda la si trova citata un po’ dappertutto dall’altra parte dell’Atlantico. Aggiungiamo il fatto che Erickson è stato “rimpallato” tra quattro editori diversi, e capiremo di essere alle prese con un autore che ancora non ha stabilito un contatto saldo e stabile con il nostro pubblico.
Siamo così a un totale di quattro romanzi tradotti (dei quali due da lunga pezza fuori stampa) contro otto scritti dall’autore; a questi vanno aggiunte due raccolte di saggi di qualità considerevole, Leap Year e American Nomad, inedite in Italia; e dire che la seconda la si trova citata un po’ dappertutto dall’altra parte dell’Atlantico. Aggiungiamo il fatto che Erickson è stato “rimpallato” tra quattro editori diversi, e capiremo di essere alle prese con un autore che ancora non ha stabilito un contatto saldo e stabile con il nostro pubblico.
E questo, per tornare al discorso iniziale, forse a causa dell’essere un romanziere talmente americano che stentiamo a entrarci dentro. Non sempre, infatti, gli scrittori di un altro paese riescono a far breccia nel nostro immaginario. A certi è riuscito in modo sorprendente: Philip K. Dick, o Jack Kerouac, o Ernest Hemingway, tanto per restare nella letteratura a stelle e strisce. Eppure ci sono autori amatissimi negli Stati Uniti che da noi non hanno mai sfondato veramente: Nathanael West, tanto per fare un nome, o Robert Penn Warren, o più recentemente Rober Coover. E altri che sono magari citati (spesso a sproposito) ma poco e niente letti, come Thomas Pynchon e William Gaddis. Infine ci sono quelli che di là sono romanzieri rampanti, in odore di Pulitzer, come Jonathan Lethem o William T. Vollmann, mentre da noi sono stati finora relegati allo status di autori di nicchia. Questo è inevitabile; non tutta la letteratura è esportabile. Fuori dall’Italia Italo Calvino ha fatto furore (in America grazie anche a un grandissimo traduttore, William Weaver), mentre di Carlo Emilio Gadda non si è accorto nessuno; se Umberto Eco è diventato una celebrità (più come romanziere che come semiologo), di Mario Luzi (del quale, finché era in vita, si faceva sempre stancamente il nome in tempo di premi Nobel) non si può certo dire la stessa cosa.
Eppure Erickson meriterebbe più considerazione, e questo speciale che gli dedichiamo ha la precisa e spudorata intenzione di promuovere l’autore di Arx d’X e Zeroville presso i lettori del Bel Paese. E chissà, se si convincono i lettori qualche volta gli editori si rassegnano ad adeguarsi (certi miei colleghi critici, invece, non si arrendono mai all’evidenza, ma questa è un’altra storia).
Sogni, si diceva. Tra questi spicca certo il sogno americano, e scusate quest’altra banalità. Sarebbe l’idea che dall’altra parte dell’Atlantico tutto sia possibile: diventare famosi, ricchi, potenti. Il figlio di un immigrato africano che diventa presidente; i discendenti di irlandesi morti di fame che diventano la famiglia più influente del paese (i Kennedy, beninteso, non i Bush); gli schiavi che si emancipano; i reietti di tutto il pianeta che si sistemano. Cosa dice ai paesi europei (e non) la stessa Statua della Libertà in un sonetto a lei dedicato? “Datemi le vostre masse stanche, povere, accalcate, che bramano di respirare liberamente, i disgraziati rifiuti delle vostre spiagge brulicanti. Mandatemi questi, i senza casa, gettati a me dalle tempeste, io levo la mia lampada accanto alla porta d’oro!” Il sogno americano, come dicono loro, come archetipica storia from rags to riches, dagli stracci alla ricchezza. L’America (tutta quanta, non solo quel grosso pezzo che chiamiamo Stati Uniti) come Eldorado.
Sempre che ci vogliamo credere. Ovviamente noi italiani cinici e disincantati non manderemmo mai giù l’amo; non ci fregano, con questa vecchia storia (fa eccezione un certo Veltroni, non so se ve lo ricordate…). Ma che il sogno americano sia una leggenda, un mito, un sogno nel senso onirico del termine l’avevano capito anche gli americani più avvertiti. Già Il grande Gatsby di Fitzgerald (che ormai ha i suoi begli ottantaquattro anni, ma si difende ancora bene) era una demolizione nostalgica ma lucida di quella favola bella.
Però Fitzgerald (e ancor prima di lui Melville, a saper leggere tra le righe del Moby Dick) aveva capito che l’America, più che un paese di sogno, è un paese che ama sognare, e soprattutto sognarsi; una nazione sempre ben disposta, tra l’altro, a comprare un sogno particolarmente attraente, anche perché è un paese di piazzisti, come il Willy Loman di Arthur Miller. I sogni li hanno materializzati due fratelli francesi, i Lumière, ma dell’arte di produrre i sogni gli americani se ne sono impadroniti subito, ci hanno investito bei capitali, e hanno costruito un’intera città, complice il clima secco e soleggiato, funzionale alla produzione industriale di sogni da esportare in tutto il pianeta. Stiamo ovviamente parlando di Hollywood e dell’industria cinematografica coi suoi vari annessi. E stiamo parlando di Erickson, che alla sua attività di romanziere accoppia quella, sicuramente più redditizia, di critico cinematografico, esattamente come il suo alter ego, il protagonista del romanzo Amnesiascope (1996), da molti ritenuta una sorta di autobiografia onirica.
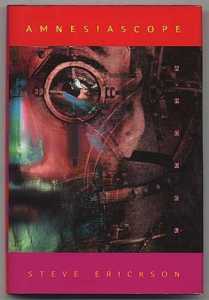 Nel romanzo una Los Angeles di un futuro prossimo, sconquassata da un terremoto di quelli seri, funestata da incendi interminabili, è la scena della realizzazione di un cortometraggio erotico d’avanguardia la cui regista, Viv, è anche la compagna (assai disinvolta in materia di sessualità) del protagonista e io narrante. Il film è un sogno, abbiamo detto; in questo caso, un sogno nel sogno, un sogno al quadrato (come lo è in una pellicola decisamente Ericksoniana, Mulholland Drive di David Lynch); Los Angeles è città dei sogni di chi va a cercarvi successo e fama, e dei sogni che vi vengono prodotti. Ma questa metropoli onirica gioca strani scherzi: quando il protagonista si azzarda a recensire un film immaginario, La morte di Marat, girato da un regista inesistente, Aldolphe Sarre, lo fa per lanciare una provocazione, una specie di suicidio del critico; è come se gridasse all’intera città che i cinefili si parlano addosso, che i loro sproloqui sono talmente avulsi dai film che fingono solo di recensire, da poter addirittura sproloquiare su un film inesistente. Il sogno di un film, per l’appunto. Ma a Los Angeles i sogni hanno una loro perversa solidità; il protagonista di Amnesiascope scopre infatti, non senza un certo orrore, che tutti attorno a lui parlano del capolavoro di Sarre come se esistesse veramente; alla fine il critico viene invitato a un festival dove La morte di Marat, appositamente restaurato, verrà proiettato nella sua interezza.
Nel romanzo una Los Angeles di un futuro prossimo, sconquassata da un terremoto di quelli seri, funestata da incendi interminabili, è la scena della realizzazione di un cortometraggio erotico d’avanguardia la cui regista, Viv, è anche la compagna (assai disinvolta in materia di sessualità) del protagonista e io narrante. Il film è un sogno, abbiamo detto; in questo caso, un sogno nel sogno, un sogno al quadrato (come lo è in una pellicola decisamente Ericksoniana, Mulholland Drive di David Lynch); Los Angeles è città dei sogni di chi va a cercarvi successo e fama, e dei sogni che vi vengono prodotti. Ma questa metropoli onirica gioca strani scherzi: quando il protagonista si azzarda a recensire un film immaginario, La morte di Marat, girato da un regista inesistente, Aldolphe Sarre, lo fa per lanciare una provocazione, una specie di suicidio del critico; è come se gridasse all’intera città che i cinefili si parlano addosso, che i loro sproloqui sono talmente avulsi dai film che fingono solo di recensire, da poter addirittura sproloquiare su un film inesistente. Il sogno di un film, per l’appunto. Ma a Los Angeles i sogni hanno una loro perversa solidità; il protagonista di Amnesiascope scopre infatti, non senza un certo orrore, che tutti attorno a lui parlano del capolavoro di Sarre come se esistesse veramente; alla fine il critico viene invitato a un festival dove La morte di Marat, appositamente restaurato, verrà proiettato nella sua interezza.
La morte di Marat non è comunque un semplice paradosso di sapore borgesiano: nel primo romanzo di Erickson, Momenti perduti, viene raccontata la realizzazione del film, diretto da un regista geniale ma ossessionato, realizzazione che si trasforma in una sorta di patto col diavolo nella misura in cui Adolphe viene finanziato da Jean-Thomas, figlio del proprietario del bordello privato dove Adolphe è cresciuto, con la precisa condizione che al completamento della pellicola Sarre dovrà cedere a Jean-Thomas la sua amante Jeanine (che tra l’altro, tanto per rendere la situazione un po’ più torbida di quanto già non sia, è anche la sorellastra di Jean-Thomas). La realizzazione di La morte di Marat è un’epopea cinematografia, un sogno assolutamente coinvolgente, e in quanto sogno è fatto della materia stessa del cinema, l’arte che Erickson ha coltivato per buona parte della sua vita.
In ogni caso tocchiamo qui con mano una delle caratteristiche salienti della narrativa di Erickson: per metterla nei termini di Musil, le stesse cose tornano. Adolphe Sarre è uno dei personaggi di Momenti perduti, ma il suo film riappare in Amnesiascope. E sempre in Momenti perduti incontriamo, come personaggio secondario, un drammaturgo americano che vive in Francia, tale Carl; quest’ultimo sarà uno dei protagonisti di Il mare arriva a mezzanotte, e intreccerà una torbida relazione erotica di asservimento con Kristin, una ragazza senza famiglia che non è capace di sognare. Gli stessi personaggi tornano da un romanzo all’altro, e spesso tornano gli stessi film, e sicuramente gli stessi luoghi: Parigi e Los Angeles, con la prima immaginata in diverse epoche storiche (scenario della Rivoluzione francese in Arc d’X, culla del cinema all’inizio del Novecento in Momenti perduti, scrollata dalle convulsioni del Sessantotto in Il mare arriva a mezzanotte, metropoli disastrata ancora in Momenti perduti), mentre la seconda incarna il presente senza passato (si dice in Amnesiascope che è inutile studiarne la storia), la mecca dei sogni postmoderna (in Zeroville ma anche in Amnesiascope), una città più sognata che esistente (in linea con la Los Angeles filmata/immaginata da un altro surrealista americano, David Lynch; e così la evoca Erickson in Momenti perduti e Il mare arriva a mezzanotte), ballardiana area del disastro (in tutti i romanzi del nostro Los Angeles è sconquassata e trasformata fino ad essere irriconoscibile da tempeste di sabbia, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni). Infine la metropoli californiana è anche un futuro sgradevole se non angosciante, diventa l’Aeonopolis di Arc d’X, imprigionata da uno stato di polizia al servizio di un governo teocratico.
I romanzi di Erickson, insomma, sembrano tanti capitoli di un unico mega-romanzo. Una specie di Commedia umana di un Balzac redivivo, che è passato per la controcultura degli anni Sessanta e il punk degli anni Settanta e i teatri mediatici dagli Ottanta ad oggi. Del resto, se in Arc d’X due personaggi della Rivoluzione americana, Thomas Jefferson e la sua schiava-amante Sally Hemings, ricompaiono in un futuro dalle tinte orwelliane, ma nella versione allucinata di un Philip K. Dick, non sarà poi tanto strano che in Erickson si reincarni Balzac. Sicuramente questo scrittore molto americano, anzi molto californiano, la Francia la conosce veramente bene; un po’ per via della sua attività di critico cinematografico che ha sicuramente esplorato la grande tradizione filmica d’oltralpe (e del resto il suo regista immaginario, Sarre, non è una versione anamorfica del vero regista francese Abel Gance, autore del capolavoro incompiuto e maledetto Napoleon?); un po’ perché la Francia è la patria di quel surrealismo che in letteratura ha funzionato meglio in inglese (vedi James G. Ballard, sicuramente uno dei maestri di Erickson; vedi il nostro, che viene definito surrealista – tutto sommato giustamente – nella voce a lui dedicata sulla Wikipedia in inglese). La geografia mentale di questo scrittore è tutta ricompresa tra Parigi (il passato) e Los Angeles (il presente e il futuro); ma siccome Erickson è uno scrittore tutt’altro che scontato, la relazione tra queste due capitali psicogeografiche è tutt’altro che semplice, e ognuna delle due sembra aver bisogno dell’altra (per cui il geniale regista francese Sarre, in Momenti perduti, viene legittimato dal grande cineasta statunitense D.W. Griffiths; e l’altrettanto geniale montatore-regista Vikar, in Zeroville, viene legittimato dal successo tributatogli a Cannes).
C’è chi dice che gli scrittori americani sanno parlare solo dell’America, che sono autistici o solipsistici. Veramente? A me invece sembra che quegli scrittori americani che guardano all’Europa (Richard Powers, William T. Vollmann, Erickson, e soprattutto sua maestà Thomas Pynchon) rivolgano al nostro vecchio continente uno sguardo assai più lucido e consapevole, pur nella sua visuale obliqua, dei nostri scrittori che vonno fa’ l’americani. Mi sbaglierò, ma temo che l’Europa sbaragliata e sconclusionata di Momenti perduti renda un po’ meglio l’idea di come vanno le cose su questa sponda dell’Atlantico di quanto riescano a farlo certe omelie europeiste di casa nostra (non meno inutili dell’anti-europeismo al governo). Erickson brutalmente ci dice che il muro di Berlino ci manca, perché ci conteneva; da un lato limitava la libertà di chi stava da una parte di esso (e probabilmente anche la libertà di noialtri al di qua del muro), dall’altro ci diceva quali erano i confini dell’Europa, e ci semplificava la vita. Da quando è caduto il muro non c’è più chiara demarcazione, e l’Europa brancola nel buio, indecisa se essere semplicemente un business, o se perseguire qualche Ideale (ma quale ideale potrà accontentare tutti? E fin dove portarlo? Al Volga? A Istanbul? Al Caucaso? Agli Urali?). Non solo: il muro era immagine cementata di ingiustizia e asservimento, ma anche uno schermo sul quale proiettare i nostri sogni di liberazione. Una volta scomparso, non sappiamo più immaginarci una libertà, perché l’asservimento del mercato globale è invisibile, è una microfisica del potere che non si lascia rappresentare né leggere (e ringraziamo Michel Foucault che aveva capito tutto). Guarda un po’ quanti grattacapi di noi europei vengono a galla a furia di leggere i romanzi di questo barbaro americano, peggio che peggio californiano.
Altro tema importante di Erickson, strettamente connesso con la sua ansiosa interrogazione della libertà è quello delle donne. Cantavano un tempo i Doors le donne di Los Angeles, in una delle loro canzoni meno apprezzate: e proprio queste donne ci presenta il nostro in Amnesiascope, che è mezzo romanzo e mezzo autobiografia anamorfica, una visione d’amnesia di una città che prevalentemente non ricorda o non vuole ricordare (L.A., per l’appunto), una città dove le figure più intense e più tragiche sono le donne. Questa, se permettete, è la grande tradizione californiana, che inizia con le dark ladies di Chandler e del cinema/romanzo noir. E continua con le figure femminili minacciose e aggressive di un altro grande californiano, Philip K. Dick, passando poi per le eroine femminili complesse ed enigmatiche di David Lynch. In Erickson le donne di Los Angeles sono attrici, spesso, cineaste, ogni tanto, mogli, amanti, figlie, ma sono tutte persone solide, in carne ed ossa, e questo colpisce non poco in un mondo decisamente surreale come quello del nostro. Potrà essere un mondo alternativo, il loro, un luogo immaginario e impossibile, dove tempeste di sabbia paralizzano la città degli angeli, o dove dalla faglia di Sant’Andrea scaturisce un vulcano sterminatore, ma le passioni, i sentimenti, gli strazi e le gioie delle donne di Erickson sono più vere del vero, e sono sempre scavate ed esplorate con una sincerità che mette in imbarazzo; anche perché il nostro ha una incredibile capacità (direi quasi masochistica) di mostrare in quali situazioni abiette gli uomini riescono a cacciarsi nella loro smania di possedere (in tutti i sensi) le loro compagne. Pochi scrittori riescono a ritrarre in modo assolutamente convincente, come fa Erickson, pur negli scenari più strani, le tante piccole e grandi carognate che noi uomini perpetriamo ai danni delle nostre donne; forse perché siamo tutto sommato dominati dai nostri sogni (di dominio, come quello dell’Occupante in Il mare arriva a mezzanotte; o quello di Jefferson in Arc d’X), i quali sono spesso sogni erotici.
E qui arriviamo a un altro grande filone della narrativa del nostro. Il sesso. Ce n’è tanto, e a differenza di altri autori statunitensi, descritto senza esitazioni e fin nei dettagli. In questo Erickson ha un piglio più da francese che da cittadino di quell’America che vede tra i Padri fondatori tanti – forse un po’ troppi – puritani. Nei suoi romanzi le scene di sesso ci sono, non vengono saltate, e spesso sono momenti cruciali, nel bene e nel male, delle trame. Erickson fissa il suo sguardo sugli infiniti legami che connettono i nostri desideri con le nostre relazioni affettive, o che oppongono desiderio e affetto; perché, come insegna il rapporto tra l’adultero campione del ciclismo Jason e sua moglie Lauren in Momenti perduti, proprio nella sessualità si tocca con mano fino a che punto amore e libertà siano in un dissidio forse inconciliabile, ma al tempo stesso si richiedano e si intreccino indissolubilmente. C’è anche il sesso ostentato e commercializzato, come nei film che in Il mare arriva a mezzanotte vengono girati dai due pornografi Louise e Mitch; e, cosa che non troverete mai in un film porno, la consapevolezza che il sesso lascia un’eredità lunga e incancellabile, i tanti figli e figlie che popolano i romanzi di Erickson. Un tempo da noi ci si stupiva di queste famiglie americane scombinate con genitori divorziati e risposati e con figli del primo e secondo e terzo matrimonio che dovevano trovare il modo di interagire tra mille difficoltà; ora che qui da noi divorziano anche i politici dichiaratamente cattolici (figurarsi la gente normale), le intricate relazioni e le famiglie monogenitoriali dovrebbero stupire assai di meno. E spesso il fardello dei personaggi di Erickson è di dover crescere senza famiglia, come il trovatello Adolphe Sarre, come Kristin ne Il mare arriva a mezzanotte, che è scappata presto di casa; o di doversi liberare da una famiglia che è una prigionia, come nel caso di Vikar in Zeroville, il cui padre predica il sacrificio dei figli, abnorme replica del mancato sacrificio di Abramo.
Non vengo a raccontarvi che Erickson è un autore per tutti. O lo ami o lo odi. Si tratta di un narratore talmente originale, talmente eccentrico, talmente sui generis che sicuramente non tutti i lettori si troveranno a casa nelle sue storie aggrovigliate, annodate, labirintiche. Aggiungiamo che si trova in quella strana area che Mark Amerika e Larry McCaffery hanno chiamato Avantpop, e che da noi trovò spazio nella collana della Fanucci curata anni fa da Mattia Carratello e Luca Briasco: guarda caso proprio lì venne pubblicato Arc d’X, come già si diceva. Avantpop è, a dirla breve, ibridazione tra immaginario massmediale e sperimentazioni letterarie. Sicuramente entrambe queste cose le ritroviamo nei romanzi di Erickson, col cinema a dar corpo all’immaginario massmediatico (già in Momenti perduti, ma l’apoteosi viene raggiunto con l’orgia cinefila di Zeroville), e l’evocazione di un mondo surrealistico a fare la parte della sperimentazione. Ma non c’è solo il sogno vero o artefatto a dare ai romanzi di Erickson una piega tutta loro e spesso disorientante per il lettore. C’è una prosa complessa e poetica, altrettanto ossessiva del tornare di personaggi e luoghi; c’è il gioco intricato e perverso di tempi e spazi e diversi piani di realtà (e lì il nostro è discepolo del grande virtuoso dell’incertezza ontologica, Philip K. Dick); ma c’è soprattutto la perturbante e proterva abitudine di Erickson di spezzare le sue narrazioni, di appassionarci a un personaggio e alle sue vicende e di buttarlo via quando ci abbiamo preso gusto e prendere a parlare di tutt’altro posto e tutt’altra gente (pratica che già gli viene naturale nell’opera prima, e che viene portata all’esasperazione in Arc d’X). Universi paralleli, diversi momenti nel tempo surrealisticamente comunicanti tramite porte e varchi impensati, analessi e prolessi senza pietà, trasformazioni stranianti di luoghi che crediamo di riconoscere, metamorfosi degli stessi personaggi (le più sconcertanti in Arc d’X). Ma Erickson ce l’ha detto chiaro, per bocca del protagonista di Zeroville, capace di montare le sequenze dei film nei modi più spiazzanti e sorprendenti. Ha un motto, Vikar il montatore, un motto assai semplice: “Fuck continuity”. Interessa assai poco, a lui e al suo creatore (che forse in Vikar ha creato l’ennesimo autoritratto), la continuità di una trama, di una vita, della storia, del mondo. “Affanculo la continuità!” è il programma di questo scrittore al tempo stesso quintessenzialmente californiano eppure stranamente cosmopolita (proprio come Hollywood). Un programma solo in apparenza semplice, in realtà altrettanto complesso delle trame spezzate e discontinue che quel principio (di montaggio, senz’altro) genera in questi romanzi destrutturati.
Ultima notazione: anche se da noi Erickson non è tanto conosciuto, e se in America non è certo considerato nella schiera dei massimi (tra l’altro alcuni dei suoi romanzi sono fuori stampa sia da noi che negli Stati Uniti…), a suo onore va il fatto innegabile di essere letto e apprezzato da diversi suoi colleghi: e parliamo di gente come David Foster Wallace, Richard Powers, William Gibson, Paul Auster, Jonathan Lethem e Ryu Murakami. Soprattutto viene tenuto sotto osservazione da uno dei pesi massimi, e cioè Thomas Pynchon (fors’anche perché hanno l’agente letterario in comune, e si tratta della signora Pynchon). L’onirica Venezia dai canali prosciugati che incontriamo in Momenti perduti, uscito nel lontano 1985, precorre sicuramente la Venezia iperletteraria, ma anche anarco-futurista che Pynchon ci ha rivelato nella sua penultima fatica, Contro il giorno. Non si sarà fatto tantissimi lettori, Steve Erickson, ma se ti leggono gli altri scrittori – e che scrittori – credo proprio che si possa andare molto ma molto lontano.
Quattro schede per quattro romanzi
Momenti perduti, Pironti, 1990, tr. Marilinda Machina Grifeo
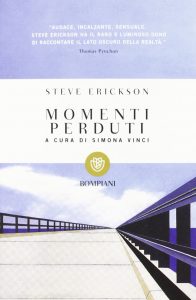 Ogni autore ha i suoi esordi, e si può ben credere a chi dice che nel romanzo di esordio si trovano già tutti i temi e le passioni che uno scrittore svilupperà nel seguito della sua carriera. Così è per Erickson: in questo romanzo troviamo il cinema, con la storia del capolavoro perduto del muto, La morte di Marat, girato negli anni ’20 dal regista “maledetto” Adolphe Sarre (evidentemente modellato dallo scrittore sulla figura storica di Abel Gance). Troviamo la California trasfigurata in chiave surrealistica da una serie di devastanti tempeste di sabbia che desertificano la metropoli (occhio a Ballard!); incontriamo personaggi dalle vite intricate e ossessionate, come il cinefilo Michel, il ciclista Jason, patologicamente infedele alla moglie Lauren, quest’ultima proveniente dal Kansas come la Dorothy del Mago di Oz (ma assai meno innocente). E poi una Parigi immiserita e disastrata, dove nevica e manca la corrente, e uno strano viaggio in barca, una Venezia dai canali prosciugati, e intrecciata alla realizzazione del capolavoro di Sarre la storia morbosa e scandalosa della sua vita di ragazzo cresciuto in un bordello privato (non a Via Gradoli, beninteso) e poi approdato al cinema sulla spinta di una visione al limite della mania.
Ogni autore ha i suoi esordi, e si può ben credere a chi dice che nel romanzo di esordio si trovano già tutti i temi e le passioni che uno scrittore svilupperà nel seguito della sua carriera. Così è per Erickson: in questo romanzo troviamo il cinema, con la storia del capolavoro perduto del muto, La morte di Marat, girato negli anni ’20 dal regista “maledetto” Adolphe Sarre (evidentemente modellato dallo scrittore sulla figura storica di Abel Gance). Troviamo la California trasfigurata in chiave surrealistica da una serie di devastanti tempeste di sabbia che desertificano la metropoli (occhio a Ballard!); incontriamo personaggi dalle vite intricate e ossessionate, come il cinefilo Michel, il ciclista Jason, patologicamente infedele alla moglie Lauren, quest’ultima proveniente dal Kansas come la Dorothy del Mago di Oz (ma assai meno innocente). E poi una Parigi immiserita e disastrata, dove nevica e manca la corrente, e uno strano viaggio in barca, una Venezia dai canali prosciugati, e intrecciata alla realizzazione del capolavoro di Sarre la storia morbosa e scandalosa della sua vita di ragazzo cresciuto in un bordello privato (non a Via Gradoli, beninteso) e poi approdato al cinema sulla spinta di una visione al limite della mania.
Le grandi ossessioni di Erickson ci sono già tutte: il surrealismo onirico, il cinema, la sessualità, la Francia, la California e Los Angeles in particolare, il disastro, la rivoluzione; intrecciata a tutte queste cose una storia d’amore, un rapporto triangolare tormentato, morboso, spesso torrido – che è anche la storia di una famiglia discretamente scombinata… forse non sarà il miglior parto della musa sognante del nostro autore, eppure a pagine incerte se ne alternano di memorabili, che fanno già intuire un talento considerevole. Magari non è la prima cosa da leggere di Erickson, ma se vi piacciono quelle successive, non ve la perdete.
Il mare arriva a mezzanotte, Frassinelli 1999, tr. Alfredo Colitto
 Romanzo dalla struttura avvolgente e avvincente, comincia con la storia di Kristin, una ragazza scappata di casa non si sa perché, che dopo essere scampata al suicidio di massa di una setta religiosa che crede nell’apocalisse di fine millennio, finisce con l’incontrare un uomo che si fa chiamare l’Occupante, grazie a un annuncio su un quotidiano. Tra i due si stabilisce un rapporto di dominazione: la ragazza soggiace alle voglie dell’Occupante, che in cambio la ospita nella sua villa a Los Angeles. Sembra che sia Kristin la schiava e l’uomo il padrone, ma il rapporto tra i due si complica gradualmente, e giunge il momento in cui, nella migliore tradizione hegeliana, si ha un rovesciamento. A questo punto l’Occupante svela il suo nome e rivela la sua storia, che ha inizio a Parigi nei fatidici giorni del maggio 1968, quando per le strade infuriava la guerriglia urbana (e qui Erickson ci disorienta con un’inedita visione americana del Sessantotto); ci viene rivelato come il caos, ossessione dell’Occupante, abbia invaso la sua vita e l’abbia sconvolta dall’inizio, e come l’Occupante sia diventato un apocalittologo, uno studioso (dilettante) del caos. La storia raccontata dall’Occupante sfocerà in quella di sua moglie Angie, fuggita di casa con una figlia nel grembo e mai più ricomparsa, e man mano s’incrocerà con altre vicende, e con altre città: New York e l’ambiente della pornografia, ancora la Francia, ma di provincia, e poi la California settentrionale. Questo romanzo ossessionante come un incubo vive nella tensione tra le dinamiche oniriche della narrativa di Erickson, e la sua aderenza a scene, luoghi, eventi e situazioni della vita vissuta; questa tensione, che è anche un equilibrio, si spezza nell’ultimo terzo del romanzo, dove il sogno prevale in modo forse eccessivo, riportando la storia dalle parti di Amnesiascope (e tornando circolarmente da Kristin). Ma le prime 150 pagine di questo romanzo sono da antologia, e mostrano un autore originale e di talento al suo meglio; nonostante la storia cambi ripetutamente centro, abbandonando un personaggio e focalizzandosi su un altro, non si riesce a staccarsi dalla pagina, e si deve seguire questa successione di vite sconvolte, alla deriva in un mondo forse illeggibile, forse anche troppo leggibile.
Romanzo dalla struttura avvolgente e avvincente, comincia con la storia di Kristin, una ragazza scappata di casa non si sa perché, che dopo essere scampata al suicidio di massa di una setta religiosa che crede nell’apocalisse di fine millennio, finisce con l’incontrare un uomo che si fa chiamare l’Occupante, grazie a un annuncio su un quotidiano. Tra i due si stabilisce un rapporto di dominazione: la ragazza soggiace alle voglie dell’Occupante, che in cambio la ospita nella sua villa a Los Angeles. Sembra che sia Kristin la schiava e l’uomo il padrone, ma il rapporto tra i due si complica gradualmente, e giunge il momento in cui, nella migliore tradizione hegeliana, si ha un rovesciamento. A questo punto l’Occupante svela il suo nome e rivela la sua storia, che ha inizio a Parigi nei fatidici giorni del maggio 1968, quando per le strade infuriava la guerriglia urbana (e qui Erickson ci disorienta con un’inedita visione americana del Sessantotto); ci viene rivelato come il caos, ossessione dell’Occupante, abbia invaso la sua vita e l’abbia sconvolta dall’inizio, e come l’Occupante sia diventato un apocalittologo, uno studioso (dilettante) del caos. La storia raccontata dall’Occupante sfocerà in quella di sua moglie Angie, fuggita di casa con una figlia nel grembo e mai più ricomparsa, e man mano s’incrocerà con altre vicende, e con altre città: New York e l’ambiente della pornografia, ancora la Francia, ma di provincia, e poi la California settentrionale. Questo romanzo ossessionante come un incubo vive nella tensione tra le dinamiche oniriche della narrativa di Erickson, e la sua aderenza a scene, luoghi, eventi e situazioni della vita vissuta; questa tensione, che è anche un equilibrio, si spezza nell’ultimo terzo del romanzo, dove il sogno prevale in modo forse eccessivo, riportando la storia dalle parti di Amnesiascope (e tornando circolarmente da Kristin). Ma le prime 150 pagine di questo romanzo sono da antologia, e mostrano un autore originale e di talento al suo meglio; nonostante la storia cambi ripetutamente centro, abbandonando un personaggio e focalizzandosi su un altro, non si riesce a staccarsi dalla pagina, e si deve seguire questa successione di vite sconvolte, alla deriva in un mondo forse illeggibile, forse anche troppo leggibile.
La passione cinematografica di Erickson si manifesta qui nell’attraversamento dell’industria degli snuff movies, pellicole clandestine nelle quali si riprende la morte di attrici (vera? perfettamente simulata? i pareri divergono) coinvolte in svariate perversioni sadomasochiste. Nel romanzo la pornostar di serie B Louise ha l’idea e il suo compagno Mitch (cineasta non si sa del tutto idiota o del tutto squilibrato, o qualche devastante mix tra i due) la mette in pratica; ma al di là dell’atrocità dell’idea di vendere la morte in diretta, gli snuff movies sono evidentemente l’incarnazione suprema del cinema come incubo, e dal punto di vista della critica cinematografica una sorta di punto di non ritorno, il segno forse che su pellicola la verità assoluta non può avere cittadinanza, pena precipitare nell’assoluta infamia.
Arc d’X , Fanucci 1999, tr. Tommaso Pincio
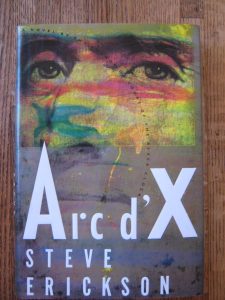 Forse, più che un romanzo, questo è un vero e proprio compendio del mondo onirico e surreale di Erickson; oltre tutto è stato tradotto da uno dei nostri autori più americanizzati (allora ai suoi esordi). Giudicate voi. Tutto inizia alla fine del Settecento, quando Thomas Jefferson, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti (e autore della Dichiarazione d’Indipendenza), dopo la morte della moglie, si prende (in tutti i sensi) come amante Sally Hemings, una schiava di colore. Il profeta della libertà americana si rende quindi colpevole di una relazione doppiamente scandalosa: perché in essa si mescola non solo il bianco col nero (i due ebbero diversi figli), ma anche perché Sally era al tempo stesso amante e proprietà del futuro presidente degli Stati Uniti.
Forse, più che un romanzo, questo è un vero e proprio compendio del mondo onirico e surreale di Erickson; oltre tutto è stato tradotto da uno dei nostri autori più americanizzati (allora ai suoi esordi). Giudicate voi. Tutto inizia alla fine del Settecento, quando Thomas Jefferson, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti (e autore della Dichiarazione d’Indipendenza), dopo la morte della moglie, si prende (in tutti i sensi) come amante Sally Hemings, una schiava di colore. Il profeta della libertà americana si rende quindi colpevole di una relazione doppiamente scandalosa: perché in essa si mescola non solo il bianco col nero (i due ebbero diversi figli), ma anche perché Sally era al tempo stesso amante e proprietà del futuro presidente degli Stati Uniti.
Di qui parte questo romanzo-sogno o romanzo-incubo, che mette in contatto diversi mondi e diverse storie alternative. Dopo l’inizio storico, ambientato per lo più nella Parigi della Rivoluzione, la vicenda si trasferisce bruscamente e misteriosamente in una strana città, Aeonopolis, dominata da una dittatura religiosa, controllata da un’onnipresente polizia, dove due detective, Wade e Mallory, devono indagare sulla morte di un perfetto sconosciuto, ritrovato morto in una camera dell’Arboretum (strano misto di locale underground e night club e ghetto urbano) insieme a Sally Hemings. Che relazione c’è tra la donna di questa Los Angeles alternativa (nata forse da un cataclisma, visto che sulla città incombe un enorme vulcano), e l’amante di Jefferson? Sono la stessa persona, o la seconda è una reincarnazione della prima? E chi è il morto?
Segue una vicenda complessa e labirintica, che si svolge in un presente alternativo (o forse un futuro distopico), quello di Aeonopolis, ma anche in una Berlino devastata (e non rigenerata) dalla caduta del Muro (e quindi un’altra storia alternativa), dove Erickson stesso incontra un giovane naziskin, Georgie Valis, figlio (forse) di un profugo dalla Germania Est. La vicenda segue le vite di un gruppo di personaggi, tutti più o meno travolti dallo scontro tra amore e libertà che già lacerava la coscienza di Thomas Jefferson; e forse, più che Sally Hemings, al centro di questo viluppo c’è l’archivista e scrittore, Etcher, che è da leggere come un’identità alternativa dell’autore (se all’inizio si limita a raccogliere documenti, nella seconda metà del romanzo vive da eremita a riscrivere le storie che non sono avvenute). Nel complesso finale le varie trame del romanzo si riconnettono in modi sorprendenti e spiazzanti, intensificando l’impressione di trovarsi in un sogno o forse un incubo, ma lasciando anche la sensazione che quel sogno, quell’incubo, abbia molto, fors’anche troppo, a che fare con le nostre vite e la nostra storia.
Sicuramente meno “accessibile” di Zeroville, questo romanzo però sembra avvicinarsi di più al nucleo delle ossessioni di Erickson, interrogando al tempo stesso il cuore nero dell’America, dove la libertà e la schiavitù non cessano di rovesciarsi l’una nell’altra nei modi più imprevisti e imbarazzanti.
Zeroville, Bompiani, 2008, tr. Simona Vinci e Andrea Bruni
 Si tratta, diciamo, di un romanzo sul cinema. Un tipo strano arriva a Hollywood alla fine degli anni Sessanta. Ha la testa rasata a zero, e sopra ci ha fatto tatuare Montgomery Clift e Liz Taylor, protagonisti del suo film preferito, Un posto al sole. Il tipo strano ha una specie di fede religiosa nel cinema. Avrebbe un nome, ma tutti lo chiamano Vikar. Lo prendono per matto, ma siccome di gente normale a Hollywood non è che ce ne sia poi tanta, non è che spicchi più di tanto. Sono i giorni dopo la strage di Bel Air perpetrata dai seguaci di Charles “Satana” Manson. Gli Stati Uniti scaricano tonnellate di napalm su Vietnam e Laos. Tutti sono strafatti di acido, hashish, pasticche, eroina. Il presidente si chiama Nixon. Hanno appena sparato a Bob Kennedy e Martin Luther King. Cosa ci sarà di tanto speciale, in un posto e un momento del genere, in un tipo che va in giro con due attori tatuati sulla testa?
Si tratta, diciamo, di un romanzo sul cinema. Un tipo strano arriva a Hollywood alla fine degli anni Sessanta. Ha la testa rasata a zero, e sopra ci ha fatto tatuare Montgomery Clift e Liz Taylor, protagonisti del suo film preferito, Un posto al sole. Il tipo strano ha una specie di fede religiosa nel cinema. Avrebbe un nome, ma tutti lo chiamano Vikar. Lo prendono per matto, ma siccome di gente normale a Hollywood non è che ce ne sia poi tanta, non è che spicchi più di tanto. Sono i giorni dopo la strage di Bel Air perpetrata dai seguaci di Charles “Satana” Manson. Gli Stati Uniti scaricano tonnellate di napalm su Vietnam e Laos. Tutti sono strafatti di acido, hashish, pasticche, eroina. Il presidente si chiama Nixon. Hanno appena sparato a Bob Kennedy e Martin Luther King. Cosa ci sarà di tanto speciale, in un posto e un momento del genere, in un tipo che va in giro con due attori tatuati sulla testa?
Vikar entra nel cinema. Diventa un montatore. Svolge un ruolo cruciale: è quello che fisicamente fa il film, incollando insieme i pezzi di pellicola delle varie sequenze. Spesso senza che il regista intervenga. Vikar è bravo, nel suo mestiere, anche se ha uno stile talmente strano che all’inizio lo prendono per matto (un’altra volta). Ma poi vince un premio a Cannes, e diventa Qualcuno.
Ma la sua vita non è per questo più semplice: ha avuto un infanzia difficile con un padre maniaco religioso. Si è innamorato di una donna dalla vita complicata, Soledad, che lo considera uno psicopatico pericoloso, e magari pure mezzo pedofilo. Ha un sogno ricorrente, di un sacrificio antichissimo, e gli appare sempre una scritta incomprensibile. Eppure Vikar riesce a navigare in quello strano mondo scombiccherato che è la Mecca del Cinema senza affondare, incontrando gente strampalata, e anche personaggi che in poco tempo diventeranno famosi (a un certo punto incrocia anche un Robert De Niro ancora sconosciuto che lo prenderà a modello quando reciterà in Taxi Driver…).
Un romanzo sul cinema? Sì, certo, ma non necessariamente una cosa per cinefili (anche se i cinefili dovrebbero leggerselo). Nelle mani di Erickson il cinema diventa una metafora della vita, un’immagine del mondo. Come il teatro per Shakespeare. Ho detto Shakespeare? E perché no? Dentro questa storia che si snoda dagli anni Sessanta agli anni Ottanta mentre il cinema americano affronta una delle sue tante cataclismatiche metamorfosi, c’è anche tanto di classicamente letterario. Vikar è vergine, come Parsifal; e come Parsifal a un certo punto dovrà partire alla ricerca di un Graal di celluloide: la pellicola perduta della Passione di Giovanna d’Arco di Carl Theodor Dreyer (ennesimo artista visionario che crea un’opera suprema e rifiutata).
Forse il romanzo più riuscito, più compiuto, più ricco di Erickson; quello che raccomanderei a tutti di leggere per primo, nonostante sia uscito per ultimo.
Ancora inediti in Italia
 Romanzi
Romanzi
- Rubicon Beach (1986)
- Tours of the Black Clock (1989)
- Amnesiascope (1996)
- Our Ecstatic Days (2005)
Raccolte di saggi
- Leap Year (1989)
- American Nomad (1997)
A questa bibliografia, pubblicata nel 2010, bisogna aggiungere These Dreams of You (2012) e ovviamente Shadowbahn (2017).




