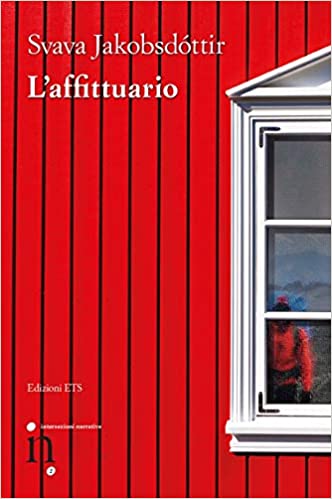La ricerca di oggettivazione totale, fotografica, del nouveau roman, tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, finisce presto per caricare la realtà di incrostazioni: ogni attimo, ogni oggetto, per essere definito in modo compiuto, fino all’ultimo particolare, fino all’ultimo atomo, avrebbe bisogno di una descrizione (e di un vocabolario) infiniti. È così che la linea che da Alain Robbe-Grillet risale fino a Peter Handke si risolve alla fine in una feconda oggettivazione del soggettivismo. In romanzi come L’ambulante (Guanda, 2017) o Prima del calcio di rigore (Guanda, 2016), sono i frammenti di un io dissociato dal mondo che acquistano carattere di assoluto e sono restituiti attraverso le parole o le non-parole che li costituiscono: l’unica oggettività possibile è quella del soggetto che formula pensieri, e solo i pensieri, ciò che si forma nell’interiorità, possono essere restituiti in modo approssimativamente oggettivo, non le cose, che non appartengono all’ambito ontologico dell’umano.
Il mondo interno dell’esterno dell’interno (Feltrinelli, 1980), scrive Handke nel 1974. “Per un attimo temette, sì, ebbe la certezza”, scrive Svava Jakobsdóttir in una delle prime pagine di questo romanzo, quasi come un’enunciazione programmatica, “che la sua intera esistenza si sarebbe invertita, l’interno si sarebbe rivoltato all’esterno e l’interno all’esterno”. L’affittuario è del 1969. L’Islanda da cui la sua autrice proviene non è ancora assurta al rango di fucina di autori di successo, come è avvenuto in questi ultimi anni, ma è terra dalla tradizione letteraria ricca, importante, attenta e sensibile a ciò che proviene dai paesi più grandi e dalla produzione più vasta. Svava Jakobsdóttir (1930-2004), che sarà poi simbolo del feminismo islandese, donna impegnata in politica e membro del Parlamento, esordisce negli anni dello sperimentalismo, nel 1965 con la raccolta di racconti 12 konur (“12 donne”), allineandosi alle avanguardie nella ricerca di dar voce oggettiva all’inoggettivo della psiche umana, seguendone i moti e i meandri così come sono, senza tentare di sedarli, spiegarli, inserirli nella linearità di un sistema che li normalizzi. Così questo romanzo, L’affittuario, è tanto netto e preciso nelle sue raffigurazioni, nella costruzione delle sue sequenze e dei suoi personaggi, quanto disorientante e sfuggente nei suoi ancoraggi alla realtà. Lo spunto è semplice, e riprende uno dei grandi canoni della narrativa realista tardo-ottocentesca e del teatro di Ibsen in particolare: l’irruzione di un estraneo – che presto diventa l’Estraneo – in mondo noto, familiare. Familiare nel senso più letterale: in questo caso il minuscolo nucleo formato dalla protagonista, anonima, giovane donna con cui coincide lo sguardo narrante, e dal marito Pétur, cui si aggiunge un giorno un estraneo, l’affittuario del titolo, che si insedia nella loro casa, presenza ingombrante ed enigmatica, incombendo su di loro come una divinità blanda e dispotica, talvolta benevola, sempre incontrastabile e incomprensibile. Come del resto sono incomprensibili molte delle dinamiche che presiedono al rapporto della coppia, dalla costruzione di una casa nuova di loro proprietà (in questa anche loro vivono in affitto), in un lotto moderno e prestigioso, e che tuttavia, come per una maledizione antica, sembra non completarsi mai, e anzi si disfa di fronte ai loro occhi, al rito che si consuma la sera, a letto, quando la protagonista offre al marito il seno colmo di latte affinché lo svuoti. Un mondo allucinato, quello che si compone e si decompone di continuo ai nostri occhi, di fronte al quale è forte il disagio: ma è un disagio del vivere, che dopo cinquant’anni ancora ci tocca e ci appartiene.