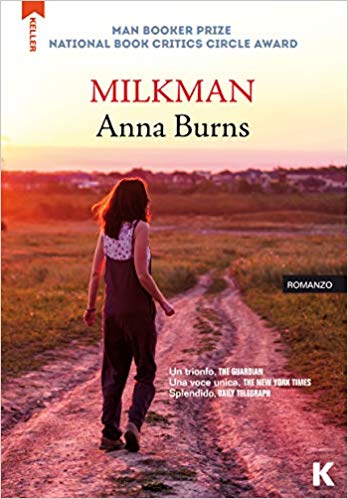Anna Burns, già nota al pubblico e alla critica inglese e irlandese per i suoi romanzi No Bones (2001) e Little Constructions (2007), è la prima scrittrice nordirlandese ad aggiudicarsi il Man Booker Prize for Fiction con il romanzo Milkman (2018), suo esordio in Italia grazie alla traduzione di Elvira Grassi.
Milkman è la storia di sorella di mezzo, una ragazza diciottenne che ci parla in prima persona da una città senza nome, in cui è possibile riconoscere la Belfast degli anni Settanta. La società che la circonda è dilaniata dai ben noti Troubles, e schiacciata dalle implicazioni moraliste di un’ideologia alienata e delirante; tutto questo dà alla vicenda uno sfondo cupo, accigliato, dove la paura per la propria incolumità fisica va a braccetto con quella del biasimo e dell’esclusione sociale.
I personaggi non hanno un nome, e neppure le vicende politiche in atto vengono nominate con precisione, sono i problemi politici, semplicemente. Dunque né i personaggi, né le vie o i quartieri, né le situazioni vengono mai identificate chiaramente, con nomi propri, ma piuttosto vengono tratteggiati dalla narratrice con perifrasi (l’Inghilterra è il paese nemico o il paese oltre l’acqua, i ribelli sono i rinnegatori-dello-Stato, le femministe sono le donne delle questioni) che offrono al lettore un punto di vista volutamente ottuso, opaco, schermato.
Ci sono ovunque emozioni contrastanti, incomprensibili; c’è un disorientamento generale, inquinato di rabbia, indolenza, segreto terrore. Vicende crude sono narrate con apparente distacco, a volte con atteggiamento di noia o repulsione, in uno scenario onirico, inaudito.
Emblematica in questo la descrizione dell’area-da-dieci-minuti: “nessuna persona sana di mente avrebbe mai pensato di andare a ciondolare lì […], un cerchio […] lugubre, desolato […] dominato da tre gigantesche chiese […] poco più che scheletri di edifici, benché le nere guglie svettassero ancora nel cielo.”
In un’atmosfera sospesa, trasognata, si svolgono eventi assurdi – gli avvelenamenti seriali di ragazza delle pastiglie, lo stalking rancoroso e le menzogne pseudo-eroiche di Qualcuno McQualcuno, le autobombe, i cani sgozzati, le irruzioni-farsa militari e paramilitari nei locali notturni – con tinte surreali, condite a tratti da un certo umorismo torvo, sbieco.
“Neppure allora – diceva (mia madre) – ho mai capito tuo padre. A cos’erano dovuti tutti quegli “psicologici”? […] pa’ aveva sofferto di una depressione grande, immensa, sfrecciante, schiacciante, nuvola-nera, contagio, cornacchia, corvo, taccola, cassa-da-morto, catacomba-su-catacomba, scheletro-su-teschio-su-ossa strisciante sul terreno dritto fino alla tomba.”
Ma che cosa ci fa sorella di mezzo, con in mano la testa mozzata di un gatto – malamente avvolta in due fazzoletti insanguinati – davanti alle porte del cimitero? E chi è quell’uomo che le si affianca quando corre a parchi & laghi, con cui parla per la strada, che la segue ovunque con il suo furgoncino bianco?
Sorella-di-mezzo non è una strega, né una pazza, né l’amante del lattaio – che un lattaio non è – come si vocifera a mezza bocca nel suo quartiere. È una diciottenne come ce ne sono tante, che ama leggere, camminare, correre al parco. Ha un ragazzo che è un forse-fidanzato, come è normale nell’età dell’incertezza e della forsitudine. Ma è perseguitata da un personaggio più anziano, subdolo, inquietante – il cosiddetto lattaio, appunto – ben conosciuto come potente affiliato ai paramilitari rinnegatori-dello-Stato.
La narratrice ricorda se stessa a diciott’anni, la sua indole schietta, istintiva, il suo non sapersi difendere dalla molestia strisciante e indefinita di quest’uomo di mezza età, che la segue dappertutto: “a diciott’anni non avevo gli strumenti per capire i modi che costituivano l’oltrepassare-il-limite […] provavo un senso di ripugnanza per certe situazioni e per certe persone, ma non sapevo che intuizione e ripugnanza contassero qualcosa, non sapevo che avevo tutto il diritto di non apprezzare, di non dover sopportare, chiunque mi si avvicinasse.” né tantomeno dalla macchina della deplorazione che si attiva, dando inizio al suo spettacolo: il conformismo assillante, l’ipnotico oscillare tra codardia morale ed efferata gogna, pruriginosa maldicenza.
“Sorella maggiore è passata a casa perché ce l’aveva mandata suo marito […] Era venuta a informarmi, a mettermi in guardia. Mi ha detto che ero stata vista mentre parlavo con quest’uomo.”
Sorella di mezzo cammina sempre a testa bassa, da sola, leggendo libri ambientati nel passato, e anche questo contribuisce a renderla un’inaccettabile:
“Camminavo spesso leggendo un libro. Non ci trovavo niente di male eppure a un certo punto è diventata un’altra delle cose da aggiungere alle prove contro di me.”
È una ragazza che prova con caparbietà a essere sé stessa, in una realtà malata e distopica che fa di tutto per stigmatizzarla, farla sentire anormale. Gli attacchi della società le si stringono attorno; si sommano, si moltiplicano: il rischio di attentati, le zone interdette, le autobombe, le molestie, la calunnia sistematica.
Quest’ultima è essa stessa un pericolo, un’arma delle peggiori. Alla sorveglianza ufficiale di Stato-nemico, e degli stessi movimenti insurrezionalisti a loro volta istituzionalizzati, cristallizzati in una nuova oppressione, c’è il peso endemico di una moralità obliqua e distorta che pervade l’intera società, che arriva a impregnare anche i familiari, le persone più care e vicine.
“Hai perso il lume della ragione. Non sai più distinguere il bene dal male. Diventa impossibile, figliola, volerti bene.”
“Te la sei cercata, amica storica […] non credere che la gente ti lascerà in pace […] sei finita nella “zona difficile”
C’è una verità parallela, da tutti considerata la vera e unica realtà, che prende corpo come qualcosa di solido e ineluttabile, fino a schiacciare le persone che ne sono l’oggetto, rendendole abuliche e disorientate. Prima fra tutte, per sorella di mezzo, la sua presunta relazione con il lattaio; le sue apparizioni sono improvvise, silenziose, il suo atteggiamento di familiarità e possesso è sconcertante. Intanto, c’è chi di sottecchi guarda, scatta fotografie, registra orari e avvenimenti, archivia dossier.
L’unica possibilità di difendersi da tutto questo è il vuoto del finto non capire, il non farsi vedere, sentire, percepire, nascondendosi – come un animale braccato – in un non lo so, fissarsi in uno sguardo immobile e assente.
Milkman non è solo un libro sui disordini politici dell’Irlanda del nord. È un libro che parla di una città spettrale, sospesa, universale; di mimetismo per la sopravvivenza; dell’eroismo che c’è nell’essere sé stessi, nell’attraversare l’isolamento, la disapprovazione, non rinunciando alla propria autenticità.
Ci sono le discriminazioni di genere, questo è certo; ma a uno sguardo attento vittime e carnefici si rivelano via via presenti in modo trasversale, perché la maldicenza diviene sopruso e oppressione, anche e più della violenza fisica.
Ci sono creature additate, etichettate, soffocate; di cui si rivendica la proprietà, il diritto di oltraggio e sopraffazione; creature perse, disciolte nel dolore, nella follia; ci sono molestie sordide, travestite da affettuoso umorismo, da carezza, da protezione.
C’è la paura dell’amore vero, della felicità; c’è la viltà del compromesso, la vita che diviene letargica e avvilita accettazione. Ma c’è anche l’adolescenza, con le sue ribellioni dislocate, fuori centro, emotive, rabbiose; le sue repentine prese di coscienza, la sua nobiltà. Il lirismo inaspettato, struggente, di amori ripresi, di lettere ritrovate, che strappano senza preavviso un sipario trasognato e opaco, e spaccano al lettore il cuore in due.
Il libro si è presentato da subito come un potenziale caso letterario internazionale, e ha attratto indubbiamente l’attenzione della critica in più occasioni: è risultato vincitore anche al National Book Critics Circle Award, all’Orwell Prize for Political Fiction, nonché finalista ad altri numerosi premi come il Women’s Prize for Fiction e il Rathbones Folio Prize; è stato segnalato e commentato come libro sperimentale, dal linguaggio innovativo e rivoluzionario, è stato messo in parallelo con James Joyce, Samuel Beckett, Laurence Sterne, e sono stati allertati come potenziali lettori gli amanti della narrativa modernista, di William Faulkner, di Virginia Woolf, del sempre citato Joyce:
“So che siete là fuori, in attesa di un libro per placare la vostra sete di qualcosa di strano e complesso”. Dunque, Milkman è per voi. Queste le parole del Washington Post.
Un testo audace, sovversivo, di grande ricerca stilistica; il linguaggio è senz’altro irriverente al limite del provocatorio, la costruzione sintattica è complessa, con un gioco di incisi simile al dipanarsi intricato di fitti pensieri; particolare l’accorgimento di negare un nome proprio a oggetti, luoghi, personaggi, lasciandoli indefiniti – non definendoli – che finisce col renderli familiari, intimi, in modo teneramente ossessivo.
Milkman è un libro delicato, atroce, dolcissimo; è un testo in cui la complessità si stempera ben presto in una partecipazione intensa a qualcosa di straordinariamente univoco e forte. Anna Burns ha scritto di realtà difficili, poliedriche, complesse, con un lessico e un fraseggiare ingarbugliato, multiforme, dando infinite sfumature di senso, e sensazioni emotive intense. La traduzione è leale, ma libera in spirito, e ci restituisce immagini potenti, piene, a tratti maestose; con la precisione di un matematico, ha saputo trovare la chiave di un messaggio cifrato, e rivelarcelo; e ha saputo farlo magistralmente.