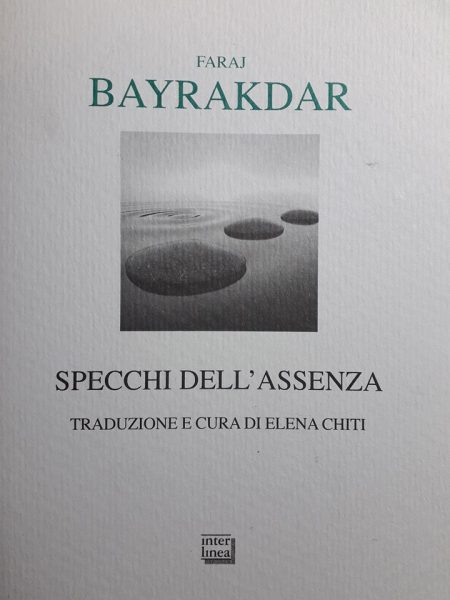Faraj Bayrakdar, Specchi dell’assenza, tr. e cura Elena Chiti, Interlinea, pp. 117, euro 12,00 stampa
Le edizioni Interlinea propongono una nuova raccolta poetica del siriano Faraj Bayrakdar, per la traduzione e la cura di Elena Chiti che aveva già curato il primo volume in italiano del poeta: Il luogo stretto (nottetempo). Sempre da uno “spazio ristretto disperato” scrive l’autore: le poesie qui raccolte datano 1997-2000, gli ultimi tre anni di carcere che Bayrakdar ha trascorso, da attivista comunista inviso al potere siriano, nel carcere di Sednaia a Damasco. Si tratta di cento componimenti brevi, più “Otto inediti”. Questi ultimi, a differenza dei precedenti, sono stati scritti nel 2015 a Stoccolma, luogo dell’esilio del poeta.
Bayrakdar ci guida dentro una terribile solitudine carceraria: “Qui / siamo soli / il luogo ed io”, dove la poesia è strumento e luogo di una liberazione possibile: “La libertà è patria / il mio paese è esilio” e ancora “berrò la libertà / fino in fondo”. L’“assenza” del titolo è, in qualche modo, l’assenza stessa dello scrittore: assenza dalla vita, dalle relazioni, talvolta dalla dignità. Siamo davanti ad una poetica della tentata evasione verso una vitalità mai perduta del tutto, anche se “le circostanze / erano di pietra / e il tintinnio del tempo e del luogo / aveva una macchia che somiglia a sangue”. I versi bramano continuamente un fuori e trovano riparo solo in un’invocazione alla poesia. Scrive infatti, “Mi nascondo / dentro la poesia”: ma non è una fuga quanto la ricerca testarda di una rigenerazione e la poesia bussa alle porte chiuse e, con la scrittura, amplia “il luogo stretto con la larghezza dell’immaginazione”. Un ripiegamento strategico, dunque, un rifiatare per ridare ossigeno all’immaginazione e dichiarare, quasi utopisticamente, “preparo i sogni alla partenza / ormai pronto / a vivere”.
Nella sua introduzione, “Storia di questo libro”, Bayrakdar chiarisce che scrivere versi per lui significa restituire senso e profondità ad un’esperienza di privazione e inesorabile annientamento. Una funzione umana che si manifesta nel continuo richiamo alla “libertà” – seppure una “libertà di lacrime” – come lumicino nella lunga notte della detenzione: “Chi ama canta / e non c’è canto / che non sia di libertà”. Canto come sinonimo di poesia torna costantemente nei versi di Bayrakdar attraverso le figure dell’uccello e del volo. Le centootto brevi liriche oscillano tra chiusura e apertura: più lo spazio della prigionia sembra restringersi, più lo sguardo del poeta prova a gettarsi fuori, oltre. Per il lettore è quasi un’esperienza furtiva in stanze minuscole con addosso un senso di dolorosa nostalgia per ciò che non è (ancora) stato. I versi brevi e fulminanti di Bayrakdar sono veri e propri panorami stilizzati dipinti su muri senza finestre, che permettono allo sguardo emotivo di gettarsi oltre le sbarre.
È un guardare ovattato e silenzioso. Non c’è clamore né ricerca di pirotecnici effetti linguistici in questo libro ma una po/etica del silenzio: “Dal silenzio voglio / solo parole / che non trovo”, volontà disperatamente omologa alla ricerca della libertà tra le quattro mura del luogo stretto. Non è difficile immaginarsi questo baffuto poeta siriano – oggi in esilio – aggirarsi per il mondo come nell’immagine malinconica di Edmond Jabès: lo straniero con sotto braccio il suo libro di piccolo formato e la malinconica illusione di poter tornare alla propria vecchia terra.