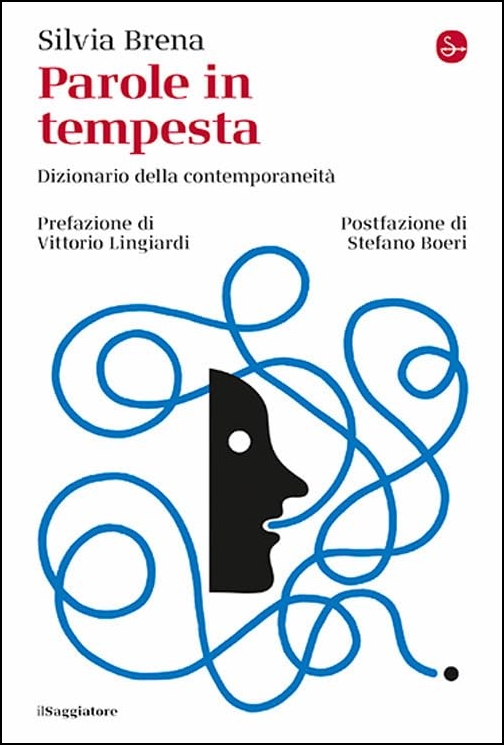Un libro-domino quello di Silvia Brena nel quale partendo dall’idea di comprendere il significato più ampio di parole cardine si giunge a una ridefinizione dell’umano. Il volume si apre con la prefazione di Vittorio Lingiardi nella quale non solo viene presentato il lavoro nel suo complesso ma anche il percorso dell’autrice, l’impegno preciso che da anni ha assunto su di sé nei confronti del linguaggio, degli usi, delle parole in quanto scrigno di testi e sotto-testi.
Si entra nei dieci capitoli, ciascuno dedicato a parole cardine del contemporaneo. Ogni singolo lemma viene definito attraverso i due più importanti dizionari – il Treccani e il Devoto Oli –, quindi partendo da ciò che delimita la descrizione l’autrice ci accompagna mano nella mano nel flusso delle riflessioni che essa smuove. Se per alcuni lemmi la prima riflessione riguarda l’uso improprio di quel termine, attraversandone l’origine e poi il suo evolversi nel tempo, la sua importanza in eventi chiave o al contrario il suo abbandono completo per decenni, si arriva nel finale di ciascun capitolo a una riscrittura della definizione. Per arrivare a questa ridefinizione si attraversano una serie di parole-ponte, molte delle quali ritornano nei vari capitoli, con accezioni diverse. Anche questo a ricordare come l’interconnessione e la rete di parole che si sceglie di usare nel contesto-società le rendano estremamente vive, duttili e necessarie le une per le altre.
Testo ricco di riferimenti e testimonianze quello di Brena, estremamente dettagliato e accademicamente strutturato con bibliografia a corredo perché anche il lettore più avido possa verificare e ampliare ulteriormente le connessioni tra le parole. In tutto 15 capitoli: da Abuso a Verità, da Bellezza a L’ultima parola attraversando costellazioni di significati e di studi sociologici. La fa da padrona una ricorrenza, Memoria: essa ritorna sia come parola cardine di capitolo che come parola-ponte in tanti altri lemmi. Un monito o forse un totem.
Al fianco dell’utilizzo di risorse storiche, testimonianze, memorie e studi accademici si apprezza, nel capitolo dedicato a “L’ultima parola”, il gioco tra richiesta all’AI di produrre una parola valida per il nostro futuro di specie esausta (che è stata generata e poi commentata) e la stessa girata a una “custode di emozioni antiche e attuali”: a Francesca Mazzotta per l’esattezza, poetessa. Ciò che ne è risultato non è una singola parola ma un vocabolario vero e proprio: “Vocabolario Italiano della Tettonica dei Sogni e Zolle”. Anche questo ci indica un futuro, la grande differenza tra la macchina che sintetizza e l’uomo che necessita di parole per definirsi e per descrivere ciò che vive, ricorda, progetta.
Il volume si chiude con il dialogo dell’autrice con Stefano Boeri, dove quest’ultimo enuncia le sue 45 tesi (il riferimento a Lutero lo spiega Brena prima dell’elencazione) nelle quali si ritrovano gran parte delle parole già sviluppate, ma anche altre che aprono ulteriormente a un mondo nuovo che sta compiendo la sua trasformazione e sta decidendo dove e come essere scritto. Il libro di Brena, infine, non è solo un volume di linguistica, di divulgazione, non è solo un saggio, un racconto e uno studio, ma di lettura in lettura diventa un portale nel quale generare parole e consapevolezza, padronanza del tempo e dello spazio nel quale ci muoviamo, nella società che abitiamo e che dovremmo essere consci di costruire ogni giorno soprattutto con le espressioni e gli utilizzi della lingua. Non sorprende quindi che nei ringraziamenti più volte venga ricordata la fatica del “tenersi insieme” e della necessità dello sprone: ogni singolo lemma apre mondi e visioni, dona altre parole e genera pensiero.