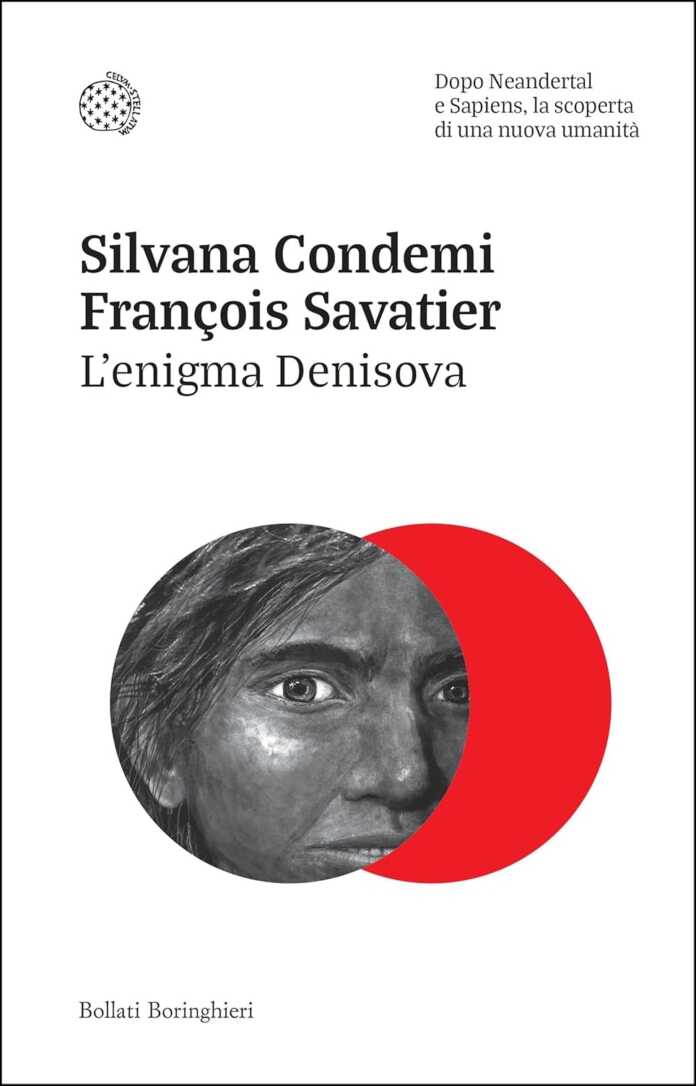Dopo Mio caro Neandertal (Bollati Boringhieri 2018) e Noi siamo Sapiens (Bollati Boringhieri 2019), Silvana Condemi, paleoantropologa e direttrice di ricerca al CNRS presso l’Università di Aix-Marseille, dedica il suo ultimo libro a un più recente e per molti aspetti più misterioso personaggio nella galleria dei nostri, vicini e lontani, antenati: il cosiddetto Uomo di Denisova. Ripercorrendo a grandi linee (e semplificando molto) il nostro pedigree di Hominina : l’Homo habilis, intorno a due milioni di anni fa, è il primo sostanziale salto di qualità rispetto all’Australopiteco, lungo la linea evolutiva che ci separa dal nostro parente scimmiesco più prossimo, lo scimpanzè; l’Homo erectus (e ergaster), circa un milione di anni fa, è il progenitore arcaico, primo bipede migrante Out of Africa; l’Homo heidelbergensis (e antecessor), fra i 600.000 e i 100.000 anni fa, il comune capostipite dei tre cugini successivi: l’europeo Homo neanderthalensis, l’africano Homo sapiens (il più fortunato, non essendosi estinto: noi), e l’asiatico Homo denisovensis. E su quest’ultimo progenitore si concentra il libro, un progenitore più misterioso, dicevamo, perché è in paleoantropologia, l’unica forma umana identificata non grazie ai suoi fossili ma ai suoi geni: il DNA nucleare estratto nel 2010 dalla punta di una falange ritrovata nella grotta di Denisova, nella parte russa del massiccio dell’Altaj. Quasi subito ci si rese conto che quel DNA apparteneva ad una nuova specie sconosciuta, imparentata con sapiens e neandertal e non direttamente derivante da erectus. Una sorta di neandertal asiatico, però geneticamente diverso da neandertal. Gli attuali sapiens asiatici, le popolazioni della Melanesia in particolare, conservano fra il 4 e il 6 per cento del DNA denisoviano, una percentuale assai consistente.
Praticamente senza ossa per i paleontologi – un dente, pochi frammenti di dimensioni inferiori al centimetro e qualche pezzetto di calotta cranica – gli studiosi cinesi sono riusciti a identificare il DNA mitocondriale denisoviano dimostrando la loro presenza dal Tibet fino alla Cina tropicale del Sud. Un’eredità passata ai successivi sapiens che si ibridarono con loro: gli attuali tibetani hanno ereditato dai denisoviani d’altitudine l’allene EPASI, il gene anti mal di montagna. Così anche i papuani della Nuova Guinea rivelano una forte impronta genetica denisoviana dimostrando il contatto, circa 70.000 anni fa, tra i sapiens antichi e non uno ma almeno due gruppi distinti di denisova, del Nord e del Sud, che evidentemente popolavano un’area enormemente vasta e diversificata. A loro volta, in base ai loro genomi, Neandertal e Denisova, risultano essersi separati circa 400.000 anni fa, a partire da una forma africana di heidelbergensis che li accomuna fra loro molto più di quanto entrambi lo siano con il sapiens. Con buona pace dei cinesi e del loro Sinantropo, la genealogia umana non è asiatica ma africana, attraverso almeno quattro stadi evolutivi successivi di Homo: la prima uscita dall’Africa, due milioni di anni fa, dell’habilis; la seconda, 1,5 milioni di anni fa, dell’erectus che popola l’Asia ma non è l’antenato dei Denisova; la terza, 800.000 anni fa, del rhodesiensis/heidelbergensis, che, questo si, sta all’origine di Neandertal in Europa e Denisova in Asia; la quarta infine, fra i 200.000 e i 70.000 anni fa, quella del sapiens, la nostra. Le prime due, antecedenti al controllo del fuoco, stanziate soprattutto in regioni calde, la terza giunta in regioni temperate e subartiche, e la quarta che si è spinta anche fino ai Poli Nord e Sud. Forme umane che il testo definisce “generaliste”, perché invece di limitarsi ad un unico ecosistema – come hanno fatto le specie umane dette “specialiste” – nel corso dell’evoluzione si sono diffuse in tutti gli ecosistemi del pianeta.
La genetica conferma poi che gli umani generalisti successivi si sono mescolati tra loro: una prima, presunta ibridazione tra erectus e denisova; una seconda tra sapiens e neanderthalensis, più di 200.000 anni fa nel Levante; una terza in Eurasia, circa 50.000 anni fa tra gli ultimi neandertal e i sapiens, e tra denisoviani e neandertaliani in Asia settentrionale. Alla faccia delle idiozie razziste sulle “razze pure”, le popolazioni originali, a loro volta discendenti da ondate migratorie precedenti, si uniscono alla biologia e alla cultura della nuova forma generalista che tende a farsi maggioritaria conservando molti dei vecchi geni e dei tratti culturali vantaggiosi ed eliminando quelli che ostacolano la riproduzione: i tratti biologici e culturali della popolazione immigrata, demograficamente dominante, prendono gradualmente il sopravvento su quelli della popolazione locale, derivata da ondate precedenti, senza che tutti i tratti di quest’ultima scompaiano completamente. Ecco perché noi eurasiatici abbiamo tra l’1 e il 3 per cento di DNA neandertaliano, bagaglio utile che ci ha dotato di una maggiore resistenza al freddo, di un metabolismo efficace dei grassi e così via.
Per questo, come conclude il bel libro di Condemi/Savatier, Neandertal e Denisova non sono del tutto scomparsi ma sopravvivono dentro di noi – gli eurasiatici hanno tra l’1,8 e il 2,6 di DNA neandertaliano e gli estremo-orientali tra l’1 e il 5 per cento di DNA denisoviano – dopo le uscite dall’Africa i sapiens eurasiatici si sono ibridati prima coi neandertaliani del Vicino Oriente, poi chi di loro ha raggiunto l’Asia settentrionale e meridionale si è mescolato coi denisoviani. I nostri molteplici antenati sono ancora in noi, tutti quanti. Ragion per cui – si rassegnino i nazisti – la purezza razziale, l’identità etnica è una corbelleria biologica: in genetica siamo tutti bastardi, per fortuna.