“La cosa più bella dell’essere una scrittrice
è che puoi permetterti di abbandonarti
alla stranezza quanto vuoi”
Shirley Jackson – “L’aglio nella narrativa” (Paranoia)
L’8 Agosto del 1965, quando inaspettatamente, a soli 48 anni, Shirley Jackson scomparve per un arresto cardiaco nel sonno, la diagnosi medica ufficiale parlò di occlusione coronarica dovuta ad arteriosclerosi e ipertensione cardiovascolare. Oltre che di certe incontinenze alcoliche e alimentari che la portarono a pesare più di un quintale già in giovane età però, la scrittrice fu probabilmente vittima soprattutto di quel Mother’s Little Helper – micidiale mistura di anfetamine, antidepressivi e barbiturici – che proprio l’anno successivo i Rolling Stones stigmatizzeranno nell’omonimo pezzo del loro album Aftermath. La droga delle casalinghe.
Con quattro figli di età diverse e un marito scrittore – il critico letterario, recensore su The New Yorker, e docente universitario Stanley Hyman – assolutamente deficitario in qualsiasi questione pratica e domestica (ma decisamente sveglio quanto a infedeltà coniugali con ex studentesse), Shirley fu per tre quarti della sua giornata ordinaria, a tutti gli effetti, un’indaffarata casalinga, costretta a ritagliarsi faticosamente i momenti liberi da poter dedicare alla creazione letteraria. Quando finalmente cominciò a guadagnare ben più del marito con il successo della sua narrativa – a partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta – questi (autore di due monumentali lavori di saggistica, The Armed Vision: A Study in the Methods of Modern Literary Criticism, del 1947 e The Tangled Bank: Darwin, Marx, Frazer and Freud as Imaginative Writers, del 1962: testi critici di tutto rispetto ma non certo dei best seller) cominciò a rinfacciarle il tempo sprecato a scrivere lettere o qualsiasi altra cosa non fosse fiction vendibile. Mamma, moglie, casalinga (e quindi cuoca, colf, donna delle pulizie, autista, amministratrice domestica, ecc.) e insieme fonte principale di reddito familiare, non stupisce che le responsabilità, l’ansia e la frustrazione (il suo precoce decadimento fisico e le frequenti scappatelle del coniuge) abbiano minato profondamente e irreparabilmente la sua salute.
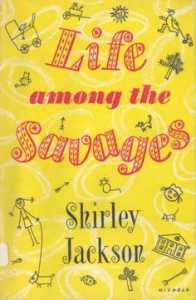 I numerosi coccodrilli apparsi sulla stampa statunitense nei giorni seguenti il triste evento l’avevano salutata, in un tripudio di discutibili calembours, come “the Virginia Werewoolf of seance–fiction”, o come “la più benevola, cordiale, arguta e generosa delle streghe”, insistendo sulla conclamata predilezione per la stregoneria da parte dell’autrice, sul suo scrivere “con un manico di scopa, più che con una penna”: non riuscendo mai a distaccarsi dagli stereotipi più sensazionalistici sulla sua figura letteraria e segnalandone la contraddittoria eccellenza, sia nella rassicurante cronaca familiare umoristica (i memoriali domestici Life Among the Savages del 1953 e Raising Demons del 1957 o le redditizie collaborazioni alle riviste per signore), sia nella destabilizzante ghost–story della migliore tradizione di Poe, Hawthorne e James (da “La lotteria” del 1948 a Abbiamo sempre vissuto nel castello del 1962, passando per L’incubo di Hill House del 1959).
I numerosi coccodrilli apparsi sulla stampa statunitense nei giorni seguenti il triste evento l’avevano salutata, in un tripudio di discutibili calembours, come “the Virginia Werewoolf of seance–fiction”, o come “la più benevola, cordiale, arguta e generosa delle streghe”, insistendo sulla conclamata predilezione per la stregoneria da parte dell’autrice, sul suo scrivere “con un manico di scopa, più che con una penna”: non riuscendo mai a distaccarsi dagli stereotipi più sensazionalistici sulla sua figura letteraria e segnalandone la contraddittoria eccellenza, sia nella rassicurante cronaca familiare umoristica (i memoriali domestici Life Among the Savages del 1953 e Raising Demons del 1957 o le redditizie collaborazioni alle riviste per signore), sia nella destabilizzante ghost–story della migliore tradizione di Poe, Hawthorne e James (da “La lotteria” del 1948 a Abbiamo sempre vissuto nel castello del 1962, passando per L’incubo di Hill House del 1959).
Seppure non fuori luogo, comunque, voler rinchiudere l’opera della Jackson entro i confini, affascinanti ma ristretti, dell’horror – come tuttora sembrano continuare a fare, pur omaggiandola, i suoi presunti seguaci contemporanei più rinomati, Stephen King e Neil Gaiman – appare, oggi come allora, ridicolmente limitativo.
Nata a San Francisco nel 1916 – e non nel 1919, come vezzosamente lasciò credere per non dichiararsi più vecchia di suo marito – in una famiglia molto convenzionale e seguace, secondo la linea materna, del culto della Christian Science che la familiarizzò fin dall’infanzia a certe pratiche occulte, come le sedute medianiche e l’uso dell’Ouija board, la tavoletta degli spiriti, in seguito sarebbe divenuta del tutto atea, mantenendo però un interesse non solo teorico, almeno a suo dire, per il soprannaturale, la magia e soprattutto la stregoneria. Certo il suo rapporto con la scrittura era di tipo magico; scrivere era per lei un incantesimo per tenere a bada la realtà. Shirley ebbe sempre rapporti molto conflittuali e dolorosi con la madre Geraldine, che le rimproverò per tutta la vita gli atteggiamenti informali, l’aspetto trasandato e poco attraente e la non conformità agli stereotipi dell’american way of life.
La futura scrittrice studiò giornalismo e letteratura alla Syracuse University, dove incontrò Stanley Hyman, di lì a poco suo consorte, intellettuale ebreo e allora simpatizzante comunista, con il quale mosse i primi passi nella pubblicistica  fondando la rivista universitaria The Spectre, in seguito soppressa dalle autorità scolastiche per le posizioni radicali sostenute, la difesa dei diritti civili e dell’ammissione di studenti di colore all’università.
fondando la rivista universitaria The Spectre, in seguito soppressa dalle autorità scolastiche per le posizioni radicali sostenute, la difesa dei diritti civili e dell’ammissione di studenti di colore all’università.
L’eterogenea coppia – contrastata da entrambe le famiglie di appartenenza: blandamente antisemita quella di lei, serrata nella salvaguardia della propria identità ebraica, quella di lui – si trasferisce nel Vermont, dove Hyman insegna letteratura in periodi diversi, presso il Bennington College – considerato uno dei campus più radicali d’America, collegio femminile noto per la spregiudicatezza e il libertinismo delle allieve (Miriam Marx, la figlia di Groucho, per esempio, riuscì a farsi espellere per “condotta inadeguata”). Ne diventerà in seguito uno dei docenti più apprezzati.
Nel cuore del New England puritano, però, fuori dagli ambienti accademici permissivi, l’anticonformismo dei due coniugi – atei che non frequentavano la parrocchia, democratici radicals in un enclave repubblicana, genitori ben poco autoritari, rumorosi organizzatori di party notturni frequentati da personaggi eccentrici, newyorkesi fuori porta e perfino da “negri” – risultò un corpo estraneo mai integrato nella comunità locale. La diffidenza si trasformò spesso in aperta ostilità. Pensando proprio ai villagers che incrociava facendo la spesa al drugstore, Shirley si prese la sua vendetta componendo la prima opera che le avrebbe dato la fama: “La lotteria”.
 Quando il racconto – oggi tranquillamente antologizzato perfino nei manuali scolastici statunitensi – venne pubblicato su The New Yorker il 26 giugno del 1948, la redazione della rivista venne sommersa nel corso delle settimane seguenti da valanghe di lettere di lettori indignati che lo definivano “oltraggioso”, “orribile”, “shoccante”, oppure “del tutto insensato”: si contarono più di cento lettere in un mese, 300 in totale – “di cui solo 13 gentili, ed erano quasi tutte di amici”, annotò spiritosamente Shirley – oltre a dieci abbonamenti al periodico cancellati. La gente spaziava tra chi voleva sapere dove si tenevano simili lotterie e se si poteva andare a vederle, a chi definiva la storia “spazzatura pura e semplice”.
Quando il racconto – oggi tranquillamente antologizzato perfino nei manuali scolastici statunitensi – venne pubblicato su The New Yorker il 26 giugno del 1948, la redazione della rivista venne sommersa nel corso delle settimane seguenti da valanghe di lettere di lettori indignati che lo definivano “oltraggioso”, “orribile”, “shoccante”, oppure “del tutto insensato”: si contarono più di cento lettere in un mese, 300 in totale – “di cui solo 13 gentili, ed erano quasi tutte di amici”, annotò spiritosamente Shirley – oltre a dieci abbonamenti al periodico cancellati. La gente spaziava tra chi voleva sapere dove si tenevano simili lotterie e se si poteva andare a vederle, a chi definiva la storia “spazzatura pura e semplice”.
“Se queste lettere” – dichiarò la Jackson – “si potessero considerare uno spaccato attendibile del pubblico dei lettori… smetterei immediatamente di scrivere”.
L’antropologo Arthur L. Kroeber, padre della futura scrittrice Ursula K. Le Guin, all’epoca diciannovenne, fu indignato dalla storia perché, ricordò la figlia, “in quanto antropologo sociale, non poteva accettare il modo in cui la lotteria veniva presentata come un’istituzione sociale riconosciuta: era per lui un palese trucco, un imbroglio”. La metafora della lapidazione rituale a sorteggio, a metà strada fra James Frazer de Il ramo d’oro e Nathaniel Hawthorne de La lettera scarlatta, in un contesto moderno e civilizzato, era difficile da digerire: uno “strumento di Stalin” per  molti, ma ci fu anche chi la apprezzò senza riuscire a capire.
molti, ma ci fu anche chi la apprezzò senza riuscire a capire.
Il racconto comunque ebbe i suoi riconoscimenti: fu antologizzato immediatamente in Prize Stories of 1949 e in 55 Short Stories of the New Yorker – Vladimir Nabokov annotò sulla sua copia un voto per ogni storia: “La lotteria” ebbe il voto massimo, un A, superato solo, con un A+, da “Colette”, dello stesso Nabokov, e da “Un giorno ideale per i pescibanana” di J. D. Salinger – venne trasmesso alla radio nel 1951 e adattato per una trasposizione televisiva; nel 1959 fu inciso perfino un disco in cui la scrittrice – con certa affettazione britannica nell’accento e il tintinnare ben udibile in sottofondo dei cubetti di ghiaccio nel bicchiere di bourbon che sorseggiava per farsi coraggio – leggeva il racconto; nel frattempo il governo razzista del Sud Africa lo includeva nel sillabo dei libri proibiti insieme a Frutto proibito di Lillian Smith e Paura di Richard Wright (“almeno loro l’hanno capita davvero”, commentò Shirley orgogliosa). Alla lunga però il successo di “La lotteria” infastidì la Jackson che temeva di essere conosciuta per quest’opera e nient’altro: la sua quotazione finanziaria come autrice comunque, ebbe un significativo incremento.
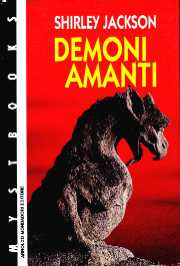 Nel 1949 con il titolo di The Lottery, or The Adventures of James Harris, fu pubblicato il suo secondo volume di narrativa e la sua prima raccolta di racconti brevi. Il sottotitolo proposto dall’editore era stato Notes From a Modern Book of Witchcraft, ma la Jackson aveva preferito la demonologia alla stregoneria, introducendo la figura di Mr. Harris, il Daemon Lover di una ballata folkloristica insegnatale da sua madre (e riportata come epilogo in fondo al volume), che seduce una donna promettendole di mostrarle “how the lilies grow/ On the banks of Italy” e solo in mezzo al mare rivelerà finalmente la sua natura diabolica facendo naufragare la nave e trascinando tutti all’inferno.
Nel 1949 con il titolo di The Lottery, or The Adventures of James Harris, fu pubblicato il suo secondo volume di narrativa e la sua prima raccolta di racconti brevi. Il sottotitolo proposto dall’editore era stato Notes From a Modern Book of Witchcraft, ma la Jackson aveva preferito la demonologia alla stregoneria, introducendo la figura di Mr. Harris, il Daemon Lover di una ballata folkloristica insegnatale da sua madre (e riportata come epilogo in fondo al volume), che seduce una donna promettendole di mostrarle “how the lilies grow/ On the banks of Italy” e solo in mezzo al mare rivelerà finalmente la sua natura diabolica facendo naufragare la nave e trascinando tutti all’inferno.
Che accadrebbe se James Harris passeggiasse per le strade di New York ? La risposta la Jackson la fornisce nei suoi racconti facendolo apparire sotto varie vesti, come un uomo alto in abito blu, a volte una presenza sinistra ma tangenziale, a volte elemento distruttivo che conduce le donne al punto di disintegrazione, vero tema della raccolta. L’edizione italiana Adelphi attualmente in commercio, La lotteria (2007), non pubblicando il libro nella sua interezza, ma selezionando solo quattro racconti estrapolati dal contesto non 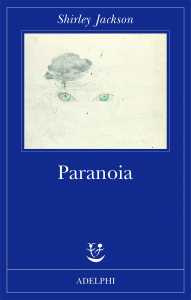 restituisce completamente l’unità tematica di questa silloge fondamentale nell’opera della scrittrice: il lettore non anglofono potrebbe cercare la quasi introvabile edizione Mystbooks Mondadori del 1991 che, sotto il titolo di Demoni amanti, aveva pubblicato il volume completo nella traduzione di Riccardo Valla. Anche l’edizione Adelphi di testi postumi ritrovati dai figli, pubblicata recentemente sotto il titolo di Paranoia (2018), non riprende completamente l’organizzazione originale del testo, e la traduzione italiana del ben più corposo Let Me Tell You (2016) riduce drasticamente il numero dei racconti, saggi, conferenze e pezzi umoristici inclusi. Una scelta editoriale che colpisce la narrativa breve della Jackson e che viene confermata da La ragazza scomparsa, in uscita nel marzo del 2019 da Adelphi, e che prevede solo tre racconti.
restituisce completamente l’unità tematica di questa silloge fondamentale nell’opera della scrittrice: il lettore non anglofono potrebbe cercare la quasi introvabile edizione Mystbooks Mondadori del 1991 che, sotto il titolo di Demoni amanti, aveva pubblicato il volume completo nella traduzione di Riccardo Valla. Anche l’edizione Adelphi di testi postumi ritrovati dai figli, pubblicata recentemente sotto il titolo di Paranoia (2018), non riprende completamente l’organizzazione originale del testo, e la traduzione italiana del ben più corposo Let Me Tell You (2016) riduce drasticamente il numero dei racconti, saggi, conferenze e pezzi umoristici inclusi. Una scelta editoriale che colpisce la narrativa breve della Jackson e che viene confermata da La ragazza scomparsa, in uscita nel marzo del 2019 da Adelphi, e che prevede solo tre racconti.
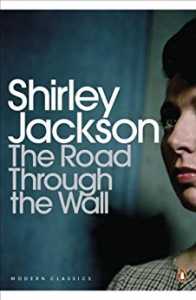 L’esordio narrativo vero e proprio di Shirley Jackson avviene nel 1948 con la pubblicazione del romanzo The Road Through the Wall, fortemente autobiografico, ambientato con notevole senso di claustrofobia in un singolo quartiere, Pepper Street, di Cabrillo, California, chiara trasposizione di Forest View Avenue a Burlingame, dove Shirley era cresciuta: un qualsiasi sobborgo middle–class, dove tutti sanno tutto degli affari degli altri e giudicano aspramente chiunque non sia conforme ai canoni condivisi.
L’esordio narrativo vero e proprio di Shirley Jackson avviene nel 1948 con la pubblicazione del romanzo The Road Through the Wall, fortemente autobiografico, ambientato con notevole senso di claustrofobia in un singolo quartiere, Pepper Street, di Cabrillo, California, chiara trasposizione di Forest View Avenue a Burlingame, dove Shirley era cresciuta: un qualsiasi sobborgo middle–class, dove tutti sanno tutto degli affari degli altri e giudicano aspramente chiunque non sia conforme ai canoni condivisi.
Siamo nel 1936 e Harriet Merriam è una quattordicenne malinconica e poco attraente che scrive poesie ed è l’unica amica di Merilyn, emarginata dai vicini – con un pregiudizio sempre espresso nei termini più educati – perché ebrea. Sua madre Josephine (la madre di Shirley si chiamava Geraldine) le impone continuamente la sua regola di conformità: “We have to do what is expected of us”, bisogna fare quello che gli altri si aspettano da noi. Shirley si vendicherà in queste pagine della grettezza della sua famiglia come Harriet infrangerà l’ipocrisia che regge l’equilibrio della comunità in cui è costretta a vivere: il muro attraverso il quale la strada dovrà passare crolla e la frattura è devastante: adulterio, omicidio e suicidio sconvolgeranno le vite banali dei borghesucci di Pepper Street.
“Il primo libro è quello che devi scrivere per ritornare ai tuoi genitori – dichiarerà Shirley – Una volta che te lo sei tolto dai piedi, allora puoi davvero cominciare a scrivere libri”. La colonna con le informazioni biografiche sull’autrice sul retro di copertina, redatta per conto dell’editore Farrar dal marito Stanley, fornisce – enfatizzandoli un po’ – molti dei particolari che avrebbero alimentato la vulgata successiva su di lei: “Suona la chitarra ed è in grado di cantare ben 500 canzoni folk… sa suonare anche il piano e lo zither. Dipinge, disegna, ricama, costruisce oggetti con le conchiglie, gioca a scacchi, e si occupa della casa e dei figli, cucina, pulisce, lava i panni, ecc. Crede che nessun artista sia mai stato rovinato dal lavoro domestico (neanche aiutato, se per quello). È un’autorità su stregoneria e magia, ha una notevole biblioteca privata di opere in inglese sull’argomento, ed è forse l’unico scrittore contemporaneo che sia un praticante apprendista stregone, specializzato in magia nera di piccolo calibro e divinazione con i Tarocchi… Ama appassionatamente i gatti e al momento ne ha sei, tutti neri come il carbone… Legge in quantità prodigiosa, quasi interamente narrativa, ed ha quasi esaurito il repertorio del romanzo di lingua inglese… Il suo periodo preferito è il diciottesimo secolo, i suoi narratori preferiti sono Fanny Burney, Samuel Richardson e Jane Austen. Non apprezza troppo quella narrativa nevrotica moderna che lei stessa scrive, le scuole di Joyce e di Kafka…”.
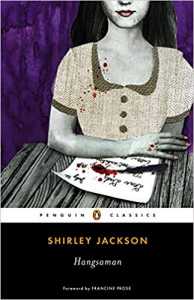 Gli altri romanzi della Jackson che ancora attendono una traduzione nella nostra lingua sono i successivi Hangsaman, del 1951, e The Sundial, del 1958. Il primo che di nuovo combina numerosi elementi autobiografici – gli anni infelici all’Università di Rochester, la cultura sociale del Bennington College, i problemi del suo matrimonio con Hyman – e riferimenti letterari che spaziano da Alice nel paese delle meraviglie alla pornografia vittoriana, prende il titolo dalla ballata folk nota come “Gallows Pole” o “Hangman Tree” (la versione più nota al pubblico di oggi è quella dei Led Zeppelin sul loro terzo LP). Nella canzone, un giovane condannato alla forca chiede al boia di ritardare un poco il momento di mettergli il cappio al collo perché possa parlare coi familiari venuti a trovarlo; alla madre, al padre, ai fratelli, a turno chiede il denaro che possa riscattarlo dalla sentenza, ma tutti quanti rifiutano, sono venuti solo per assistere all’esecuzione: per ultimo arriverà il suo vero amore che finalmente è l’unica persona a offrirgli la salvezza (nella versione più cinica dei Led Zeppelin invece, il boia si approfitta della sorella del condannato, concessa come pagamento in natura, e poi ridendo fa impiccare lo stesso il poveretto).
Gli altri romanzi della Jackson che ancora attendono una traduzione nella nostra lingua sono i successivi Hangsaman, del 1951, e The Sundial, del 1958. Il primo che di nuovo combina numerosi elementi autobiografici – gli anni infelici all’Università di Rochester, la cultura sociale del Bennington College, i problemi del suo matrimonio con Hyman – e riferimenti letterari che spaziano da Alice nel paese delle meraviglie alla pornografia vittoriana, prende il titolo dalla ballata folk nota come “Gallows Pole” o “Hangman Tree” (la versione più nota al pubblico di oggi è quella dei Led Zeppelin sul loro terzo LP). Nella canzone, un giovane condannato alla forca chiede al boia di ritardare un poco il momento di mettergli il cappio al collo perché possa parlare coi familiari venuti a trovarlo; alla madre, al padre, ai fratelli, a turno chiede il denaro che possa riscattarlo dalla sentenza, ma tutti quanti rifiutano, sono venuti solo per assistere all’esecuzione: per ultimo arriverà il suo vero amore che finalmente è l’unica persona a offrirgli la salvezza (nella versione più cinica dei Led Zeppelin invece, il boia si approfitta della sorella del condannato, concessa come pagamento in natura, e poi ridendo fa impiccare lo stesso il poveretto).
La protagonista è l’ennesima ragazzina precoce, specchio più o meno deformato dell’autrice, Natalie Waite. Il nome è probabilmente ispirato al celebre mazzo di tarocchi Waite–Smith (anche se Shirley preferiva usare il più arcaico Tarocco di Marsiglia): la carta dell’Impiccato è una delle più importanti del mazzo, Waite spiega che la complessa iconografia non significa una sentenza di morte ma trasformazione spirituale, profondo rapimento, vita sospesa. Natalie si appresta ad andare al college sfuggendo a una famiglia oppressiva e prevaricatrice, composta da una madre anaffettiva e da un padre – che è un critico letterario, proprio come Stanley, il marito di Shirley, di cui il personaggio sembra una caricatura: come lui ama l’Ulisse di James Joyce e La funzione dell’orgasmo di Wilhelm Reich, legge Il ramo d’oro di Frazer e possiede un’enorme collezione di dischi jazz – che “non è così intelligente come crede di essere”.
La ragazza si rifugia in fantasie morbose e durante un garden party cede all’esperienza nuova dell’abuso alcolico (viene obliquamente suggerito che in stato di ubriachezza uno degli ospiti si approfitti di lei nel bosco dietro casa – esperienza forse vissuta davvero dalla scrittrice – ), ma la disintegrazione della sua personalità prosegue anche al college dove fa amicizia con la giovane moglie alcolizzata di un professore di inglese, isolata nel contesto accademico e gelosa dei flirt delle studentesse con il marito (proprio come Shirley a Bennington) e si sente a disagio con le compagne del dormitorio che lamentano la sparizione di oggetti, denaro, vestiti, gioielli.
Compare la sua unica amica, Tony, un’altra proiezione della sua mente, anche se non sempre è chiaro che sia irreale: per esempio Natalie va a dormire nel letto di Tony ma si sveglia nel suo, Tony le appare nuda ai piedi del letto e la conduce per mano in una stanza dove si trovano tutti gli oggetti rubati e Natalie fugge terrorizzata.
Le due ragazze poi si allontanano in bus dal college e Natalie cita Alice attraverso lo specchio, e vede simboli dei tarocchi nelle insegne luminose dei negozi della cittadina dove si sono rifugiate. Più tardi, in un campo solitario, Natalie crede che Tony voglia aggredirla sessualmente ma, se davvero Tony non è reale, questo è impossibile. Lo shock improvviso la riporta alla normalità. Tornerà al college sentendo che è sopravvissuta a un trauma: “Come non era mai stata prima, ora era sola, e adulta, e potente, e non aveva più paura”.
Anni più tardi la Jackson scoprì con scarso entusiasmo che Hangsaman era citato in un libro di critica letteraria sulle varianti sessuali – Sex Variant Women in Literature di Jeannette H. Foster, considerato un classico minore della teoria critica lesbica – come “un romanzo inquietante sulle lesbiche”. Ammise allora di aver voluto creare un “senso d’illecito eccitamento”, ma che Tony “non era un lui o una lei ma un demone della mente, e un demone trova colpe dove può e le usa…”; in una versione precedente Tony si chiamava infatti Asmodeus, nome ebreo del re dell’inferno.
Shirley etichettò il saggio lesbico come “evidente spazzatura” e smentì con decisione ogni ipotesi di sottotesto omoerotico nella sua narrativa: “scrivo di ambivalenza, ma è un’ambivalenza dello spirito, della mente, non del sesso… è la paura stessa, la paura di sé stessi, ciò di cui scrivo, paura e colpa e la loro distruzione dell’identità…”. Anche il rapporto fra Jenny e Constance in Abbiamo sempre vissuto nel castello diede da pensare e la Jackson puntualizzò: “se il sodalizio fra Jenny e Constance è impuro (Shirley usa il termine unholy), allora il mio libro è impuro e scrivo qualcosa di terribile, dal mio punto di vista, perché la mia stessa identità è persa e la parola diventa solo qualcosa che significa qualcosa d’altro”.
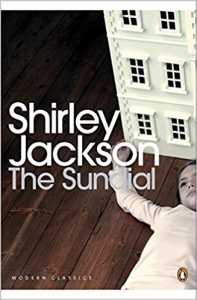 The Sundial invece risente del terrore atomico conseguente all’esplosione della prima bomba all’idrogeno al largo dell’atollo di Bikini nel 1954. È un romanzo sull’apocalisse che, come tutti gli ultimi tre romanzi pubblicati dalla Jackson, inizia e finisce in una casa. Non magione infestata, né nascondiglio pieno di segreti, questa volta, ma piuttosto rifugio antiatomico e arca di Noè, metafora della chiusura e della separazione, la proprietà degli Halloran è separata dal resto del mondo da un muro, “così che tutto quello che è all’interno del muro è degli Halloran, tutto quello che è fuori non lo è”.
The Sundial invece risente del terrore atomico conseguente all’esplosione della prima bomba all’idrogeno al largo dell’atollo di Bikini nel 1954. È un romanzo sull’apocalisse che, come tutti gli ultimi tre romanzi pubblicati dalla Jackson, inizia e finisce in una casa. Non magione infestata, né nascondiglio pieno di segreti, questa volta, ma piuttosto rifugio antiatomico e arca di Noè, metafora della chiusura e della separazione, la proprietà degli Halloran è separata dal resto del mondo da un muro, “così che tutto quello che è all’interno del muro è degli Halloran, tutto quello che è fuori non lo è”.
Qui tutto è simmetrico, perfettamente costruito e ordinato, colonnati, balaustrate, giardini, una piscina perfettamente quadrata; solo una meridiana – da cui il titolo del romanzo – in mezzo a tutto questo, è fuori centro. Gli Halloran sono una famiglia numerosa ma disfunzionale: una coppia anziana, Richard e Orianna; la sorella di Richard, zia Fanny; Maryjane, vedova di Lionel, figlio di Richard e Orianna, morto in circostanza sospette, probabilmente spinto giù dalle scale dalla suocera per assicurarsi l’eredità della casa; Fancy, la figlia di Maryjane e un piccolo gruppo di domestici.
Zia Fanny un giorno ha una visione in cui il padre le rivela l’imminenza dell’apocalisse: “L’Umanità, come esperimento, è fallita”. Il mondo sarà distrutto in una sola notte e solo la loro casa si salverà e i suoi abitanti emergeranno “incolumi e puri” per ereditare una terra vuota e silenziosa. Hanno tre mesi di tempo per prepararsi (lo stesso tempo che l’editore aveva imposto alla scrittrice per terminare il romanzo). Se i prescelti alla salvezza sono gente come gli Halloran – borghesucci gretti e meschini – certo il destino del genere umano è davvero misero: l’umorismo nero della Jackson in questo libro ricorda spesso i toni tragicomici del film Il dottor Stranamore di Stanley Kubrick, uscito nel 1964.
A un certo punto, per esempio, compaiono i Veri Credenti, dei cultisti che aspettano l’imminente discesa di astronauti provenienti da Saturno che li portino via; la zia Fanny si prepara alla sopravvivenza studiando i manuali dei boy scout e testi elementari di ingegneria, chimica ed erboristeria, ma il resto della famiglia preferirà invece bruciare tutta la biblioteca sul barbecue, riempiendo lo spazio libero con scorte di antistaminici, kit di garze e cerotti, caffè istantaneo, creme solari, carta igienica, citronella e sigarette. Il libro non svela se la profezia sarà veridica o meno, ma termina con gli Halloran – almeno la maggior parte di loro – ancora barricati in casa in trepida attesa. La Jackson dichiarò che questo era fra tutti i suoi, il romanzo preferito, perché si era divertita a scriverlo più di qualsiasi altro.
Altre opere minori che ebbero un largo successo negli anni Cinquanta, ma sono oggi quasi del tutto dimenticate, sono i memoriali umoristici e casalinghi di vita familiare degli Hyman/Jackson. Quanto di più remoto dall’unheimlichkeit dei romanzi principali si possa immaginare – una vera dissociazione schizofrenica, secondo alcuni, fra homely e unhomely: chi aveva maneggiato senza esitare stupri, omicidi, delirio e follia, ora si muoveva garbatamente fra pannolini, festicciole di compleanno e torte di mele.
Il primo è Life Among the Savages, concepito per aprirsi un mercato di collaborazioni lucrative ai giornali per signore, come Good Housekeeping o Woman’s Good Companion, e ai periodici generalisti, come Harper’s e Collier’s. Dopo il grande successo presso un ampio pubblico di lettori entusiasti delle cronache delle adorabili buffonate (basate su fatti veri ma spesso  assai infiorettati e abbelliti) di Laurie, Jannie, Sally e Barry, le quattro piccole pesti della famiglia, a queste si aggiunse il seguito Raising Demons, con i ragazzi già cresciuti e un diverso atteggiamento nei riguardi della figura del marito, quasi assente o presentato come mansueto pasticcione e imbranato nel primo libro, ma in termini molto più acidi e meno tolleranti nel secondo.
assai infiorettati e abbelliti) di Laurie, Jannie, Sally e Barry, le quattro piccole pesti della famiglia, a queste si aggiunse il seguito Raising Demons, con i ragazzi già cresciuti e un diverso atteggiamento nei riguardi della figura del marito, quasi assente o presentato come mansueto pasticcione e imbranato nel primo libro, ma in termini molto più acidi e meno tolleranti nel secondo.
In qualche modo questi testi possono ricordare altri classici resoconti delle gioie della vita domestica in lingua inglese, come la trilogia familiare di Gerald Durrell (La mia famiglia e altri animali, L’isola degli animali e Il giardino degli dei), anche nel voler omettere – barando rispetto alle intenzioni realistiche – tutti gli aspetti dolorosi, sgradevoli, conflittuali per soffermarsi solo su quelli, divertenti, pittoreschi e allegri: a differenza delle opere maggiori, esaltare il positivo anziché esplorare il negativo.
Shirley aveva inventato il cosiddetto mommy blog, ma la sua raffinatezza di scrittrice emerge anche qui: nella graduazione di un effetto climax costruito su dettagli accuratamente scelti, nell’ironico understatement, nell’incantata ripetizione di frasi chiave, nella sicura consapevolezza di dove iniziare e dove finire. Inoltre la maternità non è mai sentimentalizzata o idealizzata, né lo sono i bambini.
Proprio in quegli stessi anni in cui la all–american family degli Hyman passava alle cronache letterarie con le sue amenità domestiche, l’FBI avviava un’inchiesta su di loro per presunta attività comunista: i vicini di casa avevano denunciato, sbirciando la biblioteca casalinga, testi di Lenin, Stalin e annate della rivista The New Masses. L’investigazione sarebbe continuata per ben due anni, e per fortuna della coppia, non sarebbe mai emersa l’effettiva iscrizione giovanile di Hyman al Partito Comunista dei tempi della Syracuse University, anche se i tabulati delle telefonate dimostrarono la loro frequentazione di ben noti Reds già schedati nella lista nera, come Walter Bernstein o Jay Williams.
Alcuni colleghi o impiegati del Bennington College testimoniarono dicendo che, sebbene non provassero affatto simpatia per entrambi i coniugi, non avevano mai osservato da parte loro alcuna indicazione di attività o associazione che potessero mettere in dubbio la loro lealtà verso la nazione.
Proprio mentre l’FBI chiudeva, fortunatamente senza conseguenze, il suo dossier su Hyman, la Jackson iniziava un libro che, in metafora, denunciava le persecuzioni del 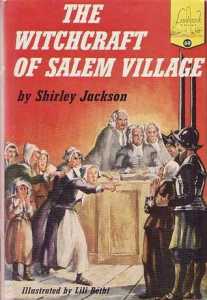 senatore Joseph McCarthy. The Witchcraft of Salem Village, uscito nel 1956. Le fu commissionato come testo storico per young–adults ma, sebbene l’autrice abbia saputo scrivere nei suoi ultimi anni due deliziose storie per bambini (Nine Magic Wishes del 1963 e Famous Sally pubblicato postumo nel 1970), il tono intermedio non le veniva troppo naturale.
senatore Joseph McCarthy. The Witchcraft of Salem Village, uscito nel 1956. Le fu commissionato come testo storico per young–adults ma, sebbene l’autrice abbia saputo scrivere nei suoi ultimi anni due deliziose storie per bambini (Nine Magic Wishes del 1963 e Famous Sally pubblicato postumo nel 1970), il tono intermedio non le veniva troppo naturale.
Il libro quindi approfondisce con dovizia di analisi e di particolari fin troppo circostanziati i fatti avvenuti nel 1692 durante la witch frenzy che sconvolse la cittadina di Salem nel Massachussetts: le predicazioni fanatiche di Cotton Mather e dei suoi accoliti, la catena di delazioni da parte dei concittadini, l’accanimento contro le donne, l’isteria e i casi di possessione diffusi epidemicamente, i processi, le testimonianze e le ritrattazioni generate dal sospetto e dalla paura, l’esecuzione di 20 persone che proclamarono fino all’ultimo la propria innocenza, i molti scampati all’impiccagione morti in seguito in carcere. “Non siamo più tolleranti o più intrepidi della gente di Salem e ancora vogliamo combattere contro un nemico immaginario”, scrisse Shirley rassegnata. “Chi impiccò e torturò il suo prossimo lo fece nella profonda convinzione di averne il diritto. Alcune delle nostre convinzioni più profonde potrebbero essere altrettanto false. Potremmo dire che abbiamo molto più da temere oggi di quanto mai abbia sognato la gente di Salem, ma non sarebbe la verità. Dobbiamo temere esattamente la stessa cosa – il demone nelle menti degli uomini che incita all’odio, alla rabbia, alla paura, un demone irrazionale che mostra un diverso volto a ogni generazione, ma non cessa mai la sua lotta per conquistare il mondo”.
Il messaggio lanciato ai giovani lettori era inequivocabile.
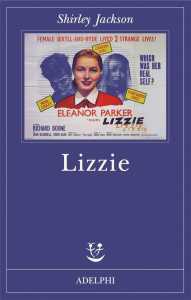 I romanzi della Jackson tradotti in italiano – tutti pubblicati da Adelphi – sono tre: The Bird’s Nest del 1954 (qui intitolato Lizzie, come il film con Eleanor Parker che Hugo Haas ne trasse nel 1957, e che è stato tradotto come La donna delle tenebre); The Haunting of Hill House, del 1959 (adattato come L’incubo di Hill House, ma oltre all’edizione Adelphi è ancora reperibile la vecchia traduzione per Urania del 1979, con il titolo La casa degli invasati, che riprende Gli invasati del titolo italiano del film The Haunting, con Julie Harris e Claire Bloom, diretto da Robert Wise.
I romanzi della Jackson tradotti in italiano – tutti pubblicati da Adelphi – sono tre: The Bird’s Nest del 1954 (qui intitolato Lizzie, come il film con Eleanor Parker che Hugo Haas ne trasse nel 1957, e che è stato tradotto come La donna delle tenebre); The Haunting of Hill House, del 1959 (adattato come L’incubo di Hill House, ma oltre all’edizione Adelphi è ancora reperibile la vecchia traduzione per Urania del 1979, con il titolo La casa degli invasati, che riprende Gli invasati del titolo italiano del film The Haunting, con Julie Harris e Claire Bloom, diretto da Robert Wise.
Esiste poi anche un imbarazzante e ridicolo remake del 1999, di Jan de Bont con Liam Neeson e recentemente al libro si è ispirata anche un’omonima serie TV diretta da Mike Flanagan, molto ben fatta ma che stravolge completamente il testo); We Have Always Lived in the Castle del 1962 (Abbiamo sempre vissuto nel castello per Adelphi, ma nel 1990 già la Mondadori nella collana Mystbooks l’aveva tradotto come Così dolce, così innocente. Del romanzo esistono una trasposizione teatrale e un musical, oltre a un recente, mediocre, film diretto nel 2018 da Stacie Passon).
Lizzie affronta in apparenza il tema psichiatrico della personalità multipla, ma rivela piuttosto l’incertezza femminile riguardo alla propria identità e al proprio ruolo – moglie, madre, professionista – in una cultura a predominanza maschile come quella degli USA degli anni Cinquanta, che glorifica la stabilità della famiglia tradizionale e percepisce come minaccia l’inserimento della donna nel mondo del lavoro: il drammatico conflitto di volontà tra un dottore maschio che vuole curare una paziente secondo i propri termini di riferimento e le molteplici personalità di lei che non si faranno sottomettere facilmente.
Quando Elizabeth Richmond, giovane segretaria in un museo cittadino, raggiunge la scrivania del suo ufficio un lunedì mattina, il muro è crollato e il palazzo si sta inclinando verso le proprie fondamenta allentate, un buco ne rivela lo scheletro interno: il crollo – immaginario o reale dell’edificio – e la frattura dell’equilibrio mentale di Elizabeth hanno una relazione metaforica diretta se non un effettivo rapporto di causa ed effetto. Elizabeth, ragazza timida, anodina, solitaria, vive dalla morte della madre, quattro anni prima, con la fin troppo energica zia Morgen, donna anziana e non bella che riserva un inspiegato rancore verso la sorella scomparsa.
Ma la placida superficie della loro vita in comune, viene turbata da fatti inspiegabili: Elizabeth è afflitta da continui mal di testa e riceve minacciose e misteriose lettere sul lavoro, esce di notte senza serbarne memoria e invitata una sera da amici con zia Morgen li insulta ripetutamente senza conservare apparentemente coscienza dell’accaduto. Condotta da Victor Wright, attempato psichiatra che ha in uggia la psicanalisi, e da questi ipnotizzata, Elizabeth rivela altre due personalità, una calma, disponibile e attraente, l’altra volgare e selvaggia che dileggia il terapeuta chiamandolo Dottor Wrong che è l’autrice delle lettere minatorie rivolte all’altra sé stessa.
Non si tratta di possessione, anche se ne avrebbe tutto l’aspetto: secondo il dottore, che cita The Dissociation of a Personality di Morton Prince, tali frammentazioni psichiche avvengono di norma in conseguenza di un trauma e Wright pensa si tratti per Elizabeth della morte della madre, evento in cui la ragazza è implicata in modo non ancora chiaro. Wright si rende poi conto che il suo compito è riassemblare in una sola le diverse personalità scisse, come prefigura la nursery rhyme che dà il titolo al romanzo: “Elizabeth, Beth, Betsy and Bess / All went together to find a bird’s nest”. Dopo l’emersione di una quarta personalità, il Dott. Wright comincia a chiamare i frammenti psichici scissi della ragazza con quegli stessi nomi: Elizabeth, la persona originale scialba e opaca; Beth, attraente e ben disposta; Betsy, infantile, volgare e crudele; Bess, fatua e avida. Come The Sundial, pubblicato quattro anni dopo, anche Lizzie contiene numerose scene comiche: per esempio la zia Morgen che prepara quattro tazze di caffè, una per ogni personalità della nipote, o discorre con ognuna di loro mentre queste a turno si fanno il bagno quattro volte di seguito. Anche il Dottor Wright – predecessore del Dottor Montague, l’investigatore psichico di Hill House – è spesso ridicolo: crede di fare il meglio per la sua paziente ma sempre secondo le proprie regole, inconsapevolmente interessate; si atteggia a cavaliere che deve salvare Beth – la personalità più seducente – come damsel in distress e vede invece l’insipida Elizabeth come “un recipiente vuoto” che è suo dovere riempire.
In un vero tour de force stilistico il romanzo – narrato da quattro diversi punti di vista: Elizabeth, il dottor Wright, Betsy, la zia Morgen – giunge a una conclusione apparentemente rassicurante e normalizzante, tutto è bene quel che finisce bene: ma quella norma così faticosamente ristabilita è davvero “normale”? Forse, suggerisce l’explicit idilliaco in cui ogni contrasto si ricompone nella posticcia restaurazione dei ruoli – padre, il dottor Wright; madre, zia Morgen; figlia, la nuova Elizabeth ricomposta – tutte le donne degli anni ’50 sono virtualmente schizofreniche, recluse consenzienti nella loro gabbia. Con sottile e garbata malizia il romanzo è dedicato al marito di Shirley, Stanley Edgar Hyman.
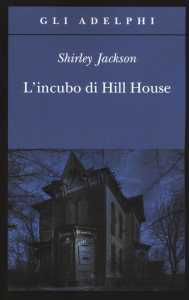 Gli ultimi due libri pubblicati in Italia rappresentano i capolavori assoluti della Jackson. Gli incipit di entrambi sono, insieme a quello del Moby Dick di Herman Melville e a quelli di un paio di racconti di Poe, forse quanto di più raffinato e perfetto la prosa statunitense abbia saputo produrre negli ultimi due secoli. Ci si permetta di riprodurli in inglese e in traduzione:
Gli ultimi due libri pubblicati in Italia rappresentano i capolavori assoluti della Jackson. Gli incipit di entrambi sono, insieme a quello del Moby Dick di Herman Melville e a quelli di un paio di racconti di Poe, forse quanto di più raffinato e perfetto la prosa statunitense abbia saputo produrre negli ultimi due secoli. Ci si permetta di riprodurli in inglese e in traduzione:
“No live organism can continue for long to exist sanely under conditions of absolute reality; even larks and katydids are supposed, by some, to dream. Hill House, not sane, stood by itself against its hills, holding darkness within; it had stood so for eighty years and might stand for eighty more. Within, walls continued upright, bricks met neatly, floors were firm, and doors were sensibly shut; silence lay steadily against the wood and stone of Hill House, and whatever walked there, walked alone.”
“Nessun organismo vivente può mantenersi a lungo sano di mente in condizioni di assoluta realtà; perfino le allodole e le cavallette sognano, a detta di alcuni. Hill House, che sana non era, si ergeva sola contro le sue colline, chiusa intorno al buio; si ergeva così da ottant’anni e avrebbe potuto continuare per altri ottanta. Dentro, i muri salivano dritti, i mattoni si univano con precisione, i pavimenti erano solidi, e le porte diligentemente chiuse; il silenzio si stendeva uniforme contro il legno e la pietra di Hill House, e qualunque cosa si muovesse lì dentro, si muoveva sola.” (da L’incubo di Hill House)
 “My name is Mary Katherine Blackwood. I am eighteen years old, and I live with my sister Constance. I have often thought that with any luck at all, I could have been born a werewolf, because the two middle fingers on both my hands are the same length, but I have had to be content with what I had. I dislike washing myself, and dogs, and noise. I like my sister Constance, and Richard Plantagenet, and Amanita phalloides, the death–cup mushroom. Everyone else in our family is dead.”
“My name is Mary Katherine Blackwood. I am eighteen years old, and I live with my sister Constance. I have often thought that with any luck at all, I could have been born a werewolf, because the two middle fingers on both my hands are the same length, but I have had to be content with what I had. I dislike washing myself, and dogs, and noise. I like my sister Constance, and Richard Plantagenet, and Amanita phalloides, the death–cup mushroom. Everyone else in our family is dead.”
“Mi chiamo Mary Katherine Blackwood. Ho diciott’anni e abito con mia sorella Constance. Ho sempre pensato che con un pizzico di fortuna potevo nascere lupo mannaro, perché ho il medio e l’anulare della stessa lunghezza, ma mi sono dovuta accontentare. Detesto lavarmi, e i cani, e il rumore. Le mie passioni sono mia sorella Constance, Riccardo Cuor di Leone e l’Amanita phalloides, il fungo mortale. Gli altri membri della famiglia sono tutti morti.” (da Abbiamo sempre vissuto nel castello)
 La fama di scrittrice gotica di Shirley Jackson è legata soprattutto a questi due testi, il primo dei quali, confrontandosi con il classico tema horror della casa infestata, è stato accostato, e giustamente, al capolavoro di Henry James Il giro di vite. In questo libro Shirley assomma con potenza dirompente tutti gli elementi della sua duratura ossessione: una donna infelice, sola con il suo inconfessato trauma interiore; la ricerca spasmodica dell’amore di una madre ma contemporaneamente il rifiuto radicale del suo controllo; il rapporto contraddittorio con il retaggio delle precedenti generazioni; il soprannaturale inteso come emersione dall’inconscio di paure e desideri repressi. Il parallelo con “Il giro di vite” di James risiede soprattutto nell’analoga, suprema e irrisolta ambiguità – l’elemento principale di quell’unheimlich che da Sigmund Freud a Mark Fisher, costituisce l’essenza numinosa del fantastico narrativo. I fantasmi – nella casa di Flora e Miles a Bly nell’Essex, come nella labirintica Hill House – ci sono davvero o sono solo la proiezione di una mente disturbata? La grandezza di James e della Jackson è di lasciare la domanda enigmaticamente senza risposta: ogni lettore avrà la sua personale opinione in proposito.
La fama di scrittrice gotica di Shirley Jackson è legata soprattutto a questi due testi, il primo dei quali, confrontandosi con il classico tema horror della casa infestata, è stato accostato, e giustamente, al capolavoro di Henry James Il giro di vite. In questo libro Shirley assomma con potenza dirompente tutti gli elementi della sua duratura ossessione: una donna infelice, sola con il suo inconfessato trauma interiore; la ricerca spasmodica dell’amore di una madre ma contemporaneamente il rifiuto radicale del suo controllo; il rapporto contraddittorio con il retaggio delle precedenti generazioni; il soprannaturale inteso come emersione dall’inconscio di paure e desideri repressi. Il parallelo con “Il giro di vite” di James risiede soprattutto nell’analoga, suprema e irrisolta ambiguità – l’elemento principale di quell’unheimlich che da Sigmund Freud a Mark Fisher, costituisce l’essenza numinosa del fantastico narrativo. I fantasmi – nella casa di Flora e Miles a Bly nell’Essex, come nella labirintica Hill House – ci sono davvero o sono solo la proiezione di una mente disturbata? La grandezza di James e della Jackson è di lasciare la domanda enigmaticamente senza risposta: ogni lettore avrà la sua personale opinione in proposito.
Tutti i grandi dell’horror e del fantastico hanno guardato al romanzo come a un modello ineguagliato, Ray Bradbury, Stephen King, Neil Gaiman; Richard Matheson ha persino composto una sua personale reinvenzione della storia, La casa d’inferno (1971), in cui parapsicologi e spiritisti si sfidano a dimostrare le loro tesi contrapposte – una razionalista, l’altra sovrannaturale – sul campo, confrontandosi con i fenomeni misteriosi in una casa ugualmente demoniaca: ma il romanzo fallisce proprio nella sua mancanza di ambiguità; i fantasmi ci sono davvero, Matheson, assume un punto di vista preciso, spiega, dà una risposta univoca e la risposta non convince: Matheson crede all’infestazione, il lettore no.
 Hill House – luogo che contiene incubi e li rende manifesti, in cui le fantasie di regressione al nucleo originario terminano in eterna solitudine – è forse l’ultima metafora del tormentato, simbiotico, devoto eppure al fondo infelice matrimonio di Shirley. La casa è una forza viva che si adatta ai suoi abitanti e risponde in base alle loro personalità e alle loro storie: pur “non sana”, stabilisce circostanze che, per sovrannaturali che possano apparire, costituiscono “condizioni di assoluta realtà”.
Hill House – luogo che contiene incubi e li rende manifesti, in cui le fantasie di regressione al nucleo originario terminano in eterna solitudine – è forse l’ultima metafora del tormentato, simbiotico, devoto eppure al fondo infelice matrimonio di Shirley. La casa è una forza viva che si adatta ai suoi abitanti e risponde in base alle loro personalità e alle loro storie: pur “non sana”, stabilisce circostanze che, per sovrannaturali che possano apparire, costituiscono “condizioni di assoluta realtà”.
La protagonista Eleonor Vance, trentaduenne che ha passato tutta la sua vita adulta a prendersi cura della madre inferma – la cui recente scomparsa l’ha finalmente liberata dal giogo, ma l’ha costretta a vivere con la sorella che odia – è invitata a unirsi al gruppo di ricercatori che si stabilirà a Hill House e, infelice e solitaria com’è, coglie al volo l’occasione.
Il dottor Montague – figura analoga, anche nella descrizione fisica, al dottor Wright di Lizzie – ha selezionato in base alle precedenti esperienze psichiche verificate in loro, una dozzina di persone: in ultimo ne ha scelte due. Una è Eleonor, che da bambina aveva vissuto un episodio poltergeist, una pioggia di pietre sulla sua casa per tre giorni dopo la morte del padre; l’altra è Theodora, una chiaroveggente con sconcertanti poteri empatici, l’esatta antitesi di Eleonor, un’artista dalla vita bohemienne, solare, allegra e provocante, di tendenze allusivamente lesbiche. Oltre al dottore e alle due medium sarà presente anche Luke Sanderson, l’erede della proprietà, la cui zia – la padrona di Hill House – lo ha inviato, a nome della famiglia, a presenziare alle investigazioni.
La casa ha un passato di catastrofi e di sfortune: la moglie del primo proprietario e costruttore, Hugh Crain, morta per il ribaltamento della sua carrozza nella rimessa; la seconda moglie scomparsa in seguito a una misteriosa caduta; le sue due figlie ed eredi, spietatamente in lotta fra loro per il possesso della proprietà, finché una delle due non si è impiccata alla garitta della torre. Nel cuore della casa, proprio sulla soglia della stanza che un tempo era la nursery, c’è un angolo sempre inspiegabilmente gelato, tipico segnale d’infestazione. Le manifestazioni sovrannaturali iniziano già dalla seconda notte di permanenza: misteriosi colpi alle pareti che ricordano a Eleonor quelli della madre malata che la chiamava dalla camera accanto alla sua, misteriosi messaggi scritti con gesso e sangue sulle pareti che chiedono di aiutare Eleonor a tornare a casa. Quando arriva la moglie di Montague, una buffonesca medium, che tenta di contattare gli spiriti tramite una specie di tavoletta Ouija, il messaggio è di nuovo rivolto a Eleonor: “Cosa vuoi ?” – chiede la medium. “Casa” – le viene risposto. A un certo punto ogni personaggio esprime la propria definizione di paura: “Abbiamo solo paura di noi stessi”, dice il dottor Montague; “Di vederci come siamo senza travestimenti”, dice Luke; “Di sapere quello che davvero vogliamo”, dice Theodora; “Io ho sempre paura di essere sola”, dice Eleonor. Proprio la notte successiva Eleonor si sveglia all’improvviso stringendo la mano di Theodora, addormentata accanto a lei; la voce di un bambino piagnucola: “Ti prego non farmi male. Ti prego fammi tornare a casa”. Eleonor urla e accende la luce rendendosi conto che Theodora non dormiva accanto a lei ma in un letto all’altro capo della stanza. “Mio Dio, la mano di chi stavo stringendo?” – si chiede Eleonor. L’episodio non è solo un eccezionale causa di brividi per il lettore, ma una metafora estremamente esplicita. “La paura e la colpa sono sorelle” dirà il dottor Montague, ed Eleonor confesserà di aver ignorato il richiamo della madre la notte prima della sua morte, così Shirley elaborerà il velenoso rapporto con Geraldine, sua madre, le cui insistenti e spietate critiche l’avevano condizionata ad accettare di essere sminuita e tradita da Stanley, l’estraneo accanto al quale dormiva da anni. “La mano di chi stavo stringendo?” – Nella splendida biografia Shirley Jackson: A Rather Haunted Life – alla quale sono debitore di gran parte delle notizie, aneddoti e citazioni qui riportate – l’autrice Ruth Franklin riferisce che nella conferenza “Experience and Fiction”, parlando di Hill House, la Jackson racconta di aver avuto degli episodi di sonnambulismo, durante la composizione del romanzo, una mattina ha ritrovato sulla sua scrivania, scarabocchiate sulla carta gialla dove amava scrivere le sue opere, le parole “Dead Dead”, ma – aggiunge la Franklin – nell’archivio di appunti e abbozzi relativi al romanzo, questo foglio non è mai stato ritrovato: ce n’è invece un altro molto simile alla descrizione ma in cui sono scarabocchiate le parole “Family Family”. “La casa è Eleonor”, spiegò Jackson nello stesso testo, puntualizzando di non credere ai fantasmi: Eleonor che indulge in fantasie domestiche, che s’immagina in varie case viste durante il tragitto in auto verso la sua destinazione infestata, creando per ognuna una diversa situazione, una diversa famiglia; che mente al gruppo inventandosi la descrizione del suo appartamento ideale nel quale sostiene di abitare. Perfino Theodora ignorerà la sua richiesta di andare ad abitare insieme una volta lasciata Hill House: Eleonor così non ha alcun posto dove tornare, la sua paura di restare sola può acquietarsi solo arrendendosi a Hill House. “Sono a casa, sono a casa” penserà nei suoi ultimi momenti mentre guida a folle velocità intorno all’edificio, prima di andarsi a schiantare contro un albero. Ma il romanzo si chiude con le stesse parole dell’inizio: le fantasie di unità di Eleonor non saranno mai soddisfatte, così come la vana speranza di Shirley che il matrimonio avrebbe posto fine alla sua solitudine. Non c’è posto per Eleonor neanche fra i fantasmi di Hill House, con i quali s’immaginava in comunione. Qualunque cosa cammini là dentro, ancora cammina sola. L’unico momento in cui Eleonor ci ha svelato la sua vera natura repressa, il suo desiderio eternamente frustrato, è nello splendido episodio dell’incontro casuale con la bambina intravista in un ristorante: la piccola non vuole bere il tè in una tazza qualsiasi ma reclama la sua cup of stars e la madre cerca di convincerla a non fare i capricci e a bere lo stesso: “Non farlo, disse Eleonor alla bambina; insisti per avere la tua tazza di stelle; una volta che ti hanno incastrata e costretta ad essere come loro, non vedrai mai più la tua tazza di stelle; non farlo; e la bambina le lanciò un’occhiata e le fece un sorrisetto scaltro, tutto fossette, assolutamente consapevole e scosse la testa in direzione del bicchiere, cocciuta. Intrepida bambina, pensò Eleonor; saggia, intrepida bambina”.
Abbiamo sempre vissuto nel castello è raccontato interamente dalla prospettiva di Mary Katherine Blackwood (Merricat, come la chiama la sorella), il personaggio più ambiguo inventato da Shirley Jackson. Ha diciotto anni – ma ragiona come una bambina – vive con la sorella Constance e con lo zio invalido Julian, nella vecchia magione di famiglia: il resto dei Blackwood sono morti, avvelenati sei anni prima alla tavola da pranzo da qualcuno che ha messo dell’arsenico nella zucchero usato per insaporire le more servite come dessert. Il fatto che Constance, adorata da Merricat e che non usa mettere lo zucchero sulle more, sia l’unica sopravvissuta indica la sorellina come evidente colpevole, ma la sorella maggiore per proteggere la più piccola si prende la colpa, lava la zuccheriera per cancellare le prove e sostiene il processo. Viene assolta ma, nonostante questo (o forse proprio per questo), gli abitanti del villaggio ostracizzano la famiglia, e i bambini dileggiano le sorelle con sinistre nursery rhyme:
“Merricat, said Connie, would you like a cup of tea?
Oh no, said Merricat, you’ll poison me.
Merricat, said Connie, would you like to go to sleep?
Down in the boneyard ten feet deep!”
Le due ragazze sono del tutto autosufficienti, Constance si occupa della cucina – perché a Merricat è proibito maneggiare il cibo – e insieme si dedicano alle altre faccende domestiche conservando la casa nell’esatto stato in cui l’avevano lasciata i genitori. La sicurezza del loro rifugio è però infranta dall’arrivo del cugino Charles, che proclama interesse romantico per Constance, ma è in realtà interessato a prendere possesso della proprietà e del denaro della famiglia che vi è nascosto. Merricat, gelosa e preoccupata di perdere Constance e le loro abitudini di vita, osteggia in ogni modo Charles e alla fine, forse accidentalmente, appicca il fuoco alla casa buttando la pipa ancora accesa di Charles dentro un cestino pieno di giornali. I pompieri del villaggio arrivano in tempo per salvare il primo piano, ma il comandante togliendosi il berretto da ufficiale, guida gli abitanti del paese in un selvaggio saccheggio della casa. Le sorelle si nascondono in giardino mentre i vicini frantumano a pietrate le finestre, spaccano mobili e porcellane, distruggono l’arpa di Constance. Il cugino non interviene né difende le parenti, anzi invita i razziatori a risparmiare la cassaforte in cui le sorelle tengono il denaro. Il fuoco ha comunque svolto la funzione di un rituale di purificazione e l’ira dei paesani contro i Blackwood è acquietata. Le sorelle si riorganizzano con i mobili e le suppellettili superstiti mentre i vicini, adesso non più ostili, lasciano periodicamente offerte espiatorie di cibo sulla soglia. “Saremo molto felici ora” conclude Merricat. Ancora più che per Hill House, la Jackson non solo ha lasciato gli elementi più spaventosi della vicenda appena accennati, ma ha pervaso tutti gli episodi di un senso profondo d’inspiegato mistero. La descrizione dettagliata del villaggio invece ricorda da vicino Bennington ed è evidente che le esperienze di Merricat in paese riflettono quelle di Shirley. Come le presunte streghe di Salem, Merricat e Constance sono delle estranee che vivono una vita fuori dalle convenzioni e sono vulnerabili alla malevolenza e al pettegolezzo – lo stesso status sociale che Shirley sentiva di avere a Bennington: l’essenza stregonesca di Merricat è rafforzata dalla presenza di un gatto nero al suo fianco, il fedele Jonas, al quale spesso parla, come Shirley faceva con i suoi gatti. La stregoneria è ancora metafora del potere femminile e della paura dell’uomo nei suoi confronti. Il centro della casa, come l’angolo gelido nella nursery di Hill House, è stavolta la cucina: le arti domestiche, come le arti nere, esprimono la possibilità di un controllo sull’ambiente; la scopa e la pentola, simboli dell’asservimento casalingo sono anche liberatori simboli stregoneschi, fonti ambivalenti d’interesse e d’ansia per la Jackson stessa. La prigione in cui le protagoniste si rinchiudono alla fine è una prigione da loro stesse creata e nella quale si sono chiuse volontariamente, la loro felicità finale sarà solo loro, diversa da quella prevista dal paradigma matrimoniale consueto.
Il riconoscimento dei critici verso il romanzo è unanime, e la Jackson – “che non ha bisogno di fantasmi, lupi mannari e clangore di catene per suggerire l’orrore”… “sa trovarlo dove esiste davvero, nei passaggi segreti della mente umana”… “scrive come un angelo toccato da un demone”… – viene paragonata a Edgar Allan Poe, William Faulkner, Fëdor Dostoevski, Henry James, Karen Blixen. Ma il momento di massima soddisfazione per la scrittrice, vede la donna attraversare uno dei periodi più infelici della propria vita: il marito Stanley vive la più intensa delle sue relazioni per l’ex allieva Barbara Karmiller, una rossa irlandese – giovane, bella, magra, elegante; ha tutto quello che manca a Shirley, che si vede tradita non solo dal marito, ma da una donna che considera un’amica intima. Stanley confesserà a Phoebe Pettingell, l’ex allieva che diventerà la sua seconda moglie, un anno dopo la morte repentina di Shirley, che oltre alle due mogli, Barbara è stata l’unica donna che abbia mai veramente amato, sebbene la loro relazione sia stata più emozionale che sessuale. Shirley cade in depressione, non scrive quasi più per due anni, beve troppo, è soggetta a crisi di panico e agorafobia: uscire di casa diventa per lei un’impresa eroica; gli incubi notturni che l’hanno afflitta nei momenti critici della sua vita – in cui spesso le appare il Daemon Lover che infesta buona parte della sua narrativa – si ripresentano. Senza abbandonare il suo uso quotidiano e nefasto di tranquillanti e iniezioni sedative, decide di sottoporsi a una terapia psichiatrica da un medico di New York, James Toolan: ce l’accompagnano proprio Barbara – che guida l’auto – e Stanley, che le tiene la mano durante il viaggio. Nel giro di pochi appuntamenti l’ansia decresce, la cura funziona, Shirley riprende faticosamente la sua routine ordinaria e riesce a raggiungere lo studio del dottore da sola: ogni passo avanti è seguito da un forte contraccolpo di terrore, tremito e mancanza di respiro. Stanley, che si sente in colpa, è sempre disponibile e con l’aiuto suo e del bourbon, la scrittrice riesce con grande sforzo a terminare un breve ciclo di conferenze e a presenziare alla prima del film Gli invasati di Robert Wise, a New York. Il tormentato ritorno all’attività creativa riprende a poco a poco con i due libri per bambini, Nine Magic Wishes, che viene pubblicato nel 1963, e Famous Sally, che per il momento resta inedito. Shirley si abbandona anche a una sorta di scrittura automatica, un diario che per lei svolge un ruolo terapeutico: in esso non c’è posto per riflessioni letterarie o politiche – sull’assassinio di John F. Kennedy, che avviene proprio in quel periodo, per esempio, mai menzionato – ma solo per i suoi problemi personali, il suo rapporto con Stanley e Barbara, le sue fantasie di andarsene da casa portandosi via i figli più piccoli (12 e 15 anni), e, soprattutto, la convinzione che esista un’uscita dal tunnel e sia la scrittura: la possibilità di un nuovo libro, un libro felice stavolta, “un libro buffo, un libro allegro, in uno stile nuovo”. Il diario termina con un’unica frase ripetuta più volte: “ridere è possibile, ridere è possibile, ridere è possibile”.
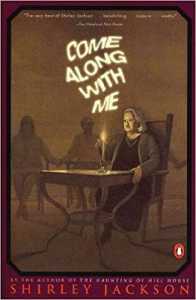 Come Along with Me, è l’ultima opera scritta da Shirley Jackson, rimasta purtroppo inconclusa a causa della morte improvvisa dell’autrice. È davvero un libro nuovo, diverso da tutti gli altri e scritto in uno stile differente. Un libro comico, con una protagonista senza nome che ricorda molto la Jackson stessa: una donna di mezza età, poco attraente e molto sovrappeso (“44 sia di età che di misura” – annuncia nella prima pagina), che “si diletta col soprannaturale”. Il marito è morto da poco e lei – libera – si sta per trasferire in una nuova città dove iniziare una nuova vita: una Merricat adulta, che si è sposata ed è uscita di casa, e che si inventa nomi fittizi per divertimento: Angela Motorman; che ha chiuso tutti i possedimenti del marito morto (in circostanze non specificate) nel granaio, in caso “possa tornare indietro a reclamarli un giorno, come fanno qualche volta”, compresi i suoi quadri (“Che pittore del cavolo, era !”); ha venduto tutti i mobili e ha preso un treno a caso, diretta verso la prima città in itinerario; ha preso alloggio in una pensione facendo amicizia con la proprietaria, Mrs. Faun, con la quale si concede spesso tè e pasticcini. Una donna bonaria, che non conta le calorie e che se ha poteri soprannaturali, li possiede in forma quanto mai rassicurante e domestica: da bambina indovinava chi era al telefono prima che suonasse e vedeva le stesse creature che vedeva il suo gatto sotto il tavolo da pranzo. Quando decide di fare una seduta spiritica per gli ospiti della pensione, Mrs. Faun da principio si preoccupa, ma lei la rassicura: “è come fare un’interurbana. Una volta che riattacchi è finita”. Ci restano solo 75 pagine dattiloscritte dell’opera e non è chiaro dove l’autrice volesse andare a parare: non esiste un vero e proprio intreccio, ma solo una serie di episodi e un unico narratore, insolito e allegro. Purtroppo non leggeremo mai il libro felice di Shirley.
Come Along with Me, è l’ultima opera scritta da Shirley Jackson, rimasta purtroppo inconclusa a causa della morte improvvisa dell’autrice. È davvero un libro nuovo, diverso da tutti gli altri e scritto in uno stile differente. Un libro comico, con una protagonista senza nome che ricorda molto la Jackson stessa: una donna di mezza età, poco attraente e molto sovrappeso (“44 sia di età che di misura” – annuncia nella prima pagina), che “si diletta col soprannaturale”. Il marito è morto da poco e lei – libera – si sta per trasferire in una nuova città dove iniziare una nuova vita: una Merricat adulta, che si è sposata ed è uscita di casa, e che si inventa nomi fittizi per divertimento: Angela Motorman; che ha chiuso tutti i possedimenti del marito morto (in circostanze non specificate) nel granaio, in caso “possa tornare indietro a reclamarli un giorno, come fanno qualche volta”, compresi i suoi quadri (“Che pittore del cavolo, era !”); ha venduto tutti i mobili e ha preso un treno a caso, diretta verso la prima città in itinerario; ha preso alloggio in una pensione facendo amicizia con la proprietaria, Mrs. Faun, con la quale si concede spesso tè e pasticcini. Una donna bonaria, che non conta le calorie e che se ha poteri soprannaturali, li possiede in forma quanto mai rassicurante e domestica: da bambina indovinava chi era al telefono prima che suonasse e vedeva le stesse creature che vedeva il suo gatto sotto il tavolo da pranzo. Quando decide di fare una seduta spiritica per gli ospiti della pensione, Mrs. Faun da principio si preoccupa, ma lei la rassicura: “è come fare un’interurbana. Una volta che riattacchi è finita”. Ci restano solo 75 pagine dattiloscritte dell’opera e non è chiaro dove l’autrice volesse andare a parare: non esiste un vero e proprio intreccio, ma solo una serie di episodi e un unico narratore, insolito e allegro. Purtroppo non leggeremo mai il libro felice di Shirley.
Pochi mesi prima della morte Shirley Jackson aveva reso omaggio in Georgia a Flannery O’Connor – scomparsa da poco per lupus a soli trentanove anni, una scrittrice per molti aspetti a lei così affine – e visitato la sua casa e il suo famoso allevamento di pavoni. Anche Sylvia Plath, suicidatasi a Londra due anni prima, aveva scritto il suo romanzo La campana di vetro sotto l’influenza della lettura di Hangsaman e aveva cercato senza fortuna di incontrare Shirley Jackson a New York nel 1953: entrambe avevano tentato il suicidio a 19 anni, Shirley stava attraversando il primo dei suoi molti esaurimenti nervosi all’Università di Rochester. Purtroppo Sylvia a differenza di Shirley aveva insistito. Queste donne, queste artiste, hanno nobilitato, tragicamente, la migliore letteratura al femminile portando il peso della loro sensibilità e della loro condizione: è bello sapere che, pur non essendosi mai incontrate, si conoscessero e si stimassero: la Santa Intelligente, la Strega Buona e Lady Lazarus, unite in un unico destino di dolore e di grandezza.

Romanzi
The Road Through the Wall, Farrar, Straus, 1948
Hangsaman, Popular Library, 1951
Lizzie (The Bird’s Nest, 1954), tr. Laura Noulian, Adelphi, 2014
The Sundial, Farrar, Straus & Cuddahy, 1958
L’incubo di Hill House (The Haunting of Hill House, 1959), tr. Monica Pareschi, Adelphi, 2004
Abbiamo sempre vissuto nel castello (We Have Always Lived in the Castle, 1962), tr. Monica Pareschi, Adelphi, 2009
Raccolte
La lotteria (The Lottery and Other Stories,1948), tr. Franco Salvatorelli, Adelphi, 2007 [edizione parziale]. Esiste una traduzione completa come Demoni amanti, tr. Riccardo Valla, Mondadori, 1991
The Magic of Shirley Jackson, New York, Farrar, Straus and Giroux, 1974
Come Along with Me, The Viking Press, 1968
Just an Ordinary Day , Bantam Books, 1995
Let Me Tell You , Penguin Classics, 2016 Paranoia (tr. Monica Pareschi, Adelphi, 2018 [edizione parziale]
Dark Tales, Penguin, 2016
Racconti autobiografici
Life Among the Savages, Farrar, Straus and Young, 1953
Raising Demons, Farrar, Straus and Cudahy, 1957
Narrativa per ragazzi
The Witchcraft of Salem Village, Landmark Books, Random House, 1956
The Bad Children , Chicago, Dramatic Pub. Co.,1959 (opera musicale)
Nine Magic Wishes (1963)
Famous Sally , London, 1970
Filmografia e rappresentazioni teatrali
Il racconto “La lotteria” è stato portato tre volte sullo schermo. Nel 1969 si ricorda il cortometraggio di Larry Yust realizzato per una serie educativa dell’Encyclopædia Britannica (https://www.youtube.com/watch?v=vQQoMCaUz5Y). Nel 1996 è la volta del lungometraggio Il complotto, diretto da Daniel Sackheim, e infine dello short diretto da Augustin Kennady nel 2007. Una serie di altri cortometraggi sono reperibili in rete.
 Nel 1957, Huho Haas dirige La donna delle tenebre (la versione italiana di Lizzie), tratto dal romanzo Lizzie (The Bird’s Nest). Eleanor Parker, nel ruolo della protagonista, interpreta i vari ruoli che corrispondono alle diverse personalità di Elizabeth. Il film presenta molte somiglianze con La donna dai tre volti (The Three Faces of Eve), diretto da Nunnally Johnson, sempre girato nel 1957, che però si ispira a un soggetto di Corbett Thigpen e Hervey M. Cleckley.
Nel 1957, Huho Haas dirige La donna delle tenebre (la versione italiana di Lizzie), tratto dal romanzo Lizzie (The Bird’s Nest). Eleanor Parker, nel ruolo della protagonista, interpreta i vari ruoli che corrispondono alle diverse personalità di Elizabeth. Il film presenta molte somiglianze con La donna dai tre volti (The Three Faces of Eve), diretto da Nunnally Johnson, sempre girato nel 1957, che però si ispira a un soggetto di Corbett Thigpen e Hervey M. Cleckley.
 Nel 1963, L’incubo di Hill House venne adattato per il cinema con il titolo Gli invasati (The Haunting), diretto da Robert Wise, mentre nel 2018 Netflix ha prodotto una serie TV la cui prima stagione è ispirata al romanzo di Shirley Jackson e intitolata Hill House.
Nel 1963, L’incubo di Hill House venne adattato per il cinema con il titolo Gli invasati (The Haunting), diretto da Robert Wise, mentre nel 2018 Netflix ha prodotto una serie TV la cui prima stagione è ispirata al romanzo di Shirley Jackson e intitolata Hill House.
Il romanzo scritto nel 1962, Abbiamo sempre vissuto nel castello, venne riadattato per il teatro a metà anni Sessanta da Hugh Wheeler . Diretto dal regista Garson Kanin, esordì a Broadway il 19 ottobre 1966. Nel 2010 è stato trasposto in musical da Adam Bock e Todd Almond. Nel 2018 viene realizzata una versione cinematografica diretta da Stacie Passon.

Come Along with Me è l’adattamento dell’ultimo romanzo incompiuto della Jackson, diretto da Joanne Woodward nel 1982, con Estelle Parsons and Sylvia Sidney.
Biografia
Ruth Franklin, Shirley Jackson: A Rather Haunted Life, Liverlight Publishing Company, New York 2016.



