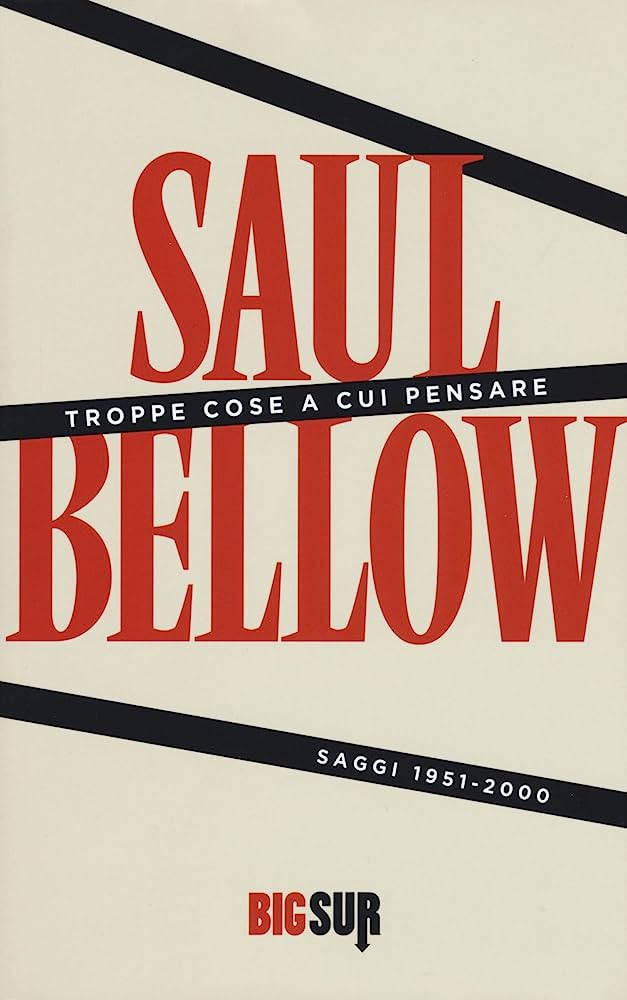Fu proprio Saul Bellow a paragonare in modo provocatorio se stesso, Bernard Malamud e Philip Roth – scrittori la cui cifra narrativa veniva immancabilmente rintracciata nella comune origine ebraica, al punto da farli sentire imprigionati dall’etichetta di “ebrei-americani” – a uno dei marchi sartoriali più esclusivi d’America: quegli Hart, Schaffner & Marx che vestivano la middle class di Chicago sin dai primi del Novecento. Nei toni elegantemente polemici che caratterizzano molta sua produzione saggistica, Bellow intendeva esprimere il proprio “disprezzo verso gli opportunisti, i sapientoni e i carrieristi che impongono queste etichette e ci speculano sopra”, ma per una delle tante ironie della storia è stata proprio la sua, di etichetta, a restare appiccicata ai tre maggiori rappresentanti della letteratura ebraico-americana.
Il riferimento a Hart, Schaffner & Marx compare nel primo saggio del volume Troppe cose a cui pensare, pubblicato da SUR a cura e nell’ottima traduzione di Luca Briasco. In effetti, nei ventuno testi che compongono la raccolta (scelti tra i cinquantasette inclusi nell’edizione americana a cura di Benjamin Taylor, uscita nel 2015), Bellow non risparmia critiche e commenti sarcastici a nessuno, dai critici letterari – “custodi e dottori della letteratura”, che in realtà si limitano a “ridescrivere tutto verso il basso, impoverendo il nostro presente e restringendo lo spazio creativo degli artisti contemporanei” – ai professori universitari e agli intellettuali in genere, il cui compito consiste “nel ridescrivere tutto, di solito rendendolo ancor meno accessibile nel momento in cui fanno subentrare all’immediatezza delle sensazioni e delle reazioni una sequela di atti interpretativi”.
Bersagli privilegiati sono anche i sedicenti “lettori profondi”, in realtà “idolatri della cultura, sofisticati e snob”; l’opinione pubblica, sempre pronta a tributare alle minoranze “un rispetto tutto retorico e fasullo” che sfocia “nella boria, nell’ipocrisia e nella tirannia”; i rappresentanti delle classi agiate, “vicepresidenti di un’azienda durante la giornata di lavoro” e “anarchici o utopisti all’ora dell’aperitivo”, i quali vivono “isolati dalla sporcizia e dai pericoli di New York”.
Nemmeno New York è risparmiata dalle osservazioni acute e sarcastiche di Bellow (che a differenza del suo Augie March non è nato a Chicago, bensì vicino Montreal, in Canada, e poi naturalizzato statunitense): in alcune tra le pagine più suggestive del volume lo scrittore descrive la “parvenza di creatività e di vita letteraria che caratterizza New York”, dietro cui però “non c’è alcuna sostanza”, tra “manipolazioni, giri loschi, lotte di potere […], guerre intestine, reputazioni gonfiate e poi distrutte. Spacconate, veemenza, vanità, mode, simulacri, condizionamenti mentali”. Ma se “gli editor delle riviste letterarie o i professori che organizzano conferenze o simposi annuali si comportano troppo spesso come promotori di incontri pugilistici”, come stupirsi, sembra chiedere Bellow, se alcuni romanzieri “identificano ancora l’azione in una jeep, un fucile da caccia, una bottiglia di whisky o una corrida”?
Il riferimento, piuttosto esplicito, è a Hemingway e ai suoi epigoni, come sottolinea Briasco nella preziosa introduzione al volume, che aiuta il lettore a orientarsi nei testi che di fatto ripercorrono l’intera carriera di Bellow. Nell’introduzione Briasco identifica alcune linee guida della poetica di uno scrittore che non smette di interrogarsi sul “ruolo dell’artista e dell’intellettuale nella società – soprattutto – americana del secondo dopoguerra”, sempre intento a “preservare e rilanciare una visione umanistica dell’arte narrativa come gesto totale”.
Questa selezione di saggi di Bellow (seppur inspiegabilmente non organizzata secondo un ordine cronologico, che avrebbe aiutato non poco il lettore a ricostruire il percorso artistico assolutamente coerente di uno dei più grandi scrittori del Novecento) restituisce un affresco suggestivo e idiosincratico degli anni del cosiddetto “rinascimento ebraico-americano”, inaugurato nel 1952 proprio dalla pubblicazione delle Avventure di Augie March, vincitore del National Book Award e da molti salutato come romanzo seminale di una nuova era letteraria. Negli anni Cinquanta e Sessanta gli scrittori ebrei americani, figli e nipoti di immigrati, incarnano una triplice alienazione: dalla cultura anglo-americana in cui vorrebbero inserirsi e far fortuna ma che inizialmente sembra respingerli; dalla tradizione ebraico-yiddish da cui provengono e che rappresenta l’eredità, spesso ingombrante, dei padri; e dalla letteratura europea che caratterizza in modo significativo la loro formazione intellettuale e artistica. “Non c’è verso”, scrive Bellow in un saggio del 1988, “che la mia esperienza moderna e americana possa riconciliarsi con l’Ebraismo ortodosso”; l’anno prima lamentava il fatto che gli europei lo caratterizzassero “come una sorta di curioso ibrido, né pienamente americano, né abbastanza europeo”, mentre gli americani sentissero “estranei” i suoi libri perché troppo vicini al Vecchio Mondo. A ben guardare, già nel 1964-65 Bellow concludeva “L’arte ebraica del racconto” con una matura presa di coscienza: “Dobbiamo accettare il miscuglio nel quale ci troviamo, in tutta la sua impurità, tragicità e speranza”.
I personaggi dei romanzi di Bellow, di Malamud e, più avanti, di Roth, irrompono sulla scena letteraria statunitense come i leopardi della parabola di Kafka (per usare la famosa similitudine proposta da Morris Dickstein), invadono il tempio e svuotano i vasi sacrificali provocando scompiglio, ma finiscono col tempo per diventare parte integrante del rituale. Dopo aver raggiunto l’apice durante la metà degli anni Sessanta, infatti, la spinta creativa della letteratura ebraico-americana perde man mano l’impulso innovativo e sovversivo che l’aveva posta al centro del panorama letterario. “Al culmine delle conquiste tecnologiche rifulge la minaccia dell’obsolescenza”, scrive Bellow nel 1974, in un saggio che già presagisce il vizio intrinseco della postmodernità: “La mente è messa a repentaglio dalla moltitudine di racconti che è in grado di produrre su qualunque argomento. Rischia l’irrilevanza, o la disintegrazione”.
Cosa resta allora, viene da chiedersi, in uno scenario in cui “lo scrittore non è in grado di capire con chiarezza quale sia la sua funzione”? Quale strada dovrebbe imboccare l’arte per redimere un mondo dove “esistono tanto la grandezza dell’uomo, quanto la grandezza della sua imbecillità, ed entrambe sono eterne”? Bellow l’umanista non ha dubbi: il compito dello scrittore “consiste ancora nel fissare un ordine di importanza e preservare un valore umano originale, proteggendolo dagli stili, i linguaggi, le forme, le astrazioni, come anche dall’assalto e dalla distrazione dei fattori sociali in tutta la loro varietà”. “Dove il sentire è espresso in modo sintetico” – come nei suoi romanzi più grandi, da Le avventure di Augie March a Il re della pioggia, da Herzog a Il pianeta di Mr. Sammler – “gli ideali di grandezza perdono ogni valore. Solo il sentimento può portarci a concepire una realtà superiore”.
24 Novembre 2017