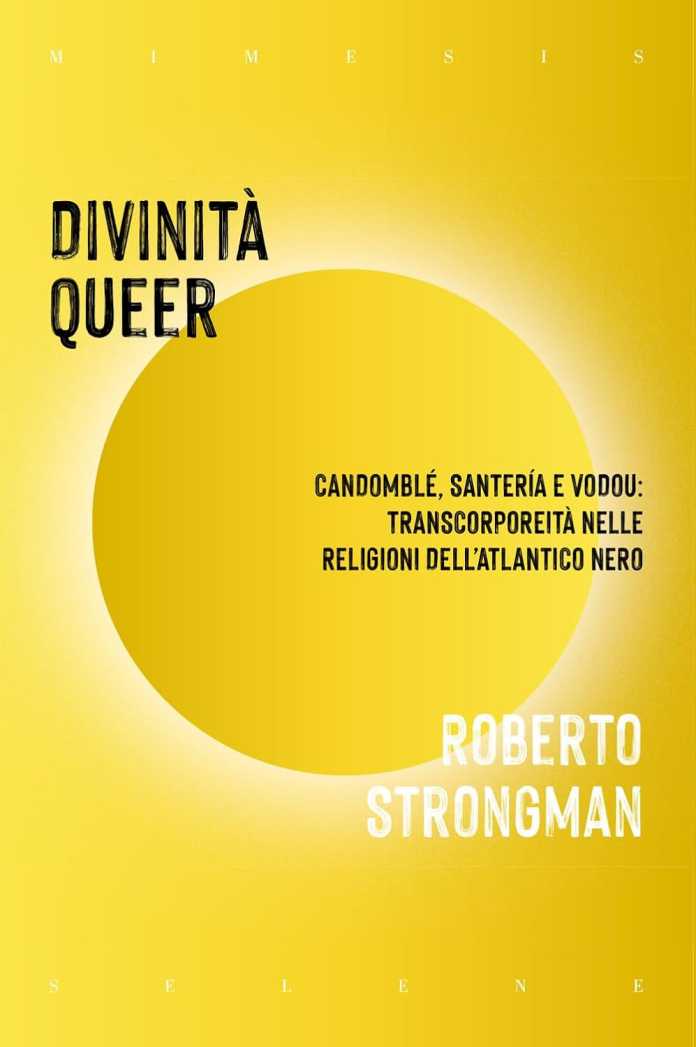L’immagine che abbiamo riguardo alla trance religiosa ricorda qualcosa di molto simile a una home invasion: l’irruzione da parte dello spirito – divinità o demone – nel perimetro del sé di cui prende possesso penetrandola. Per Roberto Strongman il riferimento a un dentro e a un fuori nasce dall’abitudine occidentale a immaginare, da Cartesio in avanti, la nostra mente imprigionata all’interno di un corpo. Avvicinando comunità spirituali afro-caraibiche come il Vodou (Haiti), il Candomblé (Bahia) o la Santeria (Cuba), ci accorgiamo che si tratta anche di un’immagine fuorviante. L’etnografo americano, professore di Black Studies presso l’Università di Santa Barbara in California, chiarisce infatti che nessun santero ad esempio si esprimerebbe in questi termini, dicendo che il tale orisha è entrato “dentro” di lui. La metafora usata nel linguaggio comune è quella della deità che “sale a cavallo” del santero, un’immagine che nella curvatura stessa della sella evoca semmai l’apertura flessuosa di corpi che si adattano al ritrarsi cerimoniale dell’io davanti al divino.
Per Strongman se “il nostro rapporto con il corpo, lungi da essere universale, è sempre immaginato e culturalmente appreso”, quello che ritroviamo nelle religioni sincretiche della diaspora nera rimanda direttamente alla filosofia africana e al diverso significato che identità, corpo e coscienza ricoprono in queste pratiche comunitarie. Diversamente dall’idea occidentale del corpo come prigione dell’anima, la possessione durante la trance viene qui descritta attraverso le interazioni di un sé molteplice. Il Vodou, in particolare, distingue la componente della coscienza anonima (gowbonanj) da quelle dell’obiettività (tibonanj) e dell’anima individuale (mètet). E attorno a questi elementi della personalità ruotano a loro volta il nam, descritto come “lo spirito della carne che permette ad ogni cellula di funzionare”, lo zetwal, la componente celeste del destino e il kòkadav, cioè il corpo fisicamente inteso. Il confronto con l’anima cattolica o con la mitopoiesi freudiana hanno in genere portato fuori rotta le interpretazioni degli etnografi creando spesso confusione. Durante la trance, sottolinea, il soggetto non smette di “essere se stesso”, perché ad essere prestata alla deità è piuttosto la sua componente viaggiante.
Proprio da questa molteplicità dell’essere emerge per Strongman anche la fluidità di genere a cui gli uomini e le donne del candomblé, del vodou o della santeria si aprono nell’incontro extracorporeo con le divinità africane della diaspora, dietro al paravento dei santi e dell’iconografia cattolica. La molteplicità del sé è quindi la premessa filosofica della queerness – di genere, sesso e razza – che unisce nella performance cerimoniale lo spirito della deità, maschio o femmina, al suo “cavallo”, femmina o maschio. Questa premessa trova anche una conferma nell’adesione storicamente elevata delle donne e delle comunità omosessuali maschili alle religioni sincretiche, relativamente più aperte almeno nei ruoli cerimoniali e performativi, rispetto al contesto di società sessiste e razzializzanti.
L’autore setaccia le fonti dell’antropologia culturale a partire già dagli anni ’30-’40 del secolo scorso per arrivare alle tesi accademiche odierne, analizzando le indicazioni utili che gli etnografi hanno fornito anche in circostanze storiche e metodologiche oggi più o meno datate. Il saggio, che non intende essere specialistico, si intreccia anche alla lettura critica di due classici della cinematografia popolare come il cubano Fragole e Cioccolata di Tomás Gutiérrez Alea e Juan Carlos Tabío, dal romanzo omonimo di Senel Paz, e Donna Flor e i suoi due mariti di Bruno Barreto, da Jorge Amado. Due film dove i simboli della spiritualità africana accompagnano sottotraccia l’intero arco della vicenda, ma invisibili o quasi alla visione dei non iniziati.