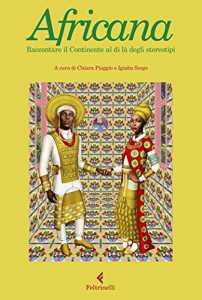 In una delle due introduzioni ad Africana: raccontare il continente al di là degli stereotipi (autori vari, traduttori vari, Feltrinelli, pp. 219, euro 19,00 stampa) Igiaba Scego scrive: “sembra banale ribadirlo, ma non si sa mai, meglio ripeterlo. L’Africa è un continente”. Se, come nota la scrittrice, dal punto di vista geografico l’affermazione è indubbiamente una banalità, lo stesso non si può dire per quel che riguarda il ruolo relazionale dell’Africa nell’immaginario occidentale, e soprattutto italiano (visto il pubblico che la raccolta si propone di raggiungere). Che persista una diffusa ignoranza, o meglio, indifferenza, nei confronti di quello che si appresta a diventare un buon quarto della popolazione mondiale e del continente che occupa non dovrebbe stupire. L’ingenuità con la quale nel nostro paese si continua a parlare di “africani” e “ner*” come se il continente fosse riducibile a un’identità tutto sommato omogenea nasconde in realtà secoli di razzismo interiorizzato e continuamente ribadito dall’incuria (o dalla mistificazione patente) con la quale ci si approccia all’Africa nel discorso pubblico.
In una delle due introduzioni ad Africana: raccontare il continente al di là degli stereotipi (autori vari, traduttori vari, Feltrinelli, pp. 219, euro 19,00 stampa) Igiaba Scego scrive: “sembra banale ribadirlo, ma non si sa mai, meglio ripeterlo. L’Africa è un continente”. Se, come nota la scrittrice, dal punto di vista geografico l’affermazione è indubbiamente una banalità, lo stesso non si può dire per quel che riguarda il ruolo relazionale dell’Africa nell’immaginario occidentale, e soprattutto italiano (visto il pubblico che la raccolta si propone di raggiungere). Che persista una diffusa ignoranza, o meglio, indifferenza, nei confronti di quello che si appresta a diventare un buon quarto della popolazione mondiale e del continente che occupa non dovrebbe stupire. L’ingenuità con la quale nel nostro paese si continua a parlare di “africani” e “ner*” come se il continente fosse riducibile a un’identità tutto sommato omogenea nasconde in realtà secoli di razzismo interiorizzato e continuamente ribadito dall’incuria (o dalla mistificazione patente) con la quale ci si approccia all’Africa nel discorso pubblico.
“Desirée Mariottini drogata, stuprata e uccisa a 16 anni dal branco di spacciatori africani”, titola un articolo di Libero del 20 giugno 2021 in relazione a uno dei fatti di cronaca nera più discussi degli ultimi anni. Non che da una testata notoriamente (e furbescamente) razzista come Libero ci si possa aspettare molto di più, ma un titolo come questo dimostra come, a destra, il dibattito pubblico sia fermo più o meno alla fine del diciottesimo secolo, strenuamente aggrappato a stereotipi colonialisti e al sempiterno terrore bianco del nero primitivo, nerboruto e ipersessualizzato, pronto a fare strage delle nostre donne inermi. Gli imputati vengono dal Senegal, dal Ghana e dalla Nigeria, ma si trasformano in un “branco di africani”, non esseri umani ma bestie assetate di sangue, con il risultato che una terribile storia di fragilità, tossicodipendenza e degrado viene risemantizzata in un generico attacco alla società occidentale e così rivenduta ai lettori.
Si tratta ovviamente di un caso estremo, in cui le reazioni viscerali sono purtroppo contemplate (e colpevolmente tollerate), ma questo genere di attitudine, la trasformazione dell’Africa e dei suoi abitanti in un radicale “altro da noi” in conflitto con il sistema-Europa, è ravvisabile anche in contesti e situazioni ben più innocui. L’introduzione di Scego ne presenta alcuni tra i più frequenti e apparentemente irrilevanti. “Parli africano tu?”; “Tu sopporti il caldo: sei africana, beata te!”; “Ah, il continente nero, che bellezza!”, e via dicendo. Se non fosse che, sembra banale ribadirlo, queste affermazioni lasciano intuire un inconscio ancora saldamente radicato nel costrutto colonialista di un’Africa tanto grande quanto indistinta, soggetto monolitico e orientalizzato (direbbe Edward Said), frutto di un’imagologia bianco-suprematista che non può e non vuole andare oltre lo stereotipo rassicurante sul quale ha costruito la propria egemonia culturale, economica e politica. Ma non c’è bisogno di volgersi necessariamente ai discorsi apertamente razzisti per rendersi conto di come il continente e i suoi abitanti siano vittima di un affastellamento di stereotipi che finiscono per soffocarne le identità molteplici e le vaste complessità che invece li caratterizzano. Difficile non scovare un atteggiamento di paternalistica superiorità anche negli approcci apparentemente nobili di chi si propone di “aiutare” l’Africa, bambina perenne incapace di comportarsi come gli adulti d’occidente, che per questo si propongono, illuminati e munifici, di insegnarle come dovrebbe comportarsi per raggiungere gli standard di civiltà richiesti per essere ammessi nel club prestigioso dei grandi della terra. Persino un libro sofisticato come Perdi la madre di Saidiya Hartman, recentemente pubblicato in Italia da Tamu Edizioni, dimostra, nella candida ma dolorosa ammissione dell’autrice, come anche gli afrodiscendenti figlie e figli della tratta atlantica degli schiavi siano costretti a venire a patti con il fatto che l’Africa è molto spesso più una terra di sogni che una realtà, e di quanto sia difficile ritrovare davvero il legame ancestrale al quale Hartman e tutti quelli come lei aspirano nel tentativo di ricucire gli strappi imposti dalla storia del capitalismo.
Ma aspettarsi che il capitalismo colonialista e gli stereotipi che ha creato vengano riformati al di là delle mani sottilissime di vernice che la cultura neoliberista tende a passare sui residui più imbarazzanti della sua storia è una pia illusione. Per questo, e per fortuna, esistono volumi come Africana, che si propongono l’intento di stravolgere l’inveterato atteggiamento coloniale dell’occidente (e, in questo caso, dell’Italia in particolare) e di fornire ai lettori e alle lettrici delle lenti nuove attraverso le quali avvicinarsi a una delle realtà più vive e interessanti del panorama culturale attuale. Perché conoscere l’Africa e capire l’Africa, in fondo, vuol dire anche capire le sorti del mondo occidentale e avere perlomeno un presagio di un futuro in cui gli equilibri del continente saranno sempre più rilevanti nella definizione della politica internazionale.
Il primo mito legato all’Africa che è cruciale smantellare è quello legato all’emigrazione. Dall’Africa se ne vanno tutti, è un luogo maledetto e ostile alla vita: orde di immigrati si affollano ai confini della fortezza Europa e delle altre nazioni del primo mondo alla ricerca di un’esistenza dignitosa (secondo gli standard occidentali, chiaramente). Ci pensa Achille Mbembe, importante filosofo camerunense che partecipa a questa antologia con un articolo intitolato “Gli africani devono purificarsi dal desiderio dell’Europa”, in cui, dati alla mano, dimostra che il 70 per cento dei migranti africani si muovono all’interno del continente piuttosto che dirigersi in Europa occidentale (dove gli africani subsahariani costituiscono appena l’1 per cento della popolazione) e nel resto del mondo. Intensificare e facilitare la mobilità all’interno del continente, secondo Mbembe, è un passo necessario per smantellare le logiche psicologiche e politico-geografiche che derivano dall’epoca coloniale. “La decolonizzazione non sarà compiuta fino a che ciascun africano non disporrà del diritto di circolare liberamente in tutto il continente”, scrive il filosofo.
Africana accoglie diciannove contributi di grande varietà stilistica e formale, tendenzialmente brevi, come una serie di scatti di luoghi, personaggi e situazioni anche molto diversi tra di loro. Un viaggio, o meglio, una cavalcata attraverso alcuni degli esempi più interessanti della letteratura e del pensiero africani contemporanei. E dell’arte, anche, con “L’uomo integro” di Pierre-Cristophe Gam, un’interessante serie di opere ibride, tra fotografia e digitale, dedicate al leader burkinabé Thomas Sankara, il “Che Guevara africano”. Alcuni dei nomi della raccolta, come quello del già citato Mbembe, o quello di Taiye Selasi, che partecipa con il bellissimo racconto “La vita sessuale delle ragazze africane”, godono già di un riconoscimento internazionale. Ma gran parte di Africana è composta da autori e autrici perlopiù sconosciuti al pubblico italiano, che ha finalmente la possibilità di avvicinarsi alla polifonia della letteratura in tutta la sua ricchezza. Troviamo Chimamanda Ngozi Adichie, quindi, ma anche Ken Bugul, scrittrice senegalese a cavallo tra tradizione e rivoluzione; Lelissa Girma, autore nato e cresciuto ad Addis Abeba che scrive in inglese e in amarico; Rémy Ngamije, che in “La ronda dei quartieri” accompagna i lettori nei bassifondi di Windhoek, capitale della Namibia; Efemia Kela, giovane autrice di talento e critica letteraria per la Johannesburg Review of Books; e Felwine Sarr, promotore insieme a Mbebe degli Ateliers de la Pensée di Dakar, incontro annuale dei maggiori pensatori africani e fondatore della casa editrice Jimsaan.
Perché, incredibile a dirsi, in Africa si scrivono, si pubblicano e si leggono libri. Una mia studentessa afrodiscendente una volta mi raccontò di come, in una conversazione in cui aveva dichiarato di amare la letteratura, le fosse stato chiesto “ah, ma quindi anche in Africa avete le librerie?”. Ennesimo esempio tragicomico di come il paternalismo, magari anche sinceramente bonario, di molti italiani sia il prodotto di uno sguardo in realtà ferocemente razzista per il quale l’Africa non è altro che un agglomerato di capanne di paglia e fango abitate da analfabeti tribali intenti a sacrificare galline in osceni e demoniaci riti vudù. E invece, come afferma Piaggio, “l’industria letteraria africana sta crescendo al ritmo del sei per cento l’anno”, proiettandosi nel futuro anche grazie alle possibilità offerte dalle tecnologie digitali. Alla faccia di chi ritiene incredibile anche solo la presenza di librerie sul continente, l’Africa abbonda di riviste online, blogger letterari ed eventi culturali ospitati sui social network. Perché, sulla scia del grande successo internazionale dell’industria cinematografica nigeriana (la cosiddetta Nollywood), anche la letteratura africana, grazie alla crescita demografica che nei prossimi decenni renderà il continente una delle regioni più giovani e popolose al mondo, è destinata ad avere un ruolo sempre più centrale nel panorama culturale mondiale.
Ignorare la letteratura africana, quindi, vuol dire ignorare il futuro della letteratura tout court. E le pagine di Africana: raccontare il continente al di là degli stereotipi offrono al lettore uno sguardo caleidoscopico e densissimo su come si scrive dell’Africa, sull’Africa e in Africa oggi, oltre la gabbia del colonialismo e del dominio culturale occidentale. Impossibile rendere giustizia alla varietà di voci, stili e temi contenuti all’interno di questo volume in un solo articolo. Come suggeriscono le curatrici, la cosa migliore è abbandonarvisi come si farebbe camminando per le strade caotiche di una metropoli come Accra o Lagos, o come si fa ascoltando un disco jazz: lasciandosi andare e facendoci trasportare dalla musica anche solo per il piacere di vedere dove ci porta.



