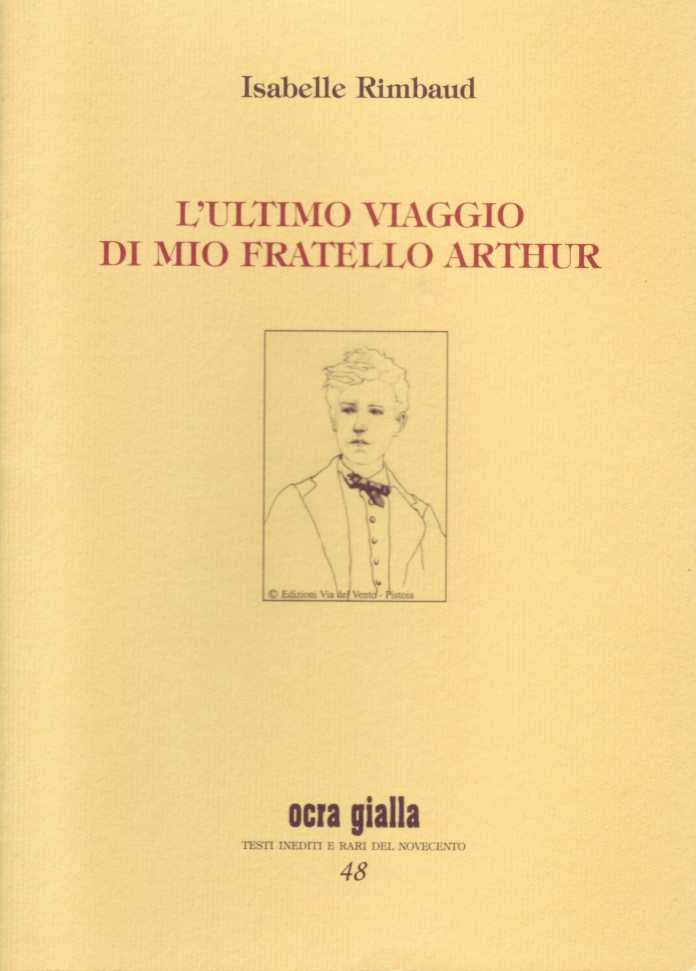Jean-Nicolas-Arthur Rimbaud, autore nemmeno ventenne di Une Saison en enfer che ancora fa scervellare traduttori di tutto il mondo, ha costretto chiunque a fare i conti con certe disavventure della vita, quelle che sovente straripano nel mistero più fitto: amava gli uomini, amava le donne, odiava l’intellighenzia poetica del suo tempo, usava droghe e farmaci, si dileguava dalla Legione straniera per approdare a Cipro passando da Genova (stazione di Piazza Principe), dirigendosi poi in Africa (in Harar), ebbe come compagna Viagère a Aden… oppure no, oppure sono stati tutti felici di coltivare un mito meraviglioso e che più maudit non si può?
Jean-Nicolas-Arthur Rimbaud, autore nemmeno ventenne di Une Saison en enfer che ancora fa scervellare traduttori di tutto il mondo, ha costretto chiunque a fare i conti con certe disavventure della vita, quelle che sovente straripano nel mistero più fitto: amava gli uomini, amava le donne, odiava l’intellighenzia poetica del suo tempo, usava droghe e farmaci, si dileguava dalla Legione straniera per approdare a Cipro passando da Genova (stazione di Piazza Principe), dirigendosi poi in Africa (in Harar), ebbe come compagna Viagère a Aden… oppure no, oppure sono stati tutti felici di coltivare un mito meraviglioso e che più maudit non si può?
 A questo immenso crogiolo si aggiungono i tre scritti di Isabelle Rimbaud, sorella minore del nostro Poeta, che sembrano confezionati apposta per rendere ancora più perturbante l’ultima stagione della sua breve vita. Il racconto del periodo posteriore all’amputazione dell’arto, con i dolori dovuti al cancro che ormai lo rodeva nel profondo, ha qualcosa di spaventoso, quando si capisce benissimo che a Isabelle delle opere del fratello poco importava, e impressiona soprattutto questa frase lapidaria e definitiva: “Pur senza averle mai lette, conoscevo le sue opere. Io le avevo concepite.”
A questo immenso crogiolo si aggiungono i tre scritti di Isabelle Rimbaud, sorella minore del nostro Poeta, che sembrano confezionati apposta per rendere ancora più perturbante l’ultima stagione della sua breve vita. Il racconto del periodo posteriore all’amputazione dell’arto, con i dolori dovuti al cancro che ormai lo rodeva nel profondo, ha qualcosa di spaventoso, quando si capisce benissimo che a Isabelle delle opere del fratello poco importava, e impressiona soprattutto questa frase lapidaria e definitiva: “Pur senza averle mai lette, conoscevo le sue opere. Io le avevo concepite.”
Ecco come la poesia, dunque, venga da lei usata come tentativo, non si sa quanto disperato, di descrivere una devozione giunta al limite estremo, ben oltre l’agonia di un giovane uomo dal destino prefigurato. Letterariamente inconsapevole di quanto avesse per le mani, Isabelle scrive questa sorta di ultimo diario la cui qualità è pur modesta: forse proprio per questo riesce a trasmetterci (come incarnandosi in una sorta di “doppio” al femminile) l’orrore della fine e l’epilogo drammatico. La stessa somiglianza fisica con il fratello sovverte la realtà, piegandola a un amore psichicamente alterato che però le permette di impadronirsi di un’anima che era stata simbolo di libertà estrema. In definitiva, avvicina e rende simpatica l’immagine di un Rimbaud altrimenti sfuggente.
 Pochi mesi prima, in estate, Arthur descriveva in una lettera a lei indirizzata i particolari della sua condizione di “storpio”, pensando ancora di cavarsela, e concludendo non senza una traccia di buona ironia (o di mascherata cattiveria): “il seguito alla prossima puntata”.
Pochi mesi prima, in estate, Arthur descriveva in una lettera a lei indirizzata i particolari della sua condizione di “storpio”, pensando ancora di cavarsela, e concludendo non senza una traccia di buona ironia (o di mascherata cattiveria): “il seguito alla prossima puntata”.