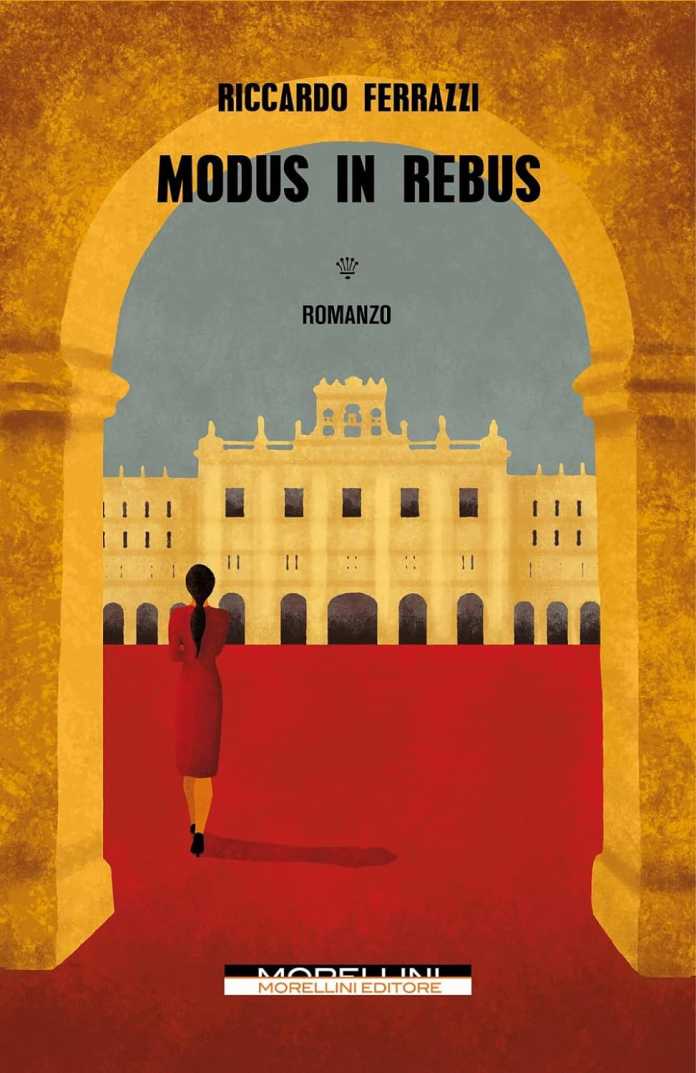Appartenendo a ricordi liceali comunemente condivisi, est modus in rebus appare come la famosa locuzione oraziana che, per mezzo di quella “misura” da ritrovarsi “nelle cose”, esalta moralisticamente le virtù della temperanza e della moderazione. Tuttavia, già nella formulazione delle Satire di Orazio l’approccio è etico e non semplicemente moralistico: sunt certi denique fines, quos ultra citraque nequit consistere rectum, “vi sono precisi confini, prima e oltre i quali non può esservi il giusto”. Una traduzione forse annacquata – come qualsiasi ricordo di liceo, per chi scrive – ma può rendere comunque giustizia alla qualità etica della massima, aprendo anche uno spiraglio verso alcune sue interpretazioni più chiaramente tragiche. Cosa c’è, infatti, prima e oltre quei confini? È probabilmente da questo interrogativo, ovvero dalla percezione, in ultima istanza tragica e provocata dallo smarrimento del modus in rebus (o dalla sua sostituzione con un so it goes di vonnegutiana memoria), che nasce l’ultimo libro di Riccardo Ferrazzi, intitolato, appunto, alla massima oraziana.
Del resto, il protagonista, Vittorio, è tutto fuorché un vincitore, come vorrebbe ironicamente il suo nome, e la sua traiettoria, nelle trecento pagine del romanzo, resta perlopiù ambigua, se non anche oscura. E popolata di crimini, per di più, a rendere il tutto più cupo ed enigmatico. Eppure, la prima parte del romanzo sembrerebbe investita dalla luce abbacinante, in particolare quella della meseta tra Madrid e Salamanca: un luogo – certamente amato anche dall’autore, traduttore dallo spagnolo (ad esempio, in tempi recenti, del Romancero gitano di García Lorca, per Pellegrini Editore, insieme a Marino Magliani) – dove non ci sono ombre, per citare il testo, se non quelle che coltivano nel proprio mondo interiore, e con una certa acribia, i vari personaggi. Tuttavia, le aspirazioni estetizzanti di una vita da sradicato, per Vittorio, rivelano presto l’oscurità su cui poggiano, con l’assassinio di un influente sacerdote e una relazione che stenta a decollare con una donna di Salamanca, Maite.
È anche l’oscurità di una Spagna che fatica a uscire dalle secche, e dagli orrori, del franchismo, rovesciata quasi sarcasticamente da una seconda parte del libro, costellata anch’essa di morti violente, in un milieu culturale milanese che ricorda Bianciardi, benché aggiornato a qualche decennio dopo La vita agra. Non solo il personaggio di Vittorio, ma i suoi amori, i suoi fantasmi e soprattutto i dubbi legati al passato uniscono le due parti e avviano verso la conclusione, dove la “misura delle cose” è di nuovo riferita al percorso esistenziale e alle sue tragedie, più che a un rimedio moralistico o etico, di qualsivoglia natura.
Prima dell’epilogo, uno scambio di battute rende forse giustizia a un’ulteriore dimensione del personaggio di Vittorio, vicina a quella del Julian Sorel stendhaliano. Una donna dall’identità misteriosa gli chiede: “E all’estero come si sentiva? Esiliato? Profugo?”, e Vittorio risponde: “Mi sentivo come i soldati di Napoleone. Con un po’ di fortuna avrei potuto mettere le mani su un regno. Come Murat. Come Bernardotte”. Come nei sogni e nelle ambizioni bonapartiste di Sorel, appunto; destinate, come le storie narrate da Ferrazzi tra Spagna, e Italia all’indomani del franchismo e di una certa atmosfera culturale milanese, a incorrere in grandi pericoli, laddove si stenta a dare una definizione eticamente ed esistenzialmente solida, una “misura nelle cose”.