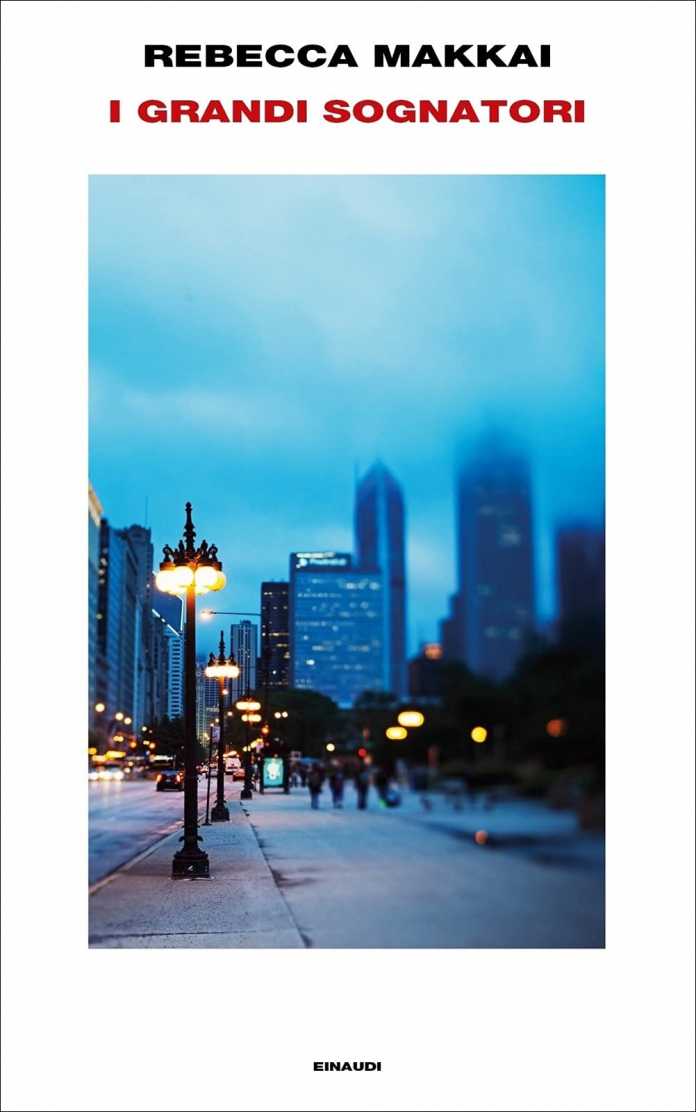Chicago, USA, 1985: scoppia violenta e con tutta la sua forza distruttrice l’epidemia di AIDS. Si diffonde soprattutto nelle comunità gay, e sembra una malattia che si trasmette solo tra le categorie di persone dalle abitudini sessuali promiscue e sregolate. Così almeno viene fatta percepire alla società americana. Siamo in piena era Reagan, con il trionfo dell’edonismo e del capitalismo più sfrontato, con un presidente che insieme a Margaret Thatcher, primo ministro britannico, smantellerà i diritti dei lavoratori e il poco stato sociale ancora esistente. La malattia viene ignorata per anni in America, come fosse una punizione divina, e solo dopo diversi anni Reagan ne parlerà apertamente in un suo discorso. Le compagnie di assicurazione intanto fanno a gara per trovare scuse per non pagare le costosissime cure agli ammalati e molti di loro moriranno soli in squallide stanze offerte da associazioni di volontariato. Nelle comunità gay, almeno all’inizio, invece di affermare il diritto a essere curati dallo Stato, comincia la caccia all’untore: la paura fa cambiare abitudini sessuali, spezza molti legami e amicizie.
Il romanzo si apre con una festa in onore di Nico che si svolge durante il suo funerale a cui i genitori non fanno partecipare gli amici gay. Fra i tanti, Yale e Charlie, una coppia consolidata e Fiona, sorella di Nico, che non ha mai perdonato al padre e alla madre di avere allontanato il fratello quando si era dichiarato omosessuale. Il testo, che sono certo lascerà una traccia indelebile nei lettori e nella letteratura mondiale, si snoda a capitoli alternati, tra il 1985 e dintorni e il 2015, quando Fiona si reca a Parigi per cercare la figlia che ha perso di vista da anni. Sono i giorni dell’attentato al Bataclan e lì si ritroveranno, anche inaspettatamente, alcuni dei protagonisti sopravvissuti che sembrano voler cercare un significato agli accadimenti di quaranta anni prima.
La scrittura di Rebecca Makkai – che è nata nel 1978 – è evocativa e potente, ci guida tra psicologie e ambienti descritti maniacalmente, il suo stile è a tratti sontuoso, il suo sguardo d’insieme e dei dettagli è ampio e preciso, un colpo d’occhio a trecentosessanta gradi. Una scrittrice consapevole dei propri mezzi, che usa senza sforzi in una narrazione sempre omogenea e profonda e senza mai pause o cadute di stile, come se avesse vissuto in prima persona le cose che ha scritto. Il lavoro di ricerca è evidente e dettagliato perché niente è lasciato al caso: l’autrice tiene sempre il timone senza tentennamenti, avendo sempre chiara la rotta da seguire per arrivare al suo obiettivo. Un romanzo, un documento che fa luce su una delle più grandi tragedie del secolo scorso su cui gli USA, la nazione più potente al mondo e il simbolo del capitalismo più sfrenato, non hanno voluto fare niente. Un libro da leggere per chi quegli anni non li ha vissuti, un ottimo approfondimento per chi c’era. Senz’altro il più bel libro che abbia letto quest’anno.