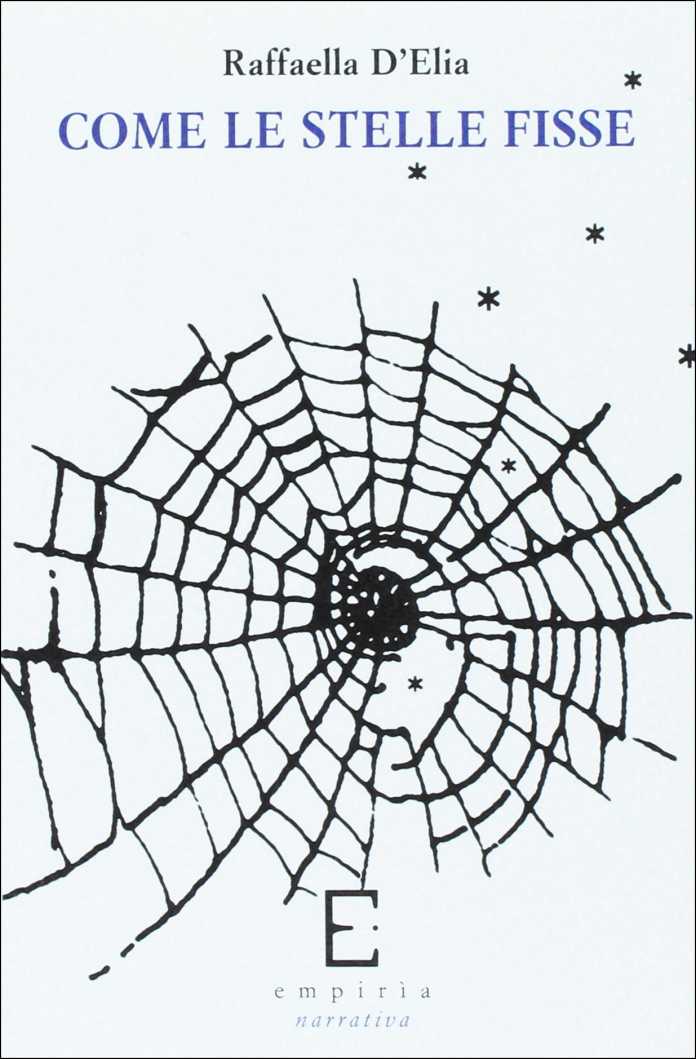Altri sconfinamenti per Raffaella D’Elia, dopo Adorazione (uscito nel 2009). Ed è affatto chiaro, in questa nuova opera, come l’autrice impari e insegni allo stesso tempo l’arrampicarsi su barriere e staccionate, dove patria corrisponde a cieli di buona volontà e territori la cui geografia giunge tanto terrestre quanto aliena. Per il semplice motivo che raccogliere atti e taccuini di zone istmiche attraversate da corsi d’acqua (l’esempio primario è un canale di Suez rappresentato come centro del mondo, della ricerca estrema di avventurieri e costruttori) reali e mentali vale la scoperta di una ragnatela siderale, come fosse un calco che sta sopra. Con quella scrittura avvincente e sacrificale a cui D’Elia ci ha allenati da quando ne seguiamo l’evolversi.
Per conoscerla davvero bene occorre addentrarsi nel suo retroterra autobiografico, determinato, miracolosamente intuitivo, dove domina un continuo sforzo respiratorio e sanguigno, poiché lo sguardo dell’autrice è subito ragionamento sulle cose, sulle geografie raggiunte, tramite una specie di grazia crudele. Crudele perché ne ha necessità la determinatezza. Dal silenzio iniziale ai passi (veri, intesi come impegnative camminate) altrettanto silenziosi, il tempo è breve. La visionarietà porta in Egitto, insegue altrettanti passi antichi, ne raccoglie e ne racconta le gesta, le più segrete e per questo apparentemente aliene (nel nostro tempo raggrinzito). In questo libro c’è la visionarietà di menti arcaiche, che furono capaci di erigere opere ingegneristiche e palazzi rivoluzionari con il proposito di far risorgere, dal mito o da testimonianze favolistiche, la realtà valorosa di tecnologie civili. Come le stelle fisse non pretende di avere un catalogo per sé: che sia narrativa, istruzione filosofica, poesia, o studio di estetica delle stelle e della superficie terrestre (con la rete fatta di meridiani e paralleli, stirata allargata e allungata da tutte le parti), si ha a che fare con qualcosa che sta fuori dai cataloghi.
Dal vagare e divagare su territori lontani all’intimo passeggio per gli incroci romani, dall’allungare le dita verso gli alfabeti altrui (che più o meno intuitivamente annoverano maestri di sbalzo come Manganelli, Landolfi, Sebald, Sanguineti, Beckett), dal pensare per poi creare la propria Bisanzio, D’Elia mostra un cammino senza tradimenti, un grande lavoro di basso continuo lungo gli scaffali eterni del creato che ci interessa e contiene. Il periodare lungo, che risente del respiro di chi è abituato a estese camminate, è qualcosa di nuovo, di cui attualmente non si riesce a trovare pari esempio. Ma tutto il libro è il rapporto di escursioni della mente dentro i mondi esterni e “fuorimondo”, perché nella sua prosa ne riprende il passato. Per questo c’è bisogno di frequentare gli archivi: l’autrice sa bene che nulla è spunto di visionarietà quanto lo spulciare gli atti notarili per vedere cosa ne salta fuori. Ci sono residui storici che vanno collegati, punto per punto fino a che non si ricostruisce una mappa delle stelle, sorta di impronta di quanto è accaduto e costruito sulla terra. Col suo pieno di guerre, paci, costruzioni edili e stradali, romanzi, e poesia. Alla fine, proprio nell’elenco dei termini utili e nella bibliografia, si apprende che la storia del mondo è una storia di scavi, di canali, di fotografia e sguardo, e che nel caso di D’Elia tutto questo va a depositarsi nella rete topografica che proprio lei sa prendere in un’indagine romanzesca di prim’ordine.