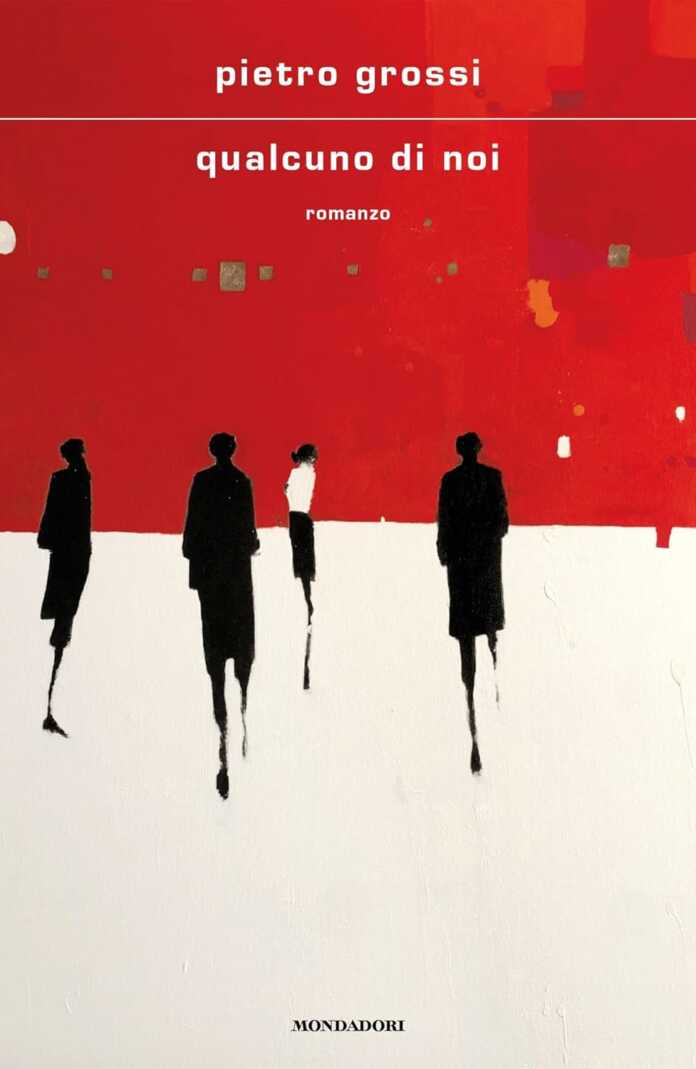Non si può evitare di cominciare con Walt Whitman e il suo “Sono vasto. Contengo moltitudini”, che era preceduto dai versi “Mi contraddico? Certo che mi contraddico!”. Chi non si è riconosciuto, in un momento o nell’altro della vita, in queste parole? Pietro Grossi scrive il suo bel romanzo Qualcuno di noi in prima persona plurale. Noi.
All’inizio ci si sente un po’ spiazzati, a leggere quel noi che in realtà vuol dire io. Viene da cercare lungo la pagina chi siano gli altri. Ma poi ci si abitua, si entra nel gioco, e dopo poco si è così catturati da quel meccanismo narrativo ed esistenziale, che quasi ci verrebbe da dare del noi anche a noi stessi. Non a caso, scrivendo le recensioni si usa spesso il noi, per indicare l’insieme dei lettori di cui il recensore fa parte; per includere chi legge e sentirsi meno soli nelle scelte che si devono fare in continuazione.
Ma il noi di Pietro Grossi è assai più complesso e articolato. È la percezione – fin dall’infanzia – che dentro di lui ci siano più personalità, e quindi anche più persone. Che non sempre vadano d’accordo tra loro, che si contendano le scelte e le responsabilità delle azioni conseguenti. Più persone che dibattono e fanno rumore. Poi nel crescere, quelle personalità si definiscono meglio, pur continuando faticosamente a convivere: ciascuna si sceglie un ambito di azione e un momento in cui agire. Vengono raccontati spesso come una ciurma di marinai, con un capitano che, a seconda delle situazioni, lascia campo libero a uno o all’altro dei membri dell’equipaggio. Ci vuole del tempo, tanto tempo e molte esperienze, dolorose e rischiose, perché il noi indifferenziato dell’infanzia arrivi al noi “moltitudine” dell’età adulta.
Ci vogliono molte menzogne. Il noi narrante è un bambino che racconta frottole e bugie anche macroscopiche, che però non vengono mai smentite. Persino le malattie, che inventa con dovizia di particolari e che millanta per attirare l’attenzione, qualche volta anche solo per non andare a scuola, quelle malattie immaginarie vengono riconosciute dai medici come vere, come se i sintomi, una volta evocati e fantasticati, diventassero autentici e reali. Quando a un certo punto il gioco della bugia non funziona più e sta per trasformarsi in prigione, il protagonista / i protagonisti del romanzo se ne sfilano. Non perché la realtà abbia portato delle sbugiardate o per ragioni etiche ma piuttosto per stanchezza e noia. Dire la verità diventa un alleggerimento, un sollievo, la possibilità di spiegare le ali.
Ci vogliono molte esperienze. Il noi protagonista è un ragazzo privilegiato, vive sui colli sopra Firenze, ha una famiglia affettuosa, due sorelle, molti amici, una vita ricca e cosmopolita. Tra le tante personalità che compongono il noi nell’adolescenza tende a prevalerne una bulla e violenta, che vuole dimostrare in ogni occasione chi è il più forte fisicamente e caratterialmente. Dato che il nostro noi è assai magrolino e piccolo, si costruisce dei muscoli adeguati. Il carattere del bullo è più che presente nella moltitudine del noi, e prevale su altri tratti. Ci sono risse e botte, senza motivo se non quello di misurarsi e vedere chi è più forte, chi cede prima. L’adolescenza porta anche alcol e droga in grandi quantità, e la difficoltà a trovare la propria strada, il proprio posto nel mondo. Viaggi per mare ed esperienze di lavoro nel mondo del cinema e della pubblicità fanno approdare finalmente il giovane “noi” sulla sua strada: la scrittura. Il luogo dove la menzogna e la verità possono anche sposarsi e convivere, e dove possono essere spostate e ribaltate secondo un senso che è una scelta, e non un caso o una condanna.
Ci vogliono esperienze amorose, relazioni piene di goffaggini e ingenuità e anche sofferenze. L’amore sembra proprio essere uno di quei territori in cui le varie parti del noi non riescono a mettersi d’accordo. Ovviamente la relazione amorosa contempla un certo grado di disvelamento, mostrare sé stessi come si è, sentire di poterlo fare e di volerlo fare. E mostrare la propria molteplicità, quando è percepita così forte e presente e quotidiana, non è facile. Il nostro protagonista ci prova, ma non ci riesce.
Tuttavia il coming of age di Grossi ha un lieto fine. Ha soprattutto un bello sviluppo, una bella linea evolutiva, che raggiunge il suo apice, e si potrebbe dire la sua perfezione, quando alla molteplicità di sé stesso riesce a far corrispondere quella degli altri. Si accorge, il noi protagonista, che anche i suoi amici, i suoi conoscenti, nel preciso istante in cui li guarda, non sono solo quello che lui sta guardando. Seduti dietro o di fianco a ognuno di loro ci sono gli altri loro, le altre voci e le altre personalità che, più o meno armoniosamente, li compongono.
Forse è questo il momento in cui il protagonista diventa adulto. Quando realizza che la sua unicità non è l’unica, perché siamo tutti inevitabilmente unici, e ogni unicità è composta di una molteplicità, di tanti io che mescolati insieme formano un io/noi originale e irripetibile. E magari questa constatazione rende la vita più complessa e complicata, ma anche infinitamente più interessante. Per tornare a Whitman, contenere moltitudini è una ricchezza che ognuno di noi può coltivare. Ebbene, Qualcuno di noi riesce a raccontare con sapienza e freschezza questa (ampia) presenza di moltitudini.