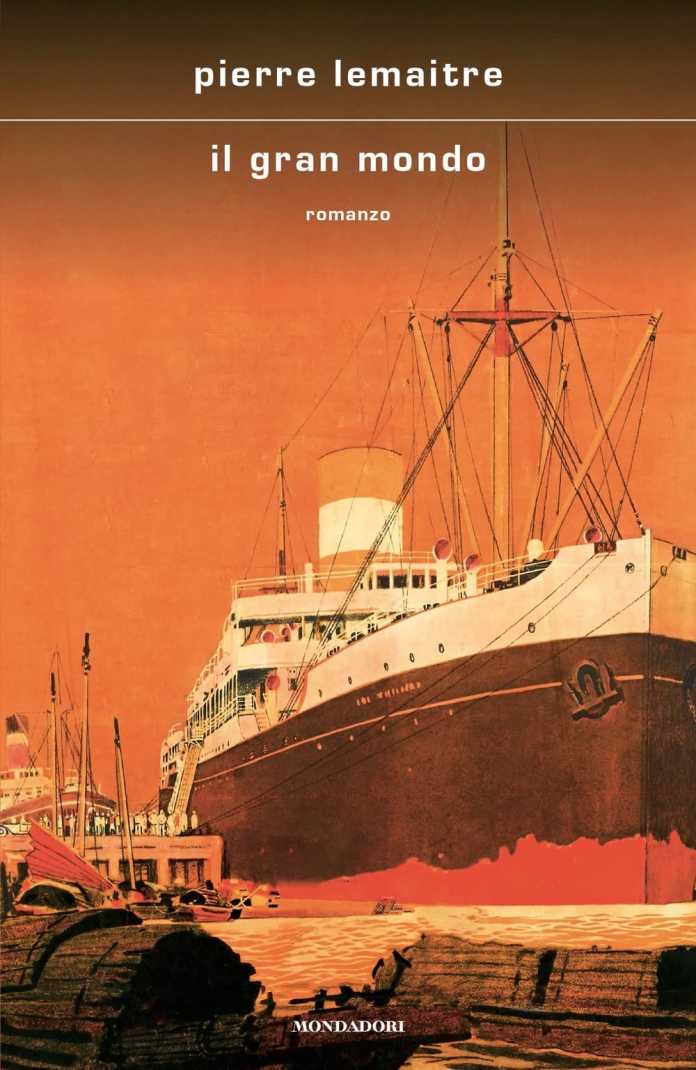Nei romanzi di Pierre Lemaitre il ritmo è serratissimo, tanto che Stephen King ne ha lodato in una circostanza la “suspense davvero eccellente”. Legato al noir, al thriller e persino al picaresco, vincitore del Prix Goncourt nel 2013 con Ci rivediamo lassù (pubblicato in Italia da Mondadori, così come quasi tutti i titoli dello scrittore francese), Lemaitre – classe ’51 – è innanzitutto innamorato della letteratura, e la sua opera è un tenace, cioraniano “esercizio di ammirazione”: lo si può notare particolarmente nell’Abito da sposo (Fazi, 2012), impollinato da continui omaggi al cinema di Hitchcock.
Il gran mondo, uscito da pochissimo sempre per Mondadori, è il primo volume di una nuova sequenza romanzesca, intitolata Gli anni gloriosi e dedicata al secondo dopoguerra, i Trente Glorieuses (il trentennio del boom economico), in chiaro collegamento con la precedente trilogia I figli del disastro (tra cui figuravano appunto Ci rivediamo lassù, I colori dell’incendio e Lo specchio delle nostre miserie). Stampato in Francia con Calmann-Lévy nel gennaio di quest’anno, Il gran mondo ha toccato immediatamente il primo posto nella classifica dei migliori libri venduti della settimana, a segnalare la sempre ottima accoglienza di pubblico per Lemaitre, il quale è stato peraltro ospite a Festivaletteratura di Mantova il 10 settembre scorso. Il romanzo in questione è una saga familiare riguardante Louis Pelletier e la moglie Angèle, emigrati in Libano, e i loro quattro figli – Jean (alias Bouboule), François, Étienne ed Hélène – che nel corso della narrazione rientrano in Francia da Beirut (a eccezione di Étienne, militare in missione a Saigon). Louis “negli anni Venti, aveva acquistato un saponificio di modeste dimensioni e lo aveva ampliato ‘coniugando qualità artigianale ed efficienza industriale’. […] Con il passare del tempo, aveva un po’ ridimensionato le sue aspettative, ma si vantava di essere a capo di un ‘fiore all’occhiello dell’industria libanese’, cosa che nessuno avrebbe avuto il coraggio di contestargli”. Il padre vorrebbe che i figli proseguissero la sua attività, ma essi al contrario vanno alla ricerca del “gran mondo”, imbattendosi in una caterva di illusioni e di speranze amaramente vanificate.
Il racconto procede secondo gli artifizi propri della diegesi lemaitriana: colpi di scena a secchiate, momenti toccanti (specialmente per ciò che concerne la vicenda di Étienne) e barbagli di umorismo, una cadenza stilistica nervosa, ad alto voltaggio, che sospinge il lettore in continue mutazioni sceniche, apparecchiate per mantenere imperiosa e costante l’asticella della Spannung.
Molto interessante per penetrare il laboratorio di scrittura di Lemaitre è il Debito di riconoscenza posto alla fine del corposo romanzo: oltre i lunghi elenchi bibliografici che lasciano intravedere la profondità della documentazione, emerge un foisonnement di “dettagli” che nutrono ipertroficamente il testo, i cosiddetti riferimenti intertestuali (tipici di una costruzione postmoderna), tutt’altro che innocue strizzatine d’occhio: Aragon, Bellow, Dumas, Flaubert, Ionesco, le Carré, Proust, Simenon e anche Scurati. La lista è ancora lunga. Non meno interessante la giustificazione di tali intrusioni: “Ho già avuto occasione di citare la prefazione di Apropos of Dolores di H.G. Wells del 1939. Mi permetto di rifarlo: ‘Si prende un dettaglio da qualcuno, un dettaglio da un altro; dall’amico di sempre o da un tizio appena intravisto sul marciapiede di una stazione, in attesa del treno. A volte si fa propria anche una frase, un’idea da un fatto di cronaca letto sul giornale. È questo il modo di scrivere un romanzo; non ce ne sono altri’. Probabilmente esistono altri modi, ma si dà il caso che quello di Wells sia anche il mio”. Il romanzo di Lemaitre è un vaso cinese, un castello di rifiniture. Svelato il mistero: “del resto”, diceva Borges, “la letteratura non è che un sogno guidato”.