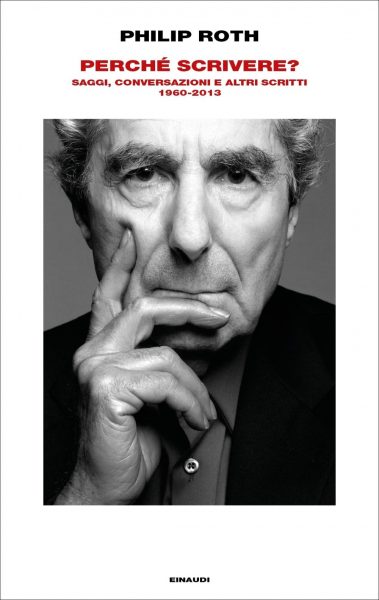Perché scrivere? Philip Roth se lo chiedeva già nel lontano 1960, durante un simposio organizzato dall’università di Stanford; il suo intervento di allora, intitolato Scrivere narrativa americana, è più che mai attuale; adesso è finalmente accessibile anche al pubblico italiano in questo prezioso e imprescindibile libro appena pubblicato da Einaudi, che raccoglie i testi di non-fiction presenti nell’ultimo volume dedicato dalla prestigiosa Library of America all’opera omnia dello scrittore. A ventott’anni Roth era convinto che
lo scrittore americano a metà del ventesimo secolo incontra grandi difficoltà a comprendere, descrivere e poi rendere credibile la realtà americana. È una realtà che sconcerta, disgusta, manda in bestia, ed è anche motivo d’imbarazzo per la nostra scarsa immaginazione. L’attualità si fa beffe del nostro talento, e ogni giorno saltano fuori figure che farebbero l’invidia di qualunque romanziere.
A dimostrazione di ciò Roth menzionava protagonisti della scena politica americana come Roy Cohn, Dwight David Eisenhower, Richard Nixon e John Fitzgerald Kennedy (allora avversari alle elezioni presidenziali), per poi concludere provocatoriamente: «Era tutto talmente sopra le righe, talmente assurdo, bizzarro e stupefacente che mi sarebbe piaciuto essere stato io a inventarlo».
Quasi sessant’anni dopo possiamo confermare che è successo proprio questo. Se Harold Bloom sostiene che Shakespeare con i personaggi dei suoi drammi abbia «inventato» l’essere umano, allora Philip Roth ha «inventato» l’America così come la conosciamo oggi: da Goodbye, Columbus (1959) a Nemesi (2010), i suoi romanzi hanno plasmato l’immagine di una nazione che grazie al New Deal ha saputo risollevarsi dalla Depressione per affermarsi come superpotenza mondiale. Nella «trilogia americana», attraverso la voce del suo alter-ego più famoso, Nathan Zuckerman, Roth ha fissato per sempre l’America idealizzata della Seconda guerra mondiale e quella paranoica e violenta del maccartismo; l’America delle proteste contro la Guerra in Vietnam e degli scontri per i diritti civili, ma anche l’America degli scandali che ne hanno fatto tremare le fondamenta democratiche – dal Watergate al sexygate. La lucidità dello sguardo di Roth è pari solo alla sua prescienza: nei primi anni Zero, alla nazione ferita del post-11 settembre si sovrappone l’America ucronica e filonazista immaginata nel Complotto contro l’America, mentre negli ultimi romanzi dietro l’ottimismo liberale suscitato dall’elezione di Obama si intravede già l’America farsesca e inquietante di Trump.
Nel corso della sua lunga e pluripremiata carriera, Roth ha preso di petto la realtà sfidandola di continuo con invenzioni narrative che spesso ne hanno anticipato gli esiti, manipolando anche gli avvenimenti chiave della propria vita in combinazioni sempre nuove – sottraendo e aggiungendo elementi, personaggi e situazioni come tasselli di un immenso puzzle formato da trentuno libri, un mosaico che oggi ci restituisce una raffigurazione assolutamente esaustiva ma altrettanto controversa dell’«American century». Nel testo intitolato Mi sono innamorato dei nomi americani Roth specifica di non sentirsi un semplice romanziere, bensì un romanziere «inconfutabilmente americano, legato da tutta la vita alla situazione americana, sotto l’incantesimo del passato di questo paese, partecipe dei suoi drammi e del suo destino». Nel bene e nel male Philip Roth ha sposato l’America, e almeno questo matrimonio non l’ha mai tradito.
Nel discorso di accettazione a uno degli innumerevoli premi ricevuti (il Pulitzer, due National Book Awards, due National Book Critics Circle Awards, tre PEN/Faulkner Awards, la National Humanities Medal della Casa Bianca… per elencarli tutti servirebbe un’altra recensione), lo scrittore ha ribadito: «La mia responsabilità estetica […] è nei confronti della lingua inglese, la madrelingua per mezzo della quale cerco di trasmettere al mondo le mie fantasie di realtà – le mie sbrigliate allucinazioni travestite da romanzi realistici». Se i romanzi sono le maschere preferite del Roth prestigiatore di storie, i testi contenuti in Perché scrivere? svelano alcuni trucchi del mestiere, forniscono una chiave per apprezzare appieno le mille sfumature della sua narrativa, dal momento che Roth resta sempre il miglior critico di se stesso. Qui troviamo interviste ad amici scrittori (Primo Levi, Ivan Klíma, Milan Kundera, Edna O’Brien…), riflessioni retrospettive sulle sue opere (una rilettura di Lamento di Portnoy Quarantacinque anni dopo, un’intervista a proposito dello Scrittore fantasma…) e su quelle altrui (un saggio sulla narrativa di Saul Bellow, un ricordo di Bernard Malamud), accanto a considerazioni sui temi principali della sua scrittura, sketch autobiografici, brani d’occasione e veri e propri gioielli narrativi come Sugo o salsa? e il bellissimo «Ho sempre voluto che ammiraste il mio digiuno», ovvero, guardando Kafka. Per non parlare delle famigerate lettere al vetriolo inviate da Roth a Wikipedia nel corso degli anni per correggere le interpretazioni delle sue opere che giudicava errate.
Ma allora perché smettere di scrivere? È la domanda che si sono incessantemente posti tutti i lettori e gli appassionati di Roth a partire dal 2012, quando lo scrittore ha annunciato la sua irrevocabile decisione di ritirarsi dalla scena letteraria. In alcune interviste raccolte in questo volume Roth fornisce diversi motivi per la sua scelta, spesso contraddittori e comunque sempre parziali; come al solito, non esiste una verità univoca – i suoi lettori dovrebbero averlo ormai imparato da tempo. «Tutti i mestieri sono ardui», spiega nel 2014 all’intervistatore della rivista Svenska Dagbladet, ma fare lo scrittore per lui è «un compito impossibile»: «Scrivere per me è stata una lotta per la sopravvivenza […]. Tuttavia, perché mi sia dovuto imbarcare in una tale impresa non so proprio dirlo. Forse scrivere mi ha protetto da minacce ancora più terribili». La scrittura come necessità, quindi; come impossibilità, come sfida, come ancora di salvezza. La scrittura come sforzo sovrumano che a ottant’anni Roth non riesce più a sostenere. Ma davvero è tutto qui?
Oppure, alla fine, l’assurdità del reale ha definitivamente surclassato la fiction, se persino un’ucronia come Il complotto contro l’America (in cui Roth immagina la vittoria dell’aviatore filonazista Charles Lindbergh alle elezioni presidenziali del 1940 al posto di Franklin D. Roosevelt) risulta più credibile dell’elezione di Donald Trump a quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti? In una delle sue ultime interviste (purtroppo non inclusa in questo volume) Roth ha specificato che il problema non è capire Trump «come tipo umano o come personaggio – l’immobiliarista o il capitalista spietato, irresponsabile e insensibile», bensì riuscire ad accettarlo seduto alla Casa Bianca, mentre «sfoggia un vocabolario di settantasette parole che sarebbe meglio definire ‘cretinese’ che inglese». I testi di Perché scrivere? sono la risposta di Roth all’impoverimento – lessicale ma anche culturale e mentale – del mondo contemporaneo: se è vero che «il romanziere non è che un minuscolo ingranaggio nella grande ruota del pensiero umano», leggere romanzi (e quindi per traslato scriverli) resta per Roth «un piacere profondo e singolare, un’attività umana avvincente e misteriosa che non richiede maggiori giustificazioni morali o politiche di quante ne richieda il sesso».
Paolo Simonetti ha già scritto su Philip Roth nelle pagine di PULP Libri, in occasione della scomparsa dello scrittore americano.