Curioso e paradossale destino quello di Philip K. Dick (1928-1982), per tutta la sua breve vita oscuro e malpagato scrittore di pulp fantascientifici: si è lasciato alle spalle le illusioni perdute di una carriera di autore mainstream – otto romanzi non di genere, uno solo dei quali pubblicato in vita e con scarso successo – ed è ormai rassegnato al ruolo, modesto ma incontestabile, di innovatore della fantascienza, stimato per la potenza visionaria dell’invenzione quanto criticato per la sciatteria dello stile e l’incoerenza della costruzione degli intrecci, quando il suo romanzo Do Androids Dream of Electric Sheep? diventa nelle mani di Ridley Scott il capolavoro della cinematografia mondiale, Blade Runner, portandogli finalmente fama e denaro. Non fa neanche in tempo ad assistere all’anteprima del film: un infarto lo stronca improvvisamente nel garage di casa il 2 marzo del 1982.
Bistrattato in vita, Dick diventa dopo la morte un’icona dell’immaginario postmoderno statunitense: decine di film e serie tv ispirate alla sua narrativa, centinaia di saggi, studi, tesi universitarie dedicate alla sua opera, un riconoscimento univoco da parte dell’establishment culturale che erige la dimessa genialità delle sue fantasie a paradigma filosofico e chiave di volta metafisica.
Anche in Italia l’imminente consacrazione nell’empireo dei Meridiani Mondadori, raramente concessa agli autori di genere (che ricordi, solo a Hammett e Chandler, e mai ad uno scrittore di fantascienza), sancisce la sua definitiva apoteosi fra i grandi della letteratura internazionale. Lo si etichetta di solito, forzando spesso i fatti, come una sorta di provocatore intellettuale o di agitatore controculturale – acerrimo avversario della politica repressiva e poliziesca di Nixon, fortunoso alfiere della psichedelia e della deriva acida – e, in grazia delle esperienze mistiche (forse effetti di una schizofrenia latente) degli anni finali della sua vita trasfuse in tutte le sue ultime opere, perfino guru spirituale e ipotetico profeta di una nuova religione (per approfondire questi dibattuti aspetti rimando al mio articolo di qualche anno fa su Carmilla).
È forse utile pertanto riflettere su questa iperesposizione mediatica e sugli effettivi meriti o sull’eventuale sopravvalutazione di un autore spesso più citato che davvero conosciuto. Ci vengono in aiuto, recenti acquisizioni ulteriori dell’immensa bibliografia in merito, due eccellenti volumi che da prospettive diverse e con approcci talvolta divergenti affrontano e riconsiderano il caso Philip Dick.

Il primo, Il mondo secondo Philip K. Dick (Mondadori, 2022, pp. 382, euro 15,00), è di un americanista fra i maggiori studiosi di fantascienza ed esperti di Dick in Italia, Carlo Pagetti. Il testo è composto, accompagnato da un’introduzione e da una conclusione, dalla raccolta ordinata delle introduzioni a quasi tutti i romanzi dickiani che lo studioso aveva scritto per la collana “Collezione Dick” delle edizioni Fanucci (mancano solo poche cose: Dr. Futurity e Vulcan’s Hammer del 1960; The Game-Players of Titan del 1963; Now Wait for Last Year del 1966; le collaborazioni The Ganymede Takeover con Ray Nelson del 1967 e Deus Irae con Roger Zelazny del 1976; e un paio di romanzi mainstream). Il che, con l’aggiunta di un lungo capitolo sulla narrativa breve dickiana, offre una panoramica pressoché completa su tutte le opere maggiori e più riuscite dello scrittore californiano.
Il secondo, Philip K. Dick: Tossine metaboliche e complessi illusori prevalenti (Mimesis, 2021, pp. 130, euro 12,00), si articola invece come una sorta di vero e proprio dibattito tra i due autori, Stefano Carducci e Alessandro Fambrini, l’uno decisamente critico e tendente a un ridimensionamento globale della figura intellettuale e creativa di Dick, che si concentra sulla narrativa fantascientifica dickiana, l’altro, più sintonico e indulgente verso lo scrittore. Fambrini analizza soprattutto le opere mainstream e, da germanista quale è di professione, oltre ad evidenziare i già noti debiti di Dick verso la lingua e la cultura tedesca, individua inedite e interessanti relazioni con alcuni scrittori scandinavi come Ibsen e soprattutto Strindberg, tornate in qualche modo al mittente nell’utilizzo delle idee e del personaggio stesso di Dick per come si presentano nella “trilogia americana” di uno scrittore svedese contemporaneo, Lars Gustafsson. A somiglianza di Dick in precario equilibrio fra mainstream e atipiche forme di fantascienza.
Tutti e tre i saggisti sono comunque concordi nel vedere nell’ultimo romanzo pubblicato da Dick in vita, The Trasmigration of Timothy Archer, l’esempio più riuscito ed efficace di sintesi fra elementi fantastici (traslatamente gotici o fantascientifici, nella tradizione del romance americano), e realistici, addirittura cronachistici, trattandosi della trasposizione romanzesca di una vicenda e di personaggi reali: la strana vita e soprattutto la strana morte del vescovo episcopaliano James Albert Pike, da Dick ben conosciuto e frequentato assiduamente. Tra questi la dettagliata ricostruzione di ambiente (la California settentrionale e l’area di San Francisco negli anni successivi alla Summer of Love), e la coerente caratterizzazione psicologica (per la prima volta il misogino Dick abbandona gli stereotipi per dare finalmente voce in prima persona ad un credibile e profondo personaggio femminile). La scomparsa improvvisa dello scrittore non ha permesso purtroppo di portare a compimento gli esiti che sembravano raggiunti in questo romanzo: l’ormai realizzato equilibrio sintetico fra le due anime – entrambe tormentate ed ossessive – dell’autore; il realismo mainstream e la visionarietà fantascientifica, finalmente pacificate in una compiuta narrativa postmoderna di cui non ci resta che il titolo: The Owl In Daylight.
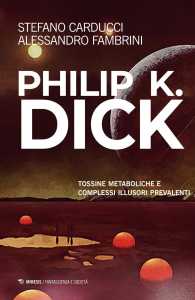
Philip Dick resta, insieme al britannico James G. Ballard, l’esempio maggiore di come la fantascienza, attraverso l’intermittente estenuazione o inibizione dei suoi topoi più popolari e scontati, possa trasformarsi davvero in narrativa sperimentale, espressione speculativa della postmodernità. Ballard, a differenza di Dick – ma va considerato il contesto britannico, diverso da quello statunitense – non considerò mai la fantascienza come un sottoscala infamante della letteratura, la sua progressiva annessione al mainstream avviene per osmosi naturale. In Dick invece i due mondi sono sempre paralleli e conflittuali e quello fantascientifico viene percepito come un ghetto, una prigione dalla quale fuggire. Pagetti, confrontando l’uso di un analogo deus ex machina – due inesplicati processi para-scientifici, la Fase Hobart che inverte il flusso del tempo in Counter-Clock World di Dick e la lenta e progressiva cristallizzazione del pianeta in Crystal World di Ballard – coglie anche un’altra sostanziale differenza fra i due scrittori: “la New wave SF britannica attinge a un linguaggio intellettualistico, memore di una visione squisitamente letteraria […] l’americano Dick rimane a stretto contatto con la cultura popolare gotica e apocalittica, contaminata dal cinema e dalla televisione, e anche da quegli interessi teologici che sono del tutto estranei a Ballard. Mentre il mondo di Ballard è sostanzialmente darwiniano (con innesti ora junghiani, ora freudiani), quello di Dick è invaso da echi sovrannaturali, da oscure presenze spirituali, da inquietanti premonizioni”.
Forse anche per questi aspetti, la natura messianica e apocalittica del suo sense of wonder e l’accentuazione delle componenti fortemente “disfunzionali” del suo realismo, Pagetti considera Dick non tanto o non soltanto un autore postmoderno, quanto l’ultimo e il più attardato modernista, se si vuole addirittura ipermodernista.
Dal canto loro Carducci & Fambrini concludono riprendendo, distanziandosene in parte, alcune delle tesi di uno storico saggio su Dick di Stanislaw Lem, noto autore fantascientifico polacco, un “collega” con il quale Dick ebbe un rapporto ambiguo e conflittuale: i concetti di fantasmagoria e di labirinto che per altri critici sono solo sintomo della confusione e della scarsa lucidità della maggioranza delle trame dickiane, rendono lo scrittore grande e mediocre al tempo stesso. Il sostanziale nihilismo, l’ossessione entropica di Dick lo rendono congruentemente abissale e pertanto interessante; la sua opera, fatta di romanzi non riusciti o riusciti solo in parte, ha un valore complessivo che si rimanda da testo a testo e che è, come corpus totale, coerente e non contraddittoria al di là delle singole contraddizioni, delle imperfezioni, delle imprecisioni. “Che cos’ha di tanto ‘rivoluzionario’?” – si chiede Carducci – “Perché quello che per alcuni, me compreso, è un’accozzaglia confusa di temi che fanno a pugni uno con l’altro per tanti è complessità di visione ?”. La domanda, a conclusione del saggio, resta senza risposta. O forse, poche righe sopra ha già risposto Fambrini: “Ecco l’effetto-Dick: la mente si allarga. O rincretinisce. A piacere”.



