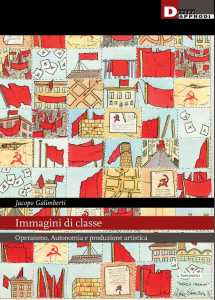 Nanni Balestrini, Gianfranco Baruchello, Pablo Echaurren, il Gruppo N, Milli Gandini, il Gruppo Femminista Immagine, e ancora tanti e tante altre: in presenza di tutti questi nomi sembra strano, e tuttavia sintomatico, che la ricerca sulle teorie e pratiche estetiche connesse all’operaismo e all’autonomia italiana siano state per lungo tempo monografiche e, in virtù di questo, frammentarie, se non anche disseminate o disperse. Negli ultimi tempi, però, il lavoro di Jacopo Galimberti – insieme a quello di altre studiose e studiosi in bibliografia, come ad esempio Steve Wright (autore de L’assalto al cielo. Per una storia dell’operaismo, tradotto in italiano da Alegre nel 2008, ma anche, più recentemente, di The Weight of the Printed Word: Text, Context and Militancy in Operaismo, del 2021) – ha contribuito a ricostruire la vasta articolazione di quel panorama socioculturale, in una pubblicazione monografica uscita dapprima in inglese, per Verso, nel 2022 e ora disponibile in italiano con il titolo di Immagini di classe. Operaismo, Autonomia e produzione artistica (DeriveApprodi, 2023). Finalmente un’analisi “organica”, si potrebbe dire, anche se con qualche cautela, concordando con l’autore sulla necessità di una prospettiva critica ponderata sulle questioni connesse all’«estetica» analizzata nel libro, che in effetti emerge come «un insieme di pratiche visuali e di strategie comunicative, che non presuppongono l’esistenza di un canone o di un sistema» (p. 12). Autrici e autori fuori dal canone e dal sistema, dunque, se non per emersioni individuali – come ad esempio quelle di Nanni Balestrini e Gianfranco Baruchello, ma sempre sull’onda di un’opera più ampia di quella connessa ad operaismo e/o autonomia – eppure un insieme, appunto, “organico” e che si presta a una visione d’insieme.
Nanni Balestrini, Gianfranco Baruchello, Pablo Echaurren, il Gruppo N, Milli Gandini, il Gruppo Femminista Immagine, e ancora tanti e tante altre: in presenza di tutti questi nomi sembra strano, e tuttavia sintomatico, che la ricerca sulle teorie e pratiche estetiche connesse all’operaismo e all’autonomia italiana siano state per lungo tempo monografiche e, in virtù di questo, frammentarie, se non anche disseminate o disperse. Negli ultimi tempi, però, il lavoro di Jacopo Galimberti – insieme a quello di altre studiose e studiosi in bibliografia, come ad esempio Steve Wright (autore de L’assalto al cielo. Per una storia dell’operaismo, tradotto in italiano da Alegre nel 2008, ma anche, più recentemente, di The Weight of the Printed Word: Text, Context and Militancy in Operaismo, del 2021) – ha contribuito a ricostruire la vasta articolazione di quel panorama socioculturale, in una pubblicazione monografica uscita dapprima in inglese, per Verso, nel 2022 e ora disponibile in italiano con il titolo di Immagini di classe. Operaismo, Autonomia e produzione artistica (DeriveApprodi, 2023). Finalmente un’analisi “organica”, si potrebbe dire, anche se con qualche cautela, concordando con l’autore sulla necessità di una prospettiva critica ponderata sulle questioni connesse all’«estetica» analizzata nel libro, che in effetti emerge come «un insieme di pratiche visuali e di strategie comunicative, che non presuppongono l’esistenza di un canone o di un sistema» (p. 12). Autrici e autori fuori dal canone e dal sistema, dunque, se non per emersioni individuali – come ad esempio quelle di Nanni Balestrini e Gianfranco Baruchello, ma sempre sull’onda di un’opera più ampia di quella connessa ad operaismo e/o autonomia – eppure un insieme, appunto, “organico” e che si presta a una visione d’insieme.
Altrettanto sintomatico, poi, risulta il fatto che tale lettura sia stata resa disponibile al pubblico italiano pochi mesi prima della morte di Toni Negri, circostanza che ha fatto riemergere (spesso incontrastata, a livello mediatico) l’etichetta del «cattivo maestro» e l’ombra lunga del Processo 7 Aprile – denominazione di vari procedimenti penali istituiti tra il 1979 e il 1988 contro alcuni esponenti di Autonomia Operaia – ossia dell’evento storico che anche Jacopo Galimberti pone a chiusura della propria ricognizione, cogliendone traccia, en passant, in una delle poche opere più recenti citate nel volume, la performance Il Processo (2010-2013) di Rossella Biscotti.
Del resto, è stata davvero una conclusione inequivocabile, quella del Processo 7 Aprile, per molte delle esperienze connesse all’autonomia e dunque anche per la produzione estetica correlata – una chiusura netta, però non definitiva, come si può notare anche solo ricordando la durata di quei procedimenti (corrispondente a buona parte degli anni Ottanta, e dunque in una forte relazione di legittimazione reciproca con il clima culturale e politico del periodo) nonché gli eventi successivi, che ne hanno prolungato e complicato l’acquisizione storica. Dilazione, questa, che è visibile anche nella produzione successiva al 1988 delle autrici e degli autori chiamati in causa da Galimberti, riportando anche alle questioni finali poste dal volume e richiamate anche alla fine di questa nota.
In ogni caso, Galimberti sceglie di mantenere l’attenzione perlopiù circoscritta agli anni Sessanta e Settanta, allungandosi, in genere, soltanto fino ai primi anni Ottanta. Di fondamentale importanza appare allora il primo capitolo, dedicato in buona parte alla rivista classe operaia (1964-1967) con una linea grafica modernista – curata da Manfredo Massironi, per la prima edizione, e da Cesare Greppi e Mario Mariotti, per la seconda – che tornerà ad echeggiare anche in altre pubblicazioni successive. Mariotti, inoltre, è giustamente ricordato e analizzato da Galimberti per i suoi disegni, che oscillano tra «mostruose divinità e antichi dei» – come chiosa l’autore, in un titolo di sezione – nella figura di un operaio che non è modello né archetipo, bensì la risultante, più che la risposta, di una domanda (che rinvia, fra gli altri, alla lettura di Deleuze, Marx and Politics di Nicholas Thoburn del 2003): «se si sostiene che la classe operaia vive una condizione di non-identificazione con sé stessa (con sé stessa in quanto capitale da sconfiggere), com’è possibile rappresentarla?» (pp. 53-54). Una domanda dal contenuto aporetico, suggerisce Galimberti; del resto, lo è anche il principio posto a cardine della critica della cultura – critica non già e non solo dell’industria culturale – e allo stesso tempo dell’estetica dall’operaismo: «Se le “battaglie culturali” definivano una realtà sociale e un insieme di istituzioni dove le tesi e antitesi trovavano una sintesi, gli operaisti non potevano che condannare la cultura come un’ideologia di cui il capitalismo si serviva per neutralizzare l’inestirpabile “negazione” operaia» (p. 39).
Le aporie si devono, sul piano teorico, sul fatto che siamo nei pressi di un «marxismo antidialettico» – come Galimberti sottolinea subito dopo, per quanto en passant – che sceglie di non agire, nemmeno con proposito demistificante, sulle provvisorie sintesi delle “battaglie culturali” (articolando su questo punto teoria e prassi), preferendo invece inasprire la propria irriducibile negazione e le contraddizioni che le sono relegate. Da questo punto diramano e a questo punto ritornano altri momenti analizzati nel libro, come l’apologia del kitsch da parte del gruppo di architetti fiorentino Archizoom o, successivamente, l’interrogazione inesausta e al tempo stesso irrisolta sull’abitabilità da parte di altri designer e architetti, più vicini a Potere Operaio.
Particolarmente rilevante, in questo senso, è allora la produzione teorica di uno storico di architettura come Manfredo Tafuri, specialmente nella sua fase di contatto con l’operaismo, dal quale si sarebbe poi progressivamente distaccato. Si pensi, ad esempio, a un suo importante articolo uscito sul secondo numero di Contropiano, nel 1970, “Lavoro intellettuale e sviluppo capitalistico”. Continuando a riflettere sulle avanguardie storiche (referente, peraltro, di molte altre produzioni e teorizzazioni del periodo), Tafuri sottolinea il progressivo avanzamento delle dinamiche di proletarizzazione del lavoro intellettuale – dal fordismo, con il mito dell’artista “maestro” del sistema industriale, fino all’era computazionale, in cui questo mito era definitivamente tramontato – e la necessità di non contrapporre a questo processo una lotta per restituire “dignità” (dunque: né compensazioni simboliche né materiali, tra l’altro solitamente irrisorie) a tale lavoro, preferendo, invece, il tentativo di incentivarne le contraddizioni fino a farle esplodere. Una prospettiva, questa, che non manca di risuonare con alcune tensioni ideologico-estetiche a proposito della cosiddetta «fabbrica cibernetica» all’interno del Gruppo N (composto, tra gli altri, da Ennio Chiggio, Toni Costa e Manfredo Massironi), attivo a Padova dal 1959 ai primi anni Sessanta e diviso «tra Olivetti e operaismo» – come, del resto, già recitava il titolo di questo articolo pubblicato da Galimberti su Operaviva nel 2016.

Si tratta di un fil rouge, o meglio di una articolazione e concatenazione, che continua ancora attraverso gli studi sulla Olivetti di Romano Alquati, fino alla definizione della «conricerca» sperimentata come tale da Alquati da un altro intellettuale cremonese dell’epoca, Danilo Montaldi – nome già emerso in un Primo piano ospitato su PULP e apparentemente di estrazione molto diversa come quello dedicato, nel mese di dicembre 2023, a Gianni Bosio. Galimberti dedica un intero capitolo a Montaldi, restituendone un ritratto a tutto tondo che non si sofferma soltanto sulla nota distinzione, per l’autore delle Autobiografie della leggera (1961), tra “popolare” e “populista”, ma anche sulla sua corrispondenza con l’artista Giuseppe Guerreschi (1929-1985) – del quale il ricco apparato iconografico che intervalla i capitoli del libro ripropone un’opera importante, anche per l’analisi di Galimberti, come Giovane profeta (1969) – nonché un abbozzato e singolare confronto con l’intervento nel campo delle arti visive di Carla Lonzi. Pur nella diversità dei posizionamenti e degli approcci, infatti, «sia Montaldi che Lonzi» scrive Galimberti «possono essere ascritti alla tradizione epistemologica della conricerca, in quanto entrambi provarono a dare legittimità e potere ai propri interlocutori, mettendo in discussione la presunta necessità di una guida, di un’avanguardia o di un intellettuale che parlasse a loro nome» (p. 190). Ciò che si chiama a grande voce, nelle righe immediatamente precedenti, è il rapporto speculare tra PCI e gruppi operai, da un lato, e Giulio Carlo Argan e artisti, dall’altro (già avanzato da Vanessa Martini nel suo contributo all’antologia di saggi Carla Lonzi: la duplice radicalità del 2011): una specularità che, appunto, non vale soltanto per la polemica tra Lonzi e Argan, ma anche per la conversazione tra Montaldi e Guerreschi, il quale, come osserva Galimberti, firmato un’introduzione di proprio pugno al catalogo de I profeti, sempre del 1969, «che si avvicina[va] alla prosa di Autoritratto» (p. 189). Similitudini affascinanti, dunque, che la scrittura di Galimberti non insegue, in questo caso, con il puntiglio critico che dedica ad altre figure e relazioni – alla produzione saggistica di Asor Rosa e Cacciari, ad esempio – ma che aprono continuamente nuovi scenari dentro l’organicità di fondo che è già stata sottolineata.
Si potrebbe andare avanti ancora a lungo; di fatto, sino a qui si è cercato di unire alcuni punti toccati dal libro, la cui struttura reticolare e la molteplicità di analisi e riferimenti, storicamente e teoricamente informati, supera tuttavia, e di gran lunga, i limiti di questa nota. Non si può però tralasciare, in chiusura, di segnalare almeno un’altra possibile apertura del testo, che ne ricollega la preziosa lettura a tempi più recenti. Si tratta dell’accostamento, inevitabilmente conflittuale, delle varie prospettive operaiste e poi autonome sul lavoro intellettuale e artistico con l’attuale scenario, dominato dalla logica dell’Arricchimento analizzata nel sistema, o nei sistemi, dell’arte da Luc Boltanski e Arnaud Esquerre nel libro omonimo, come «uno dei principali canali dell’accumulazione capitalistica, in particolare per Paesi con una forte vocazione turistica» (p. 376) come l’Italia. Accumulazione e concentrazione di potere, dunque, che rende più evidente il suo contraltare di proletarizzazione del lavoro intellettuale, per ricorrere al già menzionato Tafuri: ricorrere a prospettive antagoniste, in questo senso, non ha soltanto un valore pratico legato alla militanza, ma anche alla riaccensione di uno scenario artistico-curatoriale che appare sempre più omogeneo nel dimostrarsi «spesso incline […] a discorsi dalle sfumature identitarie» (p. 376), restando, di conseguenza, pienamente subalterno alla logica dell’accumulazione appena enunciata.
Da qui deriva un’altra domanda che è anche un auspicio per la continuazione della ricerca fatto da Galimberti stesso, per chi vorrà entrare in dialogo con il suo importante e articolato contributo: «Qual è, oggi, l’iconografia dei movimenti anticapitalisti? Quali sono i discorsi veicolati dall’immaginario politico diffuso dai social network? In che modo questo immaginario può incidere sull’emergere di un soggetto politico transnazionale e su un’eventuale identificazione con esso?» (pp. 376-377, corsivi aggiunti).
Pur nella stringatezza di questi interrogativi finali – una concisione che pare assolutizzare alcuni elementi, come quelli evidenziati in corsivo, che sono invece aperti alla problematizzazione, da parte di Galimberti stesso – questa può essere una domanda fondamentale che ci si porta dietro dopo la lettura del libro: per usare il titolo di un’opera di Baruchello del 1976 (e mantenendone l’ironia rispetto alla “spiegazione”), Come spiegare Marcel Duchamp al proletariato giovanile non solo del 1976, ma di oggi?



