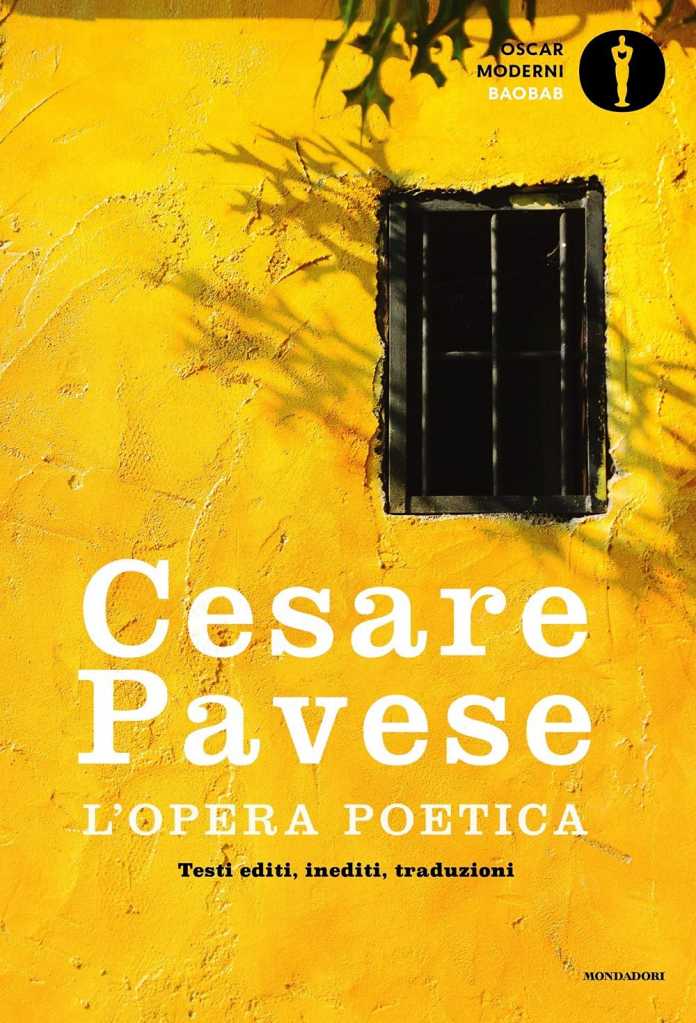Cesare Pavese era un poeta al lavoro. E, stancandosi, componeva il romanzo novecentesco della poesia, timido ma risoluto, mettendo le mani nelle Foglie d’erba ottocentesche di Whitman, americane, eroticamente adese alle consuetudini vitali del corpo langarolo. Al grande pubblico la novità arrivò con i romanzi La casa in collina, La bella estate e soprattutto La luna e i falò (1948-1950), ma la prima uscita di Lavorare stanca è del 1936 nelle edizioni di Solaria a cura di Alberto Carocci. E da lì le vicende editoriali delle poesie si dispiegano fra ripensamenti, censure e riprese, in una complessa storia documentata dalle numerose pubblicazioni successive e dagli autografi rinvenuti. La poesia di Pavese scavalca quei territori ben conosciuti in ogni fosso e rivolo d’acqua, come fossero il corpo ardente di belle ragazze giunte sì dai mari del Sud ma ben piantate sul fianco dei colli natii e completamente perdute nell’idioma pavesiano dallo sguardo raccolto – per sempre.
 Gli antenati erano molteplici e familiari a partire da fanciullezza e gioventù, lo dimostra il vasto volume dell’Opera poetica, che raccoglie traduzioni, imitazioni, sperimentazioni con uno studio “matto” (guidato da Vincenzo Monti, suo maestro di cose letterarie) su Umanesimo, Rinascimento e Classicità. Fino ai giorni in cui, scoprendo Whitman e Lee Masters, Pavese troverà sorte nuova nel mondo parallelo dove bagnarsi consapevole volgendosi allo “sporco” del mondo che nutre ritmo e corporalità della sua scrittura. Quel ritmo di cui parlerà nel Mestiere di poeta e che ancora oggi fa ripensare a quanto la “modernità” di Baudelaire abbia potuto influenzare il paesaggio mentale, sempre più consapevole, del giovane Pavese. “Un solo respiro”, dunque, per tutta l’opera maggiore riunita in unico racconto. L’espressione in Mari del sud è il primo grande esperimento, il “tener duro” narrando, togliendo di mezzo ogni “decorazione gratuita”.
Gli antenati erano molteplici e familiari a partire da fanciullezza e gioventù, lo dimostra il vasto volume dell’Opera poetica, che raccoglie traduzioni, imitazioni, sperimentazioni con uno studio “matto” (guidato da Vincenzo Monti, suo maestro di cose letterarie) su Umanesimo, Rinascimento e Classicità. Fino ai giorni in cui, scoprendo Whitman e Lee Masters, Pavese troverà sorte nuova nel mondo parallelo dove bagnarsi consapevole volgendosi allo “sporco” del mondo che nutre ritmo e corporalità della sua scrittura. Quel ritmo di cui parlerà nel Mestiere di poeta e che ancora oggi fa ripensare a quanto la “modernità” di Baudelaire abbia potuto influenzare il paesaggio mentale, sempre più consapevole, del giovane Pavese. “Un solo respiro”, dunque, per tutta l’opera maggiore riunita in unico racconto. L’espressione in Mari del sud è il primo grande esperimento, il “tener duro” narrando, togliendo di mezzo ogni “decorazione gratuita”.

Poi è vero che le aspirazioni, cominciando da Lavorare stanca, s’organizzano intorno alla società (fin lì vista) e al potere intrinseco dei corpi giuntigli dalla sacralità classica: nel volume dell’Opera poetica si possono rintracciare, finalmente, le origini di quel che sarà, gli esercizi di stile del giovanissimo alle prese con desideri sessuali e slanci di una scrittura poetica tesa a fuoriuscire, stracciandone i confini, dalla lirica italiana. Nelle spudoratezze dell’apprendista, con tutte le sue intenzioni, passando dal vecchio gruppo di poesie al nuovo – convincendosi sempre più che il campo della prosa non gli era di sudditanza – Pavese s’avventurerà nella descrizione di una realtà simbolica dove però le immagini diranno sempre qualcosa di contrario ai conformismi, alle ipocrisie. E se poi il lettore, innamorato o critico, si sente spiazzato confrontando i racconti di Feria d’agosto e Pensieri di Deola con la frantumazione ritmica di poesie – riunite postume nel 1951 ma in parte pubblicate in rivista nel 1947 –, come per esempio La terra e la morte, non avrà che da leggersi le minuziose e profonde annotazioni inserite in Introduzione e Nello scrittoio di C. P. rispettivamente di Antonio Sichera e Antonio Di Silvestro, curatori del volume. Il lettore vedrà il riflesso di una vita sperimentale dove il dissenso sta al centro, così come l’amore per le donne, risolto in elegia estesa ai terreni battuti, dove carta e inchiostro vengono sovrapposti al paesaggio: i passanti sperduti ammaliano l’autore come le poesie, vecchie e nuove, ammaliano il lettore confrontandosi in simile condizione umana.

Pavese crea il verso così come probabilmente non è mai riuscito a fare con la propria vita – è vero però che lì dentro c’è la vita di tutti, miracolosamente (o telluricamente) intonata alle colline, per chi ha le colline, al mare per chi ha il mare, ma sempre battuta dal ritmo. Quel ritmo che in tutti s’agita nell’innamoramento e nella soluzione di un problema, e che spinge a pensare:
“Sarà un giorno tranquillo, di luce fredda / come il sole che nasce e che muore…”