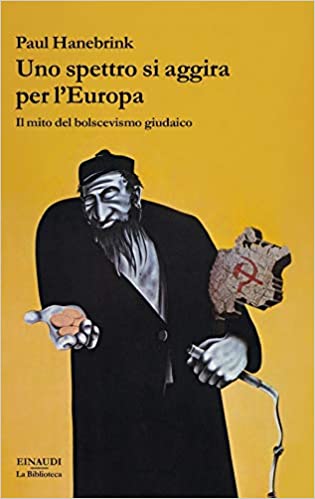Il libro di Paul Hanebrink, docente di storia alla Rutgers University del New Jersey, costituisce uno stimolante contributo di approfondimento relativamente a una tematica poco frequentata dalla pubblicistica storiografica, forse perché concernente un abbinamento in disuso (non del tutto, come dimostra l’autore) o, comunque, totalmente screditato dalle tragedie del secolo scorso.
Il volume prende le mosse dall’innestarsi del secolare sentimento antisemita diffuso in Europa, che nel Diciannovesimo secolo si era nutrito dell’accusa all’ebraismo di incarnare le mire egemoniche della grande finanza (inclinazione questa rianimatasi in questi ultimi anni e forse mai scomparsa del tutto. George Soros docet), sui rivolgimenti rivoluzionari del primo Novecento (la rivoluzione russa in primis), ritenendo gli ebrei artefici della dottrina e del movimento marxista nella prospettiva della conquista e sottomissione del mondo intero. Il mito del bolscevismo giudaico affonda le radici nella negazione di una reale autonomia di pensiero e iniziativa al marxismo, considerato nella sua natura di subdolo strumento ideato dalla stirpe ebraica a fini di predominio (Marx, del resto, era pur sempre un ebreo), coerentemente al messianesimo insito nella religione veterotestamentaria e, di conseguenza, al ruolo palingenetico assegnato al popolo eletto. La nutrita presenza di ebrei tra le schiere dei partiti comunisti (Trotskij, Kamanev, Zinoviev, Radek, Toller, Eisner, Luxemburg, Bela Kun, etc…) costituisce una prova incontrovertibile di questa equazione, che diventa una costante della propaganda dell’estrema destra europea tra le due guerre. La minoranza ebraica, da sempre ostile alla comunità cristiana in cui è inserita, intercetta il sovversivismo comunista in funzione antioccidentale e anticristiana e il tutto interpretato come frutto di una modernità patogena veicolata da un liberalismo illuminista distruttivo della tradizione. La stessa iconografia propagandistica di destra riproduce il bolscevico ispirandosi ai canoni della fisiognomica antisemita, non risparmiandosi nemmeno, con sprezzo del ridicolo, di richiamare sovente nello stesso manifesto l’avidità di ricchezza da sempre attribuita all’ebreo (dopo la stipula del patto di non aggressione tedesco-sovietico del 1939, la propaganda nazista prende di mira soltanto l’ebreo capitalista).
Nell’Europa dell’est la conquista da parte dei tedeschi dei territori a suo tempo occupati dai sovietici a causa del patto Ribbentrop-Molotov (Polonia, stati baltici, Bessarabia e Bucovina rumene) scatenò sanguinosi pogrom antisemiti da parte della popolazione locale, che incolpava gli ebrei di aver collaborato con i sovietici. Ed è relativamente a questi scenari poco esplorati di olocausto “minore” e non addebitabile ai nazisti che il testo esibisce una nutrita (e agghiacciante) casistica densa di rimandi e riferimenti.
Nel dopoguerra il mito del bolscevismo giudaico si inabissa fino alla caduta del muro di Berlino, quando alcuni governi di destra dell’Europa dell’est lo rispolverano in riferimento ai precedenti regimi comunisti in un contesto di mai sopito antisemitismo. È egli Stati Uniti che durante la Guerra fredda si inaugura il concetto di civiltà “giudaico-cristiana” in contrapposizione al comunismo ateo e, in quanto sovietico, asiatico ed estraneo ai valori dell’Occidente. In particolare in questi ultimi anni nell’Europa delle migrazioni non solo il termine “giudaico” finisce per perdere ogni connotazione negativa, ma in connubio con il cristianesimo viene contrapposto all’islamismo veicolo di “inciviltà e terrorismo”.
Hanebrink richiama l’attenzione sulla traiettoria paradossale del mito del bolscevismo-giudaico, ricongiungendosi a un’attualità che vede il secondo termine dissociarsi dal connubio con la “negatività” del primo per contribuire alla costruzione della psicosi islamofobica. “Analizzando la funzione ideologica dell’idea di bolscevismo giudaico nella politica dalla fine della prima guerra mondiale, si vede come questo mito- una potente unione di razzismo e difesa ideologica- sia una delle fonti più ricche cui attinge l’odierno sentimento antimussulmano e anti-islamico” [p. 290]
Interessante, poi, il capitolo dedicato ai paesi satelliti dell’Unione Sovietica nel secondo dopoguerra. I regimi comunisti non solo non hanno represso e condannato l’antisemitismo proprio in quei paesi dove era particolarmente diffuso a livello di massa, ma l’hanno strumentalmente rinfocolato nelle lotte interne ai gruppi dirigenti all’epoca dei processi stalinisti, quando l’accusa di “filosionismo” e “cosmopolitismo” colpiva gli ebrei che venivano sospettati di “nazionalismo” o “titoismo” (Slanski, Pauker, London erano ebrei). Lo stesso ricordo dell’Olocausto e delle persecuzioni antisemite è stato offuscato sia assimilando il primo alla politica di sterminio nazista in generale (e quindi estendibile agli antifascisti, agli slavi e alle popolazioni sottomesse) sia attribuendo le seconde esclusivamente ai tedeschi.
Nei paesi dell’Europa orientale è andato così sedimentandosi un processo di deresponsabilizzazione relativamente allo sterminio degli ebrei che è culminato negli anni post ’89, e in particolare quando le destre sono andate al governo, in una completa rimozione della partecipazione delle popolazioni locali all’Olocausto, sino ad arrivare alla legge recentemente proposta dal governo polacco che vieta ogni riferimento in proposito.
Dopo una lodevole e particolareggiata disanima degli sviluppi sull’argomento verificatisi nelle società postcomuniste, che confermano quanto la curvatura nazionalista in atto abbia riattivato in esse il veleno di un antisemitismo coniugato con l’anticomunismo, Hanebrink conclude: “Il mito giudeo-bolscevico è rinato nell’Europa postcomunista come strumento per mettere in discussione le premesse su cui si basa la Memoria transnazionale dell’Olocausto, con queste premesse anche gli ideali civili liberali di tolleranza multiculturale, di diritti umani e di integrazione europea che la cultura della Memoria dell’Olocausto è giunta a simboleggiare in maniera tanto potente” [p. 281].