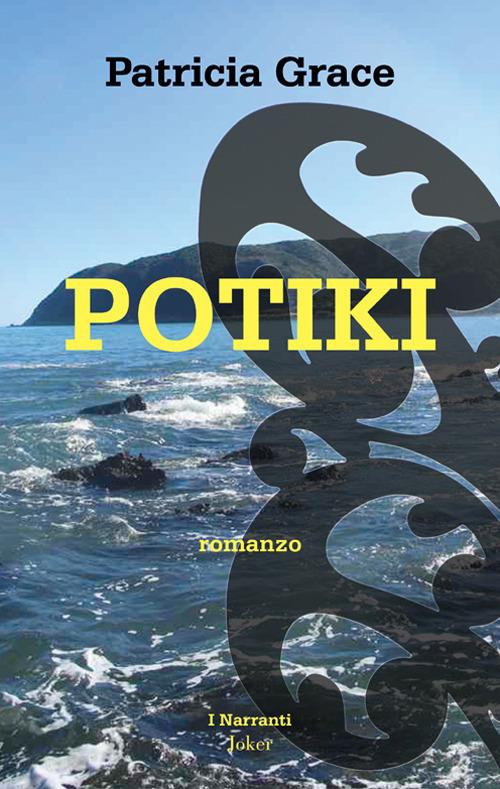Se c’è una cosa che la letteratura riesce a fare bene, è farti entrare in un mondo diverso e farti visitare terre lontane. Ora, c’è una terra più lontana dall’Italia della Nuova Zelanda? Il mappamondo dice di no (e concorda anche Google Earth!). Proprio dalle due isole ai nostri antipodi ci arriva, a “soli” trent’anni dalla pubblicazione nel suo paese, questo romanzo di Patricia Grace, considerata una delle più importanti narratrici maori. Perché i maori non vanno solo per mare, non si limitano a giocare a rugby e danzare la haka prima delle partite: scrivono anche loro.
In questo caso si racconta la storia, al tempo stesso estremamente realistica e favolosa, di una famiglia maori che sceglie di restare sulla propria terra e di vivere dei suoi prodotti; una scelta difficile in Italia, ancor più complicata in Nuova Zelanda dove per lungo tempo i nativi sono stati discriminati ed emarginati, per cui si è sempre pronti a spazzarli via per far posto ad affari e speculazioni più o meno da rapina. E questo sta per accadere alla famiglia di Hemi e Roimata, che pure ha avuto la fortuna di conservare le terre ancestrali, incluso il wharenui (la casa comune polinesiana dove s’incontrano tutte le famiglie di un villaggio e dove si celebrano tutti i riti più importanti) e l’urupa (il cimitero, che per una cultura fondata sul rapporto con gli antenati riveste un’importanza enorme).
Sarebbe una vita tutto sommato serena, non fosse che proprio sulle colline sovrastanti le terre ancestrali dei protagonisti del romanzo arriva uno speculatore piuttosto spregiudicato (diciamo un maneggione mezzo delinquente, che ricorda anche troppo certi personaggi di casa nostra…), per il quale quei contadini e pescatori maori che si frappongono tra lui e l’accesso diretto al mare sono solo un branco di pezzenti da togliersi di torno con un tozzo di pane. Ma Hemi è convinto che la sua famiglia e la sua piccola comunità debbano assolutamente restare sulla terra, perché perderla significherebbe essere privati di tutto, inclusa la propria dignità. Quindi si arriva all’inevitabile scontro con lo speculatore, i cui esiti non posso ovviamente descrivere.
Dicevamo storia anche favolosa: nel romanzo c’è pure la vicenda di Toko, un bambino nato in circostanze non del tutto chiare da Mary, una ragazza con problemi mentali, e comunque adottato da tutta la comunità; Toko che è nato deforme, però ha la capacità di vedere il passato e il futuro. È attraverso di lui che entra nel romanzo la dimensione mitica, fantastica, riagganciandosi alla mitologia maori in modo nient’affatto gratuito, ma consentendo di leggere la vicenda al tempo stesso con gli occhi della cultura occidentale e di quella polinesiana. E Grace riesce a farci entrare anche nella seconda, pur restando aderente alla vita quotidiana dei suoi personaggi; la vita di una famiglia che rischia di trovarsi, come si suol dire, in mezzo a una strada.
E a vederli così da vicino, i maori, ti viene da pensare che tutto sommato li capisci anche troppo bene. Nonostante l’uso che ogni tanto l’autrice fa di parole della loro lingua; anzi, proprio grazie ad esse (e a un glossarietto approntato dalla traduttrice, che sicuramente ha avuto il suo da fare per rendere lo stile molto originale, a tratti poetico, del romanzo). Li capisci entrando nei loro affetti, nelle loro speranze, nelle loro paure, nelle loro piccole e grandi tragedie, e Grace te li sa presentare con grande efficacia attraverso una narrazione che ha molto di parlato, ma anche momenti decisamente lirici.
Insomma, entra nel nostro paese una voce narrativa che non conoscevamo, ed è sempre un bene; non resta che augurarsi che vengano tradotte altre opere della Grace, che ha alle spalle quasi quarant’anni di romanzi e racconti. Dobbiamo recuperare il tempo perduto; e speriamo che questo lo capisca anche la nostra editoria.
4 Settembre 2017