Un giorno, un virus: come si racconta il non umano ?
In Contagion (2011), Steven Soderbergh descrive in modo ‘realistico’, cioè al di fuori di molte convenzioni spettacolari che caratterizzano il filone del cinema catastrofico hollywoodiano, la situazione che il mondo ha conosciuto in questi ultimi due anni, in seguito all’ emergenza pandemica scatenata dal virus SARS-CoV-2. Soderbergh mette in scena un thriller collettivo, con un fitto intreccio di archi narrativi e di personaggi (scienziati, giornalisti, militari, politici etc), riuscendo a restituire attraverso il film le molteplici dinamiche epidemiche di una società complessa. Soderbergh le azzecca quasi tutte, con 10 anni di anticipo: c’è un virus estremamente contagioso e letale che arriva dalla Cina, originato da una zoonosi fortuita tra suini, pipistrelli e umani; la caccia disperata al paziente zero in un mondo sempre più interconnesso e globalizzato; l’allarme mondiale, i lockdown, il distanziamento sociale, l’invito insistito alla profilassi, a non toccarsi il volto e a lavarsi spesso le mani. E, dall’altra parte, le proteste e le violenze collettive che esplodono nelle strade, il blog di fake news e il teorico della cospirazione governativa (Jude Law) con milioni di followers, convinti che il virus si possa sconfiggere con un rimedio omeopatico, la forsythia. Una volta “scoperto” il vaccino, non mancano il green pass vaccinale con codice a barre da portare al polso, i tempi di industrializzazione per immunizzare 7 miliardi di persone e, infine, la sensazione che, al di là del lieto fine, la storia possa ripetersi invariata in qualsiasi momento nel prossimo futuro.
Quello che manca nel film – e che noi stiamo imparando faticosamente a riconoscere – è in un certo senso, proprio l’agentività del suo protagonista, il virus. Quello che non vediamo è la danza delle sue ininterrotte mutazioni, sottratta all’esperienza diretta e ai mezzi della narrativa umana, intercettata per noi nei laboratori sulla scala dell’infinitamente piccolo e classificata in base agli effetti che sulla scala antropocentrica più ci interessano (economia, sanità, coesione sociale..), per trasformarsi alla fine nelle metafore che corroborano il lessico e il discorso quotidiano sulla pandemia (l’immunità, la guerra al virus, il ritorno alla normalità..). Come osserva Marco Malvestio : “La scarsa narrabilità della pandemia (perfettamente coerente con quella dell’Antropocene) ha anche a che fare con le scale temporali in cui questo tipo di eventi si svolge. Anche l’andamento non lineare della malattia, con la sua crescita esponenziale alternata a periodi di latenza, non rende il suo racconto coerente con le esigenze di climax delle narrazioni sensazionalistiche; ne il raggiungimento dell’immunità tra i sopravvissuti significa effettivamente una fine del fenomeno, perché la malattia potrà sempre ripresentarsi, mutata, in futuro.”. [1]
La difficoltà di raccontare il non umano a cui si riferisce Malvestio non è infatti limitata allo storytelling dello stato pandemico, di cui stiamo oggi sperimentando tutta l’inadeguatezza. Tantomeno simile difficoltà è da ascriversi al solo cinema hollywoodiano che, attingendo alla letteratura di genere e più tardi al fumetto, ha semmai adattato ai suoi canoni le pulsioni distopiche che circolano nelle nostre società, registrandole nell’immaginario collettivo. Da questo punto di vista, cioè dal nostro punto di vista come civiltà culturale, la linea che ha demarcato il confine narrativo tra il nostro mondo e quello interminato e sporco dei fenomeni naturali, emerge forse più chiaramente dalla letteratura “seria” del Novecento, e, più in generale, dal paradigma del romanzo moderno, come ha messo in luce tra i primi Amitav Ghosh:
“Dovremmo chiederci innanzitutto qual è il posto del non umano nel romanzo moderno. Rispondere a questa domanda significa affrontare un altro dei perturbanti effetti del surriscaldamento globale: proprio quando questa attività umana cominciava a modificare l’atmosfera terrestre, l’immaginazione cominciò a concentrarsi esclusivamente sull’umano”. [2]
Terrestre vs globale: lezioni di storia dall’Antropocene
Ma, andando oltre, se il modo in cui raccontiamo oggi il non umano discende per forza di cose dalla tradizione della modernità, come indica nelle sue conclusioni il saggio di Ghosh, con essa difficilmente potremo fare i conti senza prima farli con il modo in cui per secoli abbiamo raccontato noi stessi come specie sapiens: non semplicemente in opposizione o ai vertici della piramide naturale ma su un piano temporale dedicato e nettamente distinto, appositamente per noi. Il piano storico, appunto. Detto in altri termini, la nostra difficoltà a percepirci sullo stesso livello evolutivo di una spugna o di una cometa ha radici profonde nella grande narrazione della Storia prima ancora che nelle piccole storie di una climate fiction o in un film di Roland Emmerich. Una cesura che, almeno dal punto di vista della metodologia critica, oggi però non è più scontata nemmeno per gli storici di professione. Un impulso in questa senso, o per meglio dire una bomba, è arrivata a cavallo degli anni ‘10, dalla riflessione dello storico indiano Dipesh Chakrabarty, noto fino a quel momento soprattutto per il suo contributo ai subaltern studies postcoloniali e per il classico “Provincializzare l’Europa” (2000).
 Nel suo saggio “The climate of History: four thesis” (2009), ora tradotto in Italia da Nottetempo [3] avanza una serie di ipotesi rivoluzionarie a partire dalla considerazione che con il cambiamento climatico “la nostra concezione storiografica del presente finisce per avere effetti estremamente distruttivi sulla visione della storia in generale”. La prima tesi di Chakrabarty, e probabilmente la più sconvolgente per uno storico, ipotizza che “le spiegazioni antropogeniche del cambiamento climatico comportano la crisi della secolare distinzione umanistica tra storia naturale e storia umana”. Le altre tesi sono conseguenti: l’idea di Antropocene, cioè di un’epoca in cui gli esseri umani si riconoscono come “potenza geologica”, dovrebbe ridimensionare in maniera decisiva la storia della modernità/globalizzazione (seconda tesi). Ciò ci obbligherebbe oggi a mettere in relazione e a intersecare le storie globali del capitale con la storia della specie umana, che in definitiva ci accomuna (terza tesi), un processo che “mette alla prova i limiti della comprensione storica.” (quarta tesi).
Nel suo saggio “The climate of History: four thesis” (2009), ora tradotto in Italia da Nottetempo [3] avanza una serie di ipotesi rivoluzionarie a partire dalla considerazione che con il cambiamento climatico “la nostra concezione storiografica del presente finisce per avere effetti estremamente distruttivi sulla visione della storia in generale”. La prima tesi di Chakrabarty, e probabilmente la più sconvolgente per uno storico, ipotizza che “le spiegazioni antropogeniche del cambiamento climatico comportano la crisi della secolare distinzione umanistica tra storia naturale e storia umana”. Le altre tesi sono conseguenti: l’idea di Antropocene, cioè di un’epoca in cui gli esseri umani si riconoscono come “potenza geologica”, dovrebbe ridimensionare in maniera decisiva la storia della modernità/globalizzazione (seconda tesi). Ciò ci obbligherebbe oggi a mettere in relazione e a intersecare le storie globali del capitale con la storia della specie umana, che in definitiva ci accomuna (terza tesi), un processo che “mette alla prova i limiti della comprensione storica.” (quarta tesi).
Chakrabarty invita a mettere in relazione la storia documentata e la “storia profonda” della nostra specie perché “collegate alla storia della vita su questo pianeta”. L’asse della globalizzazione, su cui ruota anche il discorso della critica e dell’ anticapitalismo, osservato dalla prospettiva terrestre della storia naturale, offre ora una visuale completamente diversa: la cosiddetta rivoluzione agricola di diecimila anni fa, da cui possiamo far discendere anche quella industriale degli ultimi due secoli, osserva, non sarebbe stata possibile senza una molteplicità di condizioni geologiche e di fattori paleoclimatici, con cui oggi occorre ancora confrontarsi perchè “rimangono validi indipendentemente dalle nostre scelte politiche”. Muovendosi su un doppio registro, Chakrabarty colloca, non senza sollevare una scia di comprensibili polemiche, accanto alle tradizionali categorie storiografiche, la nozione di “specie”, riferita agli umani, al centro di un auspicato progetto di impronta scientifica multidisciplinare. Una storia che, secondo lo studioso indiano, potrebbe anche fornire un significato davvero storico alla crisi climatica, che diversamente non ne avrebbe nessuno. Si tratta di una prospettiva che, come chiarisce nell’altro saggio della raccolta, “Climate and Capital: on conjoined histories”, porta a distinguere ancora più nettamente i due piani del “globale” e del “planetario”: l’indeterminatezza e le incertezze non addomesticabili di quest’ultimo, caratterizzano infatti la vicenda terrestre in un senso ben diverso da quanto la semplice “gestione del rischio” possa permeare oggi le moderne società industrializzate. Come osserva in un passaggio conclusivo:
“L’immaginario che in questo caso viene messo in gioco non è umanocentrico. Esso allude a una crescente divaricazione nella nostra coscienza tra il globale – una storia esclusivamente umana – e il planetario, una prospettiva nella quale gli umani sono incidentali”. [4]
La riflessione di Chakrabarty prende più in generale le mosse dalla nozione di Antropocene, un termine coniato negli anni ottanta dal biologo Eugene F. Stoermer e ripreso all’inizio del 21esimo secolo dal Premio Nobel per la chimica Paul Crutzen, oggi ampiamente usato non solo per indicare le cause antropiche del riscaldamento globale ma, sempre più spesso, anche per distinguere l’attuale fase geologica, subentrata in epoca storica all’Olocene. L’Antropocene indica un radicale rovesciamento di prospettiva, là dove proprio all’apice attuale della sua potenza tecnica e tecnologica, alimentata dal consumo illimitato combustibili fossili che ha alterato i livelli di CO2 sul pianeta, la specie umana si riconosce per la prima volta come fattore di scala climatica, geologica etc alla pari delle forze della natura e dell’inorganico. Questo capovolgimento per altro non è univoco nella sua interpretazione e alimenta oggi, nella corsa globale alla sostenibilità, anche progetti di ingegneria climatica e di terraformazione antropica, che promettono un Antropocene più green.
Sulle origini dell’Antropocene non c’è concordanza assoluta tra gli studiosi, nelle formulazioni correnti viene in genere fatto cominciare, simbolicamente, con lo scoppio della prima bomba al plutonio di Trinity e l’inizio della Grande Accelerazione del dopoguerra o, alternativamente, retrodatato di due secoli, all’alba della prima rivoluzione industriale, quella del vapore e del carbone. Secondo altre interpretazioni occorre risalire ancora più indietro nel tempo, alla nascita della rivoluzione agricola e ai primi insediamenti umani di dodicimila anni fa.
Un oscuro scrutare: ecologia pulp e iperoggetti
E’ a quest’ultima datazione, più remota e per molti versi più confortevole, alla luce delle responsabilità ecologiche del capitalismo e della modernità, che, sembra rifarsi, indirettamente, anche Timothy Morton, con la nozione di “agrilogistica” delineata in Ecologia Oscura (Luiss, 2021), testo seminale del 2016 che è anche il quarto volume del filosof* inglese tradotto ora in italiano. Con la comparsa dei villaggi e delle prime coltivazioni di orzo e di segale, già a partire dal nucleo della civiltà mesopotamica emergerebbe secondo Morton “il concetto stesso di mondo, inteso come regione temporale pervasa dal destino umano“. La sua struttura logica, giunta all’età del carbone e ai nostri giorni attraverso l’intero ciclo della civilizzazione umana, poggerebbe su tre assiomi filosofici: a) l’inviolabilità del principio di non contraddizione b) la presenza, persistente nello spazio fisico e sociale, come significato ultimo dell’esistenza c) l’esistenza come esseri umani come qualità superiore dell’esistente.
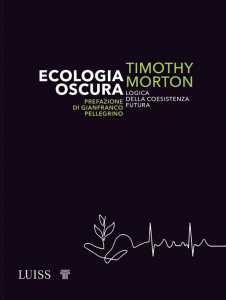 Per questa via il pensiero agrilogistico si fa normativo e piega ogni cosa al fine dichiarato di massimizzare la realizzazione del progetto umano, ottenendo come risultato un clamoroso effetto boomerang nel lungo termine. La relazione tra umano e non umano, inteso come risorsa e bene strumentale, si trasforma e si oggettivizza nel Neolitico, senza che tuttavia il filo si interrompa mai completamente. Riavvolgere il nastro, tornate indietro al Paleolitico o al nomadismo ipotizzato da filosofi primitivisti come John Zerzan, tuttavia non è possibile né auspicabile. Un pensiero ecologico secondo Morton, oggi si da solo a partire da un “essenzialismo weird” e dal riconoscimento dell’irriducibile stranezza dell’esistente, oggi suffragata dall’osservazione scientifica, dagli approdi della fisica quantistica come dagli studi di biosemiotica. Il gioco diventa parola chiave ma non corrisponde a un impulso estetico, liberatorio, o a un edulcorante sensuale per il soggetto, come pensava Schiller, quanto piuttosto a “un fatto organico rispetto al reale”. Per uscire dalla prigione e lasciarsi alle spalle l’agrilogistica occorre imparare a “subscendere” il reale nelle sue parti e ad accettarle per come si manifestano a noi – a cominciare da 10 milioni di specie microrganiche che concorrono a formare quello che chiamiamo “corpo umano” – e quindi come un groviglio inanellato e sporco, non come una superficie liscia e pulita:
Per questa via il pensiero agrilogistico si fa normativo e piega ogni cosa al fine dichiarato di massimizzare la realizzazione del progetto umano, ottenendo come risultato un clamoroso effetto boomerang nel lungo termine. La relazione tra umano e non umano, inteso come risorsa e bene strumentale, si trasforma e si oggettivizza nel Neolitico, senza che tuttavia il filo si interrompa mai completamente. Riavvolgere il nastro, tornate indietro al Paleolitico o al nomadismo ipotizzato da filosofi primitivisti come John Zerzan, tuttavia non è possibile né auspicabile. Un pensiero ecologico secondo Morton, oggi si da solo a partire da un “essenzialismo weird” e dal riconoscimento dell’irriducibile stranezza dell’esistente, oggi suffragata dall’osservazione scientifica, dagli approdi della fisica quantistica come dagli studi di biosemiotica. Il gioco diventa parola chiave ma non corrisponde a un impulso estetico, liberatorio, o a un edulcorante sensuale per il soggetto, come pensava Schiller, quanto piuttosto a “un fatto organico rispetto al reale”. Per uscire dalla prigione e lasciarsi alle spalle l’agrilogistica occorre imparare a “subscendere” il reale nelle sue parti e ad accettarle per come si manifestano a noi – a cominciare da 10 milioni di specie microrganiche che concorrono a formare quello che chiamiamo “corpo umano” – e quindi come un groviglio inanellato e sporco, non come una superficie liscia e pulita:
“La subscendenza è l’inverso della “trascendenza”, mentre l’”immanenza” è il suo contrario. Diversamente dall’immanenza, la subscendenza evoca il divario ontologico tra ciò che una cosa è e il modo in cui essa appare, o tra una cosa e le sue parti. Il gioco è una subscendenza perché collega me con un mattoncino Lego, un lichene, una rete di attivisti, il microbioma, un ghiacciaio che si scioglie. Siamo meno della somma delle nostre parti: in noi brulicano intere moltitudini. “[5]
Personalità non binaria, marxista, studioso di letteratura romantica e cultore delle digressioni pop a cui non sa resistere, Morton si riconosce nel materialismo della corrente Object Oriented Ontology (OOO), a suo dire la più atta oggi a garantire un accesso non antropocentrico alla realtà, assegnando pari dignità ontologica all’organico e all’inorganico, come del resto ad oggetti reali e a costrutti immaginativi. “Se il mio stile filosofico fosse un film e io il regista, il produttore sarebbe Graham Harman e i produttori esecutivi Immanuel Kant e Martin Heidegger” [6] L’iperoggetto è forse la nozione più nota del pensiero Morton. Un Iperoggetto è un’entità che contraddice la nostra esperienza quando la interseca, perché contraddice la linearità spazio temporale e risulta fuori scala quando proviamo a misurarla sul metro antropico. Di lei, in altre parole, riusciamo a intercettare i singoli fotogrammi ma non distinguiamo il film. E’ un iperoggetto il riscaldamento climatico, come lo sono l’ecosistema della plastica, una pandemia o la specie umana stessa, intesa come attore di magnitudo terrestre e al di là di qualsiasi malinteso universalismo. La nostra incomprensione degli iperoggetti è, secondo Morton, alla base dell’incapacità dell’ecologia politica di fare i conti con l’agentività del non umano e anche dei numerosi equivoci creati da decenni di ambientalismo.
Dietro a questi equivoci c’è il ritrarsi dell’Anima Bella naturista di fronte alla Valle del perturbante e al sentimento di sé pervaso dall’Orrore. In breve l’affezione per la Vita intesa come “sostanza facile da pensare” e mai come brivido caldo, quel tocco dell’altro, in cui, citando Adorno, la soggettività “da segno di sé senza già sussistere”. Ma, soprattutto, ci sarebbe la nozione di Natura, che anche l’Antropocene riafferma e presuppone come Altro, perpetuando il dualismo soggetto / oggetto nel rapporto di dominio che si estende al non umano e che si esprime oggi anche attraverso il conservazionismo naturista, new age, senza glutine, etc. , con esiti e ricadute secondo il filosofo inglese neppure così lontane dal criptofascismo. Mutatis mutandis, del resto non erano proprio Adorno e Horkheimer, che, decenni fa, osservavano che “l’ideale borghese della conformità alla natura non intende la natura amorfa, ma la virtù del giusto mezzo”? [7]
L’ecologia “oscura” di Morton è invece, fondamentalmente, un’ecologia senza Natura, aperta al sentimento del perturbante, che ignora tanto il ricatto quanto il compiacimento del catastrofismo: “Man mano che scendiamo nella Malinconia, più l’oggetto che non è me esercita la sua forza di gravità, più svanisce la differenza tra interesse e fascino, che taluni vorrebbe ancora tenere in vita (..) E’ la melanconia automatizzata di E-Wall a salvare la terra, un sentimento spogliato del suo involucro umano, implacabile eppure soft. E’ il guardiano di E-Wall, non certo Justine di Melancholia, il film di Lars Von Trier. “ [8]
Un altro parlamento è possibile ? E per chi?
Che la nozione di “natura” sia un ostacolo sulla strada dell’ ecologia politica, del resto, non è una novità. Seguendo una linea di pensiero affatto diversa, cioè a partire dall’antropologia e dalla sociologia della scienza, lo aveva già messo in chiaro diversi anni prima un intellettuale stimato da Harman e da Morton, ma, rispetto a questi, poco interessato alle sottigliezze ontologiche. Anche per Bruno Latour, infatti, l’ecologia politica ha avuto esiti deludenti rispetto ai suoi obiettivi dichiarati, senza mai veramente riuscire a liberarsi della “natura” che vorrebbe proteggere, rimanendo prigioniera e vittima di una visione antropocentrica e, in ultima analisi non inclusiva, delle forme di vita non umane. Questo non tanto per la vocazione primitivistica e quaresimale della sua componente storica “radicale”, stigmatizzata spesso da Morton, ma perché semmai l’azione dell’ecologia è rimasta incastrata nelle forme tradizionali della rappresentanza che assegnano, nella vita pubblica, alla scienza e alla politica il duopolio, rispettivamente, della conoscenza (“i fatti”) e del potere sociale (“i valori).
 In Politiche della Natura l’antropologo francese individua a ritroso lo statuto di questo regime, alle fondamenta della civiltà occidentale, direttamente nel mito della caverna di Platone: nella sala oscura – l’inferno del sociale – la folla degli umani si accalca ma può vedere solo le ombre proiettate dalla politica mentre, al di là di queste, il filosofo-scienziato accede liberamente alla realtà. I pochi eletti che hanno facoltà di transitare tra le due assemblee dispongono a questo punto di un potere esclusivo e non sindacabile, che esclude la moltitudine di umani e non umani dalla partecipazione politica reale. A questa “costituzione”, e al suo dettato epistemologico, Latour oppone la visione di un nuovo “parlamento” dove possono approdare sia la discussione scientifica che quella etico-politica. La sua struttura bicamerale promuove il dibattimento e l’approfondimento delle ipotesi, mettendo in circolazione i saperi secondo un modello decisionale democratico e paritetico. Attraverso le scienze (al plurale), in particolare, viene “data la voce” anche al non umano, non più “oggettività muta”, di cui i camici bianchi diventano, in pratica, i portavoce presso l’assemblea degli umani e i loro rappresentanti. Comunque la si valuti è una prospettiva, quella di Latour, con un’ ovvia ricaduta anche sul nostro attuale presente, data l’importanza che la ricerca di laboratorio e la tecnologia vaccinale rivestono in questo momento per l’agibilità umana sul pianeta. Come tale può prestarsi anche a fraintendimenti, dacché non si tratta di relativizzare la scienza, declassandola a costrutto sociale indifferenziato, ma, al contrario, di “complicarla” e di aprirla alla società: “L’irruzione delle controversie scientifiche sulla scena pubblica non dimostra che si sia passati dai fatti stabiliti a finzioni senza fondamento, ma che la distinzione tra l’interno e l’esterno delle discipline scientifiche è alquanto scomparsa”. [9]
In Politiche della Natura l’antropologo francese individua a ritroso lo statuto di questo regime, alle fondamenta della civiltà occidentale, direttamente nel mito della caverna di Platone: nella sala oscura – l’inferno del sociale – la folla degli umani si accalca ma può vedere solo le ombre proiettate dalla politica mentre, al di là di queste, il filosofo-scienziato accede liberamente alla realtà. I pochi eletti che hanno facoltà di transitare tra le due assemblee dispongono a questo punto di un potere esclusivo e non sindacabile, che esclude la moltitudine di umani e non umani dalla partecipazione politica reale. A questa “costituzione”, e al suo dettato epistemologico, Latour oppone la visione di un nuovo “parlamento” dove possono approdare sia la discussione scientifica che quella etico-politica. La sua struttura bicamerale promuove il dibattimento e l’approfondimento delle ipotesi, mettendo in circolazione i saperi secondo un modello decisionale democratico e paritetico. Attraverso le scienze (al plurale), in particolare, viene “data la voce” anche al non umano, non più “oggettività muta”, di cui i camici bianchi diventano, in pratica, i portavoce presso l’assemblea degli umani e i loro rappresentanti. Comunque la si valuti è una prospettiva, quella di Latour, con un’ ovvia ricaduta anche sul nostro attuale presente, data l’importanza che la ricerca di laboratorio e la tecnologia vaccinale rivestono in questo momento per l’agibilità umana sul pianeta. Come tale può prestarsi anche a fraintendimenti, dacché non si tratta di relativizzare la scienza, declassandola a costrutto sociale indifferenziato, ma, al contrario, di “complicarla” e di aprirla alla società: “L’irruzione delle controversie scientifiche sulla scena pubblica non dimostra che si sia passati dai fatti stabiliti a finzioni senza fondamento, ma che la distinzione tra l’interno e l’esterno delle discipline scientifiche è alquanto scomparsa”. [9]
La riflessione di Latour, che non possiamo riassumere in queste righe, offre oggi vari, numerosi punti di contatto, ad esempio, in ambito femminista, con la cosmopolitica teorizzata da Isabelle Stengers o con le alleanze multispecie immaginate da Donna Haraway. Correnti di immaginazione intellettuale e di impegno che intersecano altre correnti che intravvedono nella democratizzazione del sapere scientifico non solo una chance per sospingere e rilanciare oggi l’ecologia politica ma per aprirsi un camminamento verso il nucleo del reattore impazzito che ha trasformato l’idea stessa di futuro in una narratologia distopica. Per andare oltre la narrativa del collasso e immaginare un mondo possibile quel reattore adesso va spento. Gli eventi della pandemica offrono un banco di prova, forse l’ultimo, alla politica per fare rapidamente i conti con il non umano. Non su scala globale ma, questa volta, terrestre.
NOTE
[1] Marco Malvestio, Raccontare la fine del mondo, Nottetempo, 2021, pag. 73,
[2] Amitav Ghosh, La grande cecità. Il cambiamento climatico e l’impensabile, Neri Pozza, 2017, pag. 125
[3] Dipesh Chakrabarty, Clima, storia e capitale. A cura di Matteo De Giuli e Nicolò Porcelluzzi. Nottetempo, 2021
[4] Pag 136. Ibid.
[5] Timothy Morton, Ecologia oscura (Luiss, 2021), pag. 154
[6] Timothy Morton, Noi, esseri ecologici (Laterza, 2016), pag. 4
[7] Max Horkheimer, Theodore W. Adorno, Dialettica dell’Illuminismo, Einaudi, 2010, pag. 39
[8] Timothy Morton, Ecologia oscura (Luiss, 2021), pag. 181
[9] Bruno Latour, Politiche della Natura (Raffaello Cortina, 2000), pag. 70-71



