L’operaio è stato a lungo un soggetto minoritario nell’immaginario sociale dominante e anche in quello letterario. Oggi lo è addirittura di più che nel Novecento, secolo breve in cui una classe operaia organizzata come mai prima d’allora ha cercato in ogni modo di farsi rispettare. Da quando invece le nostre società hanno abbracciato entusiasticamente l’economia post-industriale e della conoscenza, l’identità operaia si è fatta sempre più fragile e frammentata così come le sue rappresentazioni. Ecco allora che si potrebbe definire Joseph Ponthus (1978-2021) uno “scrittore minoritario”, nel senso usato da Monique Wittig, perché Ponthus ha saputo insinuarsi come un “cavallo di Troia” nel territorio della letteratura considerata “alta” portando all’attenzione di un grande pubblico il non detto del mondo operaio contemporaneo. E l’ha fatto senza replicare né gli stereotipi ricorrenti nelle rappresentazioni edulcorate o pietiste firmate da chi il lavoro in fabbrica l’ha visto solo da lontano né i luoghi comuni che, in certi casi, hanno abbondato anche nell’autocelebrazione del lavoro operaio. Ma andiamo con ordine.
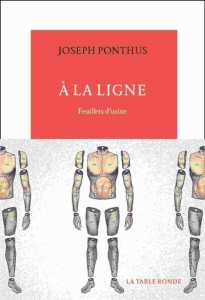 Quando nel gennaio di due anni fa viene pubblicato il suo primo libro, À la ligne. Feuillets d’usine (Éditions La Table Ronde, 2019), chi sia Joseph Ponthus non lo sa praticamente nessuno. Presentato come “romanzo” in quarta di copertina, À la ligne è in realtà una sorta di prosimetro in versi liberi scritto da un autore che viene facile identificare con il suo protagonista, operaio interinale spedito senza alcuna preparazione prima in uno stabilimento bretone in cui si lavorano pesci e crostacei poi in un mattatoio. A leggere attentamente il testo si possono trovare anche le chiavi del nome che campeggia in copertina: se Joseph (Giuseppe) è indicato come il santo patrono del lavoro nel 61° capitolo, nell’ultimo il narratore evoca come suo “ancêtre” (antenato) il poeta Pontus de Tyard (1521-1605), assai meno noto di Ronsard ma tra i fondatori del gruppo della Pléiade e autore di versi più frammentari e variamente dedicati a momenti della vita quotidiana.
Quando nel gennaio di due anni fa viene pubblicato il suo primo libro, À la ligne. Feuillets d’usine (Éditions La Table Ronde, 2019), chi sia Joseph Ponthus non lo sa praticamente nessuno. Presentato come “romanzo” in quarta di copertina, À la ligne è in realtà una sorta di prosimetro in versi liberi scritto da un autore che viene facile identificare con il suo protagonista, operaio interinale spedito senza alcuna preparazione prima in uno stabilimento bretone in cui si lavorano pesci e crostacei poi in un mattatoio. A leggere attentamente il testo si possono trovare anche le chiavi del nome che campeggia in copertina: se Joseph (Giuseppe) è indicato come il santo patrono del lavoro nel 61° capitolo, nell’ultimo il narratore evoca come suo “ancêtre” (antenato) il poeta Pontus de Tyard (1521-1605), assai meno noto di Ronsard ma tra i fondatori del gruppo della Pléiade e autore di versi più frammentari e variamente dedicati a momenti della vita quotidiana.
Scavando nel passato di quest’operaio versificatore si è poi scoperto che l’“educatore di strada” Joseph Ponthus era tra i responsabili del libro collettivo Nous… La Cité (Éd. Zones, 2012), esito di un atelier di scrittura con giovani residenti nella banlieue parigina di Nanterre. E, risalendo ancor più indietro, è emerso che era stato redattore della rivista libertaria “Article 11” firmandosi sia Ponthus sia anche “Ubifaciunt” o “Ubi”, soprannome con cui nel 2011 partecipò alla prima edizione della rassegna partenopea Chi racconta la città promossa dalla redazione di “Napoli Monitor”[1]. Il riferimento alle celebri parole di Publio Cornelio Tacito, “Ubi solitudinem faciunt pacem appellant” (Quando fanno terra bruciata la chiamano pace), il suo attivismo sociale e il fatto che tra i ringraziamenti di À la ligne figurino tanto lo storico del mondo operaio Xavier Vigna quanto Luther Blisset sono chiari indizi di una personalità costruitasi in anni di studio e di lotta, non assimilabile ai numerosi autori “transclasses” (“transfughi di classe”) che in Francia hanno raccontato il proletariato dopo esserne usciti senza rimpianti. Anche perché lui, benché altamente istruito, proletario lo è rimasto davvero, come si racconta nel libro, ritrovandosi sposato e disoccupato in Bretagna dove le agenzie interinali cercano per lo più operai nell’“agroalimentare”. Termine che suona eufemistico per un’industria che smembra, dissangua e inscatola esseri viventi a ritmi vertiginosi.
In definitiva, conta quindi poco che il vero nome dell’esordiente Ponthus fosse Baptiste Cornet da Reims e che già in una delle sue prime interviste[2] dichiarasse di non lavorare più in fabbrica, rimasto senza contratto dopo avere lui stesso consegnato alla direzione del mattatoio una copia di À la ligne. Conta qui ribadire che la scelta dello pseudonimo era politica e poetica e che al momento della pubblicazione nulla garantiva al libro il successo conquistato nel corso del 2019 fino ad assumere le dimensioni di un caso letterario vero e proprio. Oltre ai consensi della critica, ad aumentare la popolarità del libro sono i premi fioccati a sorpresa come quello che i lettori delle biblioteche della città di Parigi assegnano agli esordienti o il Grand Prix RTL/Lire, uno dei più ambiti di Francia, il Régine Deforges, il Jean Amila Meckert, il Coiffard, l’Obiou e l’Eugène Dabit consegnato sin dal 1931 al miglior “roman populiste” dell’anno. Quest’ultimo inscrive À la ligne nella tradizione di una letteratura “proletaria” che oltralpe è riconosciuta e studiata sin dai gloriosi anni Trenta e a cui ci si richiama ancora oggi con orgoglio. Nonostante il primato degli autori proletari francesi c’è peraltro chi, come l’operaio e scrittore Jean-Pierre Levaray, ha reso apertamente omaggio all’ispirazione ricevuta dal romanzo-diario Tuta Blu (Feltrinelli, 1978) del poeta operaio pugliese Tommaso di Ciaula (1941-2021), che fu protagonista della tardiva legittimazione editoriale della letteratura nostrana di fabbrica. Ma bisogna notare che lo scorso gennaio, quando Di Ciaula è scomparso, la notizia è passata inosservata sui media nazionali. In Francia sarebbe forse stato diverso.
Poesia e autobiografia, diario e cronaca: in À la ligne si ritrovano tutti i caratteri peculiari delle opere di chi lavora e scrive nei ritagli di tempo per riflettere sulla propria condizione, con in più una voce del tutto singolare e una forma che scompagina non soltanto i codici dei generi letterari borghesi ma anche alcuni parametri della letteratura proletaria, che l’ibridazione tra generi e forme l’ha invero sempre praticata. A volergli trovare un precedente, vengono in mente i frammenti di prosa e versi di Thierry Metz (1956-1997), pure lui per un periodo impiegato in un macello come Ponthus, che lo cita, e di cui si può consigliare in particolare Le Journal d’un manœuvre (Gallimard, 1990), tradotto col titolo Diario di un manovale dalle Edizioni degli animali e pubblicato meritoriamente con l’originale a fronte nel 2020. Ma ciò che contraddistingue inequivocabilmente i Feuillets d’usine di Ponthus è innanzitutto la messe di citazioni e rimandi intertestuali nascosti ed espliciti, riferimenti poetico-musicali, giochi linguistici e doppi sensi che fioriscono a partire dal titolo interpretabile sia come “a capo” sia come “sulla linea di produzione”: “J’écris comme je travaille / À la chaine / À la ligne” (Scrivo come lavoro / alla catena / sulla linea-andando a capo), si legge nel testo con una polisemia già persa in alcune delle traduzioni che il libro ha ricevuto, come l’olandese e l’inglese intitolate Aan de lopende band (De Arbeiderspers, 2020) e On the Line (Apollo, 2021).
Attendendo con fiducia la versione italiana, anche nella nostra lingua non sarà semplice conservare la ritmica di un’opera totalmente priva di punteggiatura ma non di ritmo perché costruita su di un principio di “armonia imitativa” (in senso lato) con la cadenza dei pensieri in fabbrica del narratore, che si oppone a quella del lavoro. È bene avere chiara questa distinzione: la prosa poetica di Ponthus non mima la ripetitività martellante della catena industriale ma riproduce il modo in cui i pensieri al lavoro si dimenano cercando di sfuggirlo, di meglio sopportare il tempo che manca alla fine del turno. Tale dispositivo salvifico è messo in pratica, da un lato, inventando mantra e nonsense come il memorabile “égoutter du tofu” (sgocciolare il tofu) che accompagnò l’autore per un’intera notte di lavoro alienante e scrivendo a mente quelli che saranno prima dei brevi testi pubblicati su Facebook e poi il libro. Dall’altro, per fare un esempio, con un meccanismo simile a quello raccontato da Aldo Braibanti nella sua Lettera al compagno Gianfranco caduto nella lotta clandestina (1945) quando ricordava che, dopo le torture subite in quanto partigiano dalla famigerata banda Koch-Carità, si ripeteva versi di Baudelaire: “il ritmo mi leniva la carne e mi staccava dai miei persecutori”.
Così fa Ponthus, stremato fisicamente e mentalmente dalla fabbrica, rimasticando non casualmente citazioni di quegli Apollinaire, Aragon o Cendrars che provarono l’esperienza sconvolgente del fronte della grande guerra, la “Grande Boucherie” (grande macelleria) che fa risonanza con la sua al mattatoio. E se, da addetto alla lavorazione del pescato, il sapere che “la première occurrence du mot crevette est chez Rabelais” (la prima occorrenza del termine gamberetto è in Rabelais) sembra di primo acchito del tutto inutile, è invece proprio pensare a Rabelais che gli consente di restare se stesso. Così come rileggere En attendant Godot di Beckett nella lunga fila d’attesa che si crea alle agenzie interinali o immaginarsi di essere un novello D’Artagnan alla vigilia di una nuova missione lavorativa. Aggiungendo poi ai rimandi a René Char (il sottotitolo del libro è un omaggio evidente ai suoi Feuillets d’Hypnos), Ronsard, Jean de la Bruyère, Hugo, Sinclair, Perec e persino Franju e Godard, un’infinità di citazioni tratte da canzoni popolari di grandi autori e vedette del panorama francese: da Trenet, Brel, Brassens, Léo Ferré, Barbara a Johnny Hallyday, Vanessa Paradis e Carla Bruni.
Lo raccontava già il succitato Tommaso Di Ciaula[3], e non sarà per tutti un fatto nuovo, ma in molte fabbriche parlare con i compagni di lavoro è praticamente impossibile e non resta che cantare per resistere e mantenere una qualche forma di sanità mentale. Se ci si riesce:
| L’autre jour à la pause j’entends une ouvrière dire à un de ses collègues | L’altro giorno in pausa sento un’operaia dire a un suo collega |
| “Tu te rends compte aujourd’hui c’est tellement speed que j’ai même pas le temps de chanter” | “Renditi conto oggi è una tale follia che non ho manco il tempo di cantare” |
| Je crois que c’est une des phrases les plus belles les plus vraies et les plus dures qui aient jamais été dites sur la condition ouvrière | Penso sia una delle frasi più belle più vere e più dure mai pronunciate sulla condizione operaia |
| Ces moments où c’est tellement indicible que l’on n’a même pas le temps de chanter | Momenti in cui si va a un ritmo così indicibile da non avere il tempo di cantare |
| Juste voir la chaîne qui avance sans fin l’angoisse qui monte l’inéluctable de la machine et devoir continuer coûte que coûte la production alors que | Solo di vedere la catena che scorre senza fine l’angoscia che cresce l’ineluttabilità della macchina e di continuare a produrre costi quel che costi e comunque |
| Même pas le temps de chanter | Neppure il tempo di cantare |
| Et diable qu’il y a de jours sans[4] | Diamine se ce ne sono di giorni così |
Joseph Ponthus ci ha dunque saputo raccontare, innanzi tutto, che la classe operaia non è per nulla scomparsa neanche nel cuore della vecchia Europa. Tuttavia, la sua coscienza di classe si è frammentata a furia di moltiplicare tipologie di contratti, differenziare orari e mansioni. Nelle fabbriche in cui l’autore è stato chiamato, gli interinali costituivano una percentuale crescente della forza lavoro, senza la possibilità di rifiutare un impiego, fare sciopero, declinare l’offerta di svolgere straordinari, pena il non venire richiamati la settimana successiva. À la ligne ci restituisce così l’affresco preciso di quanto si sia nuovamente ingrossato, e ancor di più dopo la pandemia globale da Covid19, quell’“esercito industriale di riserva” cui il sistema capitalistico ricorre per perpetuare se stesso e massimizzare i propri profitti, come ci ha insegnato Marx.
Malgrado ciò, la fabbrica affrontata da Ponthus con il conforto del canto e della scrittura si rivela essere anche un luogo di comprensione e approfondimento del reale e di sé, una possibilità di conoscenza, come lo è sempre la buona letteratura. Insieme ai teneri accenni a episodi di solidarietà tra compagni di lavoro che emergono qui e là nel testo, il lascito della sua parabola creativa e umana è enorme, e tutt’altro che scontato. Varrà senza dubbio per Ponthus, scomparso per un tumore[5] davvero troppo prematuramente, quel che intonava il suo amato Trenet in L’âme des poètes: “Longtemps, longtemps, longtemps / Après que les poètes ont disparu / Leurs chansons courent encore dans les rues” (Tanto, tanto, tanto tempo / dopo che i poeti sono scomparsi / i loro canti riecheggiano ancora nelle strade).
[1] Cfr. “La fabbrica mangia il tempo, il corpo e la mente”. In ricordo di Joseph Ponthus, in “Napoli Monitor”, 1° marzo 2021, con la traduzione di Andrea Bottalico di un’intervista a Ponthus realizzata da Émilien Bernard per la rivista “CQFD. Ce Qu’il Faut Détruire”, n. 190, settembre 2020.
[2] Ramsès Kefi, Joseph Ponthus: «L’épreuve de l’usine s’est peut-être substituée à celle de l’angoisse», in “Libération”, 19 gennaio 2019.
[3] Tommaso di Ciaula, Tuta Blu. Ire, ricordi e sogni di un operaio del sud, prefazione di Paolo Volponi, Feltrinelli, Milano 1978, p. 63: “Certe volte sul lavoro canticchiamo per tenerci allegri. Non per allegria, ma per rabbia, come dice la famosa favola dell’uccello in gabbia. Altre volte cantiamo a squarciagola, almeno per sovrastare il rumore infernale delle macchine. Si canta di tutto: stornelli piccanti, canzoni strappacore napoletane, Bandiera Rossa, ma quest’ultima, almeno per quanto mi riguarda, con poca convinzione, negli ultimi tempi”.
[4] Joseph Ponthus, À la ligne. Feuillets d’usine, Éditions La Table Ronde, Paris 2019 (Gallimard, Paris 2020), p. 203. Traduzione di chi scrive.
[5] Cfr. per lo meno l’intenso ricordo di Alberto Prunetti, Il tempo perduto di uno scrittore operaio, in “Jacobin”, 25 febbraio 2021. L’ultimo scritto edito di Ponthus è la prefazione alla raccolta di testi di Henri Calet, Je ne sais écrire que ma vie (Presses Universitaires de Lyon, 2021). Stava lavorando a un nuovo romanzo.



