Ho incontrato Azélie Fayolle a Testo (Firenze, 1-2 marzo 2025) dove, assieme a Daniela Brogi, presentava il suo Scrivere femminista. Per un altro canone in letteratura (Nero), tradotto impeccabilmente da Laura Marzi. Nel saggio Fayolle analizza e affronta la questione delle condizioni sociali in cui le donne leggono e a loro volta producono letteratura; e di come uno sguardo femminista possa risultare una strategia in grado di mettere in discussione la distinzione tra stile e dimensione politica dei testi, aprendo a una rappresentazione che restituisca agency a scrittrici e lettrici. Perché nella narrativa e saggistica scritta da donne c’è sempre, afferma risolutamente Fayolle, una risposta più o meno consapevole all’oppressione patriarcale. E quindi occorre cambiare la nostra visione e parlare di letteratura “femminista” e non femminile.
Sul tema in Italia si è pubblicato molto, basti pensare a tutto il lavoro sull’Oltrecanone (a cura di Anna Maria Crispino, Iacobelli editore) portato avanti da vari decenni dalla Società italiana delle letterate (SIL). Numerose opere di saggistica e narrativa nate ai margini hanno messo in discussione il canone patriarcale, introducendo nella letteratura nuove forme di soggettività e autorialità inaspettate. Il margine, da luogo di esclusione, è stato così reinterpretato come spazio di libertà. È questa la lezione di bell hooks che sembra riecheggiare anche ne Lo spazio delle donne (Einaudi, 2022) di Daniela Brogi, un saggio che, attraverso il concetto di “fuoricampo”, indaga le dinamiche di genere responsabili dell’emarginazione delle scrittrici. Con questo libro, Brogi realizza un autentico rovesciamento di prospettiva.
Qui le logiche di genere hanno lavorato con piú violenza, affermando canoni e valori di letterarietà – e di extraletterarietà – organici al contratto sociale patriarcale, perché alla violenza di primo grado – equivalente allo svuotamento e alla svalutazione della possibilità che le donne potessero occupare, da soggetti, uno spazio pubblico (non domestico) – si è aggiunta una violenza di secondo grado, corrispondente alla svalutazione ulteriore della narrativa riguardante gli spazi marginali a quel punto occupati e rappresentati dalle donne. E cosí parlare di spazi domestici, di memorie famigliari, del mondo della madre, dell’autobiografia, di storie d’amore, o del corpo è stata a lungo una scrittura creduta inferiore, se praticata dalle autrici (…).
Il saggio di Fayolle, interessante e provocatorio, ci parla della situazione vista dalla Francia, aggiungendo più di una freccia, tra cui quella intersezionale, all’arco delle elaborazioni femministe. Il saggio è scandito da quattro passaggi: leggere e scrivere nella lingua del patriarcato, il silenzio delle donne, la rabbia delle donne e il tempo delle femministe. Per argomentare la sua tesi Fayolle si serve di testi teorici e narrativi, lungo un periodo di tempo che va da madame De Sevigné a Virginie Despentes. Utilizzando, inoltre, accanto a romanzi mainstream, anche narrativa di genere fantastico, una modalità rara per l’Italia che mi rende il saggio di Fayolle ulteriormente prezioso. Pertanto proprio su questo aspetto ho rivolto a Azélie Fayolle alcune domande.
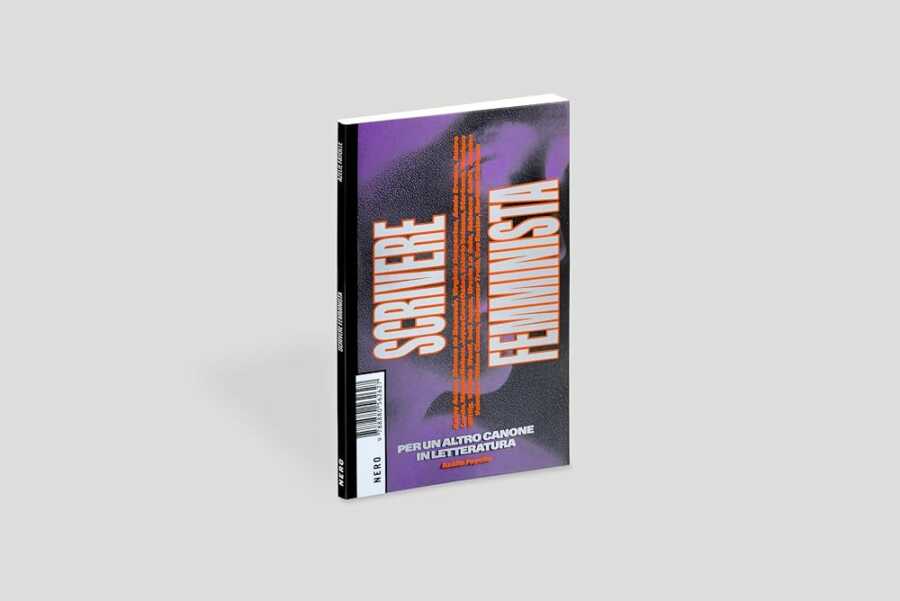
Misserville Salve Azélie, grazie per aver accettato questa intervista. Nel tuo saggio affermi che esiste uno stile femminista che innerva la letteratura. Potresti spiegarci come vengono percepite in Francia le opere letterarie che adottano un punto di vista femminista? Sono mainstream o marginali?
Fayolle Salve Giuliana. In Francia questo è un momento fortunato: le persone, e soprattutto le donne, sono molto interessate a ciò che leggono, in particolare a ciò che è incluso nei programmi scolastici: Françoise Cahen ha lanciato una petizione nel 2017 denunciando come in quei programmi fossero assenti le scrittrici, una petizione che ha avuto un grande impatto. Il movimento è vasto: nascono nuove case editrici, o collane dedicate al femminismo o alla scrittura femminile, librerie o sezioni nelle librerie… il pubblico le segue, e le richiede perfino. Si cercano quindi storie passate o moderne di donne, femministe, queer…
M. “Scrivere femminista. Per un altro canone in letteratura” è un testo complesso anche se scorrevolissimo. A un certo punto, sottolinei come l’estetica sia sempre un’epistemologia e quanto la maggior parte delle produzioni artistiche e letterarie facciano parte del discorso dell’ideologia dominante. Come è possibile allora costruire una contro-epistemologia?
F. Non credo che l’ideologia dominante sia direttamente collegata a un’epistemologia dominante: distinguo, più chiaramente ora che nel saggio, una scienza che produce conoscenza pur non potendo mai raggiungere l’oggettività assoluta (e i cui contributi provengono anche da epistemologie femministe come i lavori di Harding o Hartsock) da altre conoscenze, che non possono ottenere lo stesso grado di affidabilità. La produzione di conoscenza è sempre provvisoria e in movimento: è questo che permette di rovesciare la narrazione dominante di una scienza trionfante che funge da strumento di dominio. Nella tradizione del femminismo troviamo anche numerose proposte di “scienza femminile” (ad esempio nel XIX secolo, con Céline Renooz), o la promozione di conoscenze “femminili”, tradizionali o non scientifiche. Ritengo politicamente importante prestare molta attenzione ai saperi non scientifici, tenendo conto del fatto che le donne sono state a lungo escluse dalla formazione scientifica e comprendendo che anche i saperi svalutati hanno la loro importanza (le narrazioni orali, le canzoni, ad esempio, veicolano conoscenze proto-femministe). Tuttavia, mi rifiuto di considerare quei saperi come scientifici o dello stesso valore della scienza: la razionalità non ha né sesso né genere, come dimostra Michèle Le Dœuff ne Le sexe du savoir. Oggi abbiamo bisogno delle garanzie che offre la scienza, sotto attacco da varie frange fasciste.
M. Mi piace molto il modo in cui integri la narrativa fantastica nel tuo pensiero sulla letteratura e la scrittura femminista. Il fantastico gioca, a parer mio, un ruolo essenziale nel dibattito sul canone letterario. Si tratta di una posizione condivisa in Francia? Pongo questa domanda perché in Italia facciamo ancora fatica a considerare la narrativa fantastica in questo modo, sia in ambito accademico che nella comunicazione pubblica ed editoriale. Come se la narrativa fantastica fosse figlia di una divinità minore.
F. Grazie! Penso che la situazione cambi parecchio a seconda dei sottogeneri del fantastico: quello del XIX secolo, di Poe, è diventato canonico; possiamo trovare i suoi libri nei programmi scolastici, probabilmente grazie alla traduzione di Baudelaire. Altri generi del fantastico, soprattutto quelli contemporanei, sono meno apprezzati. Quando li troviamo studiati all’università, vediamo che sono considerati più come sottogeneri che come facenti parte del corpus maggioritario della storia letteraria. Per il mondo dell’editoria è la stessa cosa: la segmentazione del mercato librario si divide in letteratura “di genere” (letteraria) e letteratura generale o blanche (come la collezione Blanche di Gallimard), anche per le librerie che possono specializzarsi. Alcuni autori passano da un genere all’altro, cambiando editore, e questo influisce sulla loro ricezione e sugli studi accademici. A volte penso che questa situazione abbia anche i suoi vantaggi: ci permette di orientarci, ci dà il senso di una comunità. Possiamo anche osservare un’istituzionalizzazione in corso, che riguarda tutti i corpus minoritari: la funzione predittiva della fantascienza può essere valorizzata, nel finanziamento di progetti o tramite Red Team Defense che vede autori e sceneggiatori di fantascienza lavorare con lo stato maggiore dell’esercito – ma questa è forse un’istituzionalizzazione di cui preferiremmo fare a meno.
M. Come è nata la tua passione per la narrativa fantastica? E quali sono i tuoi autori preferiti, donne o uomini?
F. Penso che le cose siano avvenute un po’ per caso e un po’ attraverso diversi canali. Da bambina ero rimasta affascinata dalla serie Ants di Bernard Werber, così presi alcuni libri simili nella biblioteca comunale e scoprii Stephen King, che ho adorato ma che mi spaventava molto. Nello stesso periodo, mio padre iniziò a farmi leggere Io robot di Isaac Asimov (mi piaceva tantissimo) e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, ma non sono mai riuscita ad appassionarmi al fantasy, nemmeno al cinema: non fa proprio per me. La scuola mi ha portato in altre direzioni e ho voluto letture “da grandi”, “serie”; così, fino a qualche anno, fa mi ero dimenticata della narrativa fantastica. Non ne so molto, ma ora la leggo abbastanza spesso. Mi piace molto Antoine Volodine o un romanzo come Herland di Charlotte Perkins Gilman. Sto leggendo Mariana Enriquez il più velocemente possibile! Ora cerco in maniera sistematica e specifica testi femministi, fantastici e anche di altri generi.
M. Tu racconti come la fiaba, storicamente, evidenzi l’asimmetria di potere tra i sessi. Cosa pensi della reinterpretazione delle fiabe di Angela Carter?
F. Purtroppo non l’ho mai letta! È nella mia lista delle cose da fare. In genere sono interessata alle riscritture, anche se credo di essermi persa i racconti di Madame Murat, ripubblicati in Francia qualche mese fa. E a proposito di riscritture, sono stata molto coinvolta, anche solo a pensarci, da Lavinia di Ursula Le Guin, uno dei miei romanzi preferiti.
M. Secondo te, in che modo la narrativa fantastica può contribuire a identificare e costruire “utopie in divenire”, alimentando così una prospettiva femminista che tu vedi legata e facilitata da quello che definisci “tender gaze”? Potresti citare alcune opere che hanno svolto questo ruolo in Francia?
F. Mi è piaciuto molto un romanzo che non è stato ripubblicato in Francia, Memorie di un’astronauta, di Naomi M. Mitchinson. Il romanzo racconta la storia della vita, e in particolare della ricerca, di questa scienziata spaziale, specializzata nelle comunicazioni tra specie, comprese quelle tra animali. Era un romanzo molto strano, che affrontava molto da vicino anche la questione della maternità di altre specie: in tutti i casi, la comunicazione passava attraverso un’empatia fortissima, che mi ha completamente travolto, e che mi sembra un buon punto di partenza per pensare e sognare altri mondi; come Herland immagina un mondo in continua evoluzione. In Francia, Nathalie Sejan ha introdotto il concetto di “protopia”, per designare le micro-utopie concrete che permettono di immaginare, con uno sforzo collettivo, grandi cambiamenti nel giro di poche generazioni. Il “tender gaze“, per me, si colloca nella trasmissione orizzontale e intergenerazionale, persino intersecolare; lo intendo, ben al di là della sessualità, come una presa in conto di ciò che collega e permette le relazioni. Noi creiamo il passato come il passato crea noi: siamo i sogni futuri di persone che non esistono più se non attraverso le loro tracce e attraverso noi, e abbiamo un compito per il futuro, immenso! È tra le femministe, in particolare tra le saint-simoniane, un gruppo radicale, socialista e cristiano degli anni Trenta dell’Ottocento, che studio per le mie ricerche, che trovo questi frammenti di utopia, con l’idea che le donne del futuro sapranno ciò che noi non sappiamo.
M. Cosa pensi dell’uso che alcuni autrici del fantastico latino-americano stanno facendo oggi, in particolare, della narrativa horror, affrontando il tema della violenza di genere?
F. Non conosco molto bene la letteratura latino-americana. Di solito aspetto l’estate per leggere in tranquillità certi romanzi, o i racconti come quelli di Carmen Maria Machado. Credo di aver già menzionato Mariana Enriquez, i cui racconti ho adorato! Sono rimasta molto colpita, leggendo Le cose che abbiamo perso nel fuoco, sempre di Enriquez. La semplicità del suo stile, apparentemente molto ordinario, e delle sue descrizioni, mentre rappresenta, in tutta la sua brutalità, l’orrore patriarcale; mettendo in scena, più in generale, una vita moderna, capitalista, e al tempo stesso l’abiezione coloniale; una vita che malgrado ciò si vive comunque. Non capisco come si possano leggere queste cose e non volere poi bruciare tutto!
M. La narrazione fantastica può essere uno strumento potente per interrogarsi sulla condizione delle donne e di altri soggetti LGBTQ+ emarginati nel mondo reale. Secondo te, qual è il rapporto tra realtà e fiction fantastica?
F. La letteratura immaginaria è molto preziosa per testare altre possibilità, in particolare per le storie sulle minoranze (che in realtà non sono più minoranze). Non so se sia meglio avere testi molto aderenti alla realtà, alla vita di tutti i giorni, ma che ci permettano di vederla vacillare, oppure delle fughe complete: immagino che dipenda dalle persone e dai momenti. Inizialmente sono rimasta sorpresa nello scoprire che, negli Stati Uniti, Monique Wittig è considerata più una scrittrice di fantascienza, probabilmente sullo stesso filone di Joanna Russ; penso che in ogni emancipazione si nascondono frammenti di altrove e di utopia che denunciano e propongono altri mondi. Mi affascinano queste ipotesi che troviamo nei testi teorici, a volte molto seri, e che sembrano restare sospese nel limbo: credo che l’utopia sia davvero lì, nelle nostre vite, ma che non sempre la vediamo.
M. Infine, quale opera fantastica stai leggendo al momento?
F. Surrogata universale. Rovesciamo la famiglia di Sophie Lewis! e per essere meno provocatoria, vorrei leggere presto l’ultimo testo tradotto in francese di Mariana Enriquez, La petite soeur: Un portrait de Silvina Ocampo, e anche Seule di Audrey Clees. Subito dopo dovrei leggere, un po’ per lavoro e molto per me, i romanzi della rivoluzionaria del XIX secolo Louise Michel: non vedo l’ora di scoprirli. Su un altro registro, ho in programma di approfondire l’opera di Ketty Steward, scrittrice francese e anche teorica della fantascienza: mi è piaciuto molto leggere il suo Foodistan e conto di immergermi nel suo L’évangile selon Myriam! Sono anche molto impaziente di iniziare Harde di Mardi Forestier. Ma sto accumulando un po’ troppi libri a casa: è più l’impazienza che il tempo a disposizione. E prenderò nota di leggere Angela Carter.
M. Grazie Azélie. Per il tuo saggio appassionante e anche per gli ulteriori suggerimenti di lettura.



