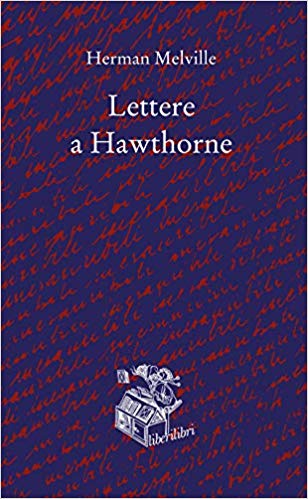Nathaniel Hawthorne e Herman Melville si conobbero il 5 agosto del 1850, durante un’escursione sulla Monument Mountain, fra i colli del Berkshire, nel Massachusetts nordorientale. Hawthorne, già affermato autore di racconti, aveva quarantasei anni, Melville di anni ne aveva trentuno, e all’attivo già cinque romanzi. È il classico colpo di fulmine tra due anime elette, l’inizio di un’amicizia non lunga ma di bruciante intensità, che avrebbe segnato entrambi nel profondo.
Tra i frutti di tale incontro vi è un carteggio di straordinario interesse, seppur incompleto, poiché le lettere di Hawthorne a Melville andarono perdute. L’epistolario è stato di recente pubblicato dalla casa editrice Liberilibri, una seconda edizione che segue di quindici anni la prima, provvista di testo a fronte e curata dallo studioso di letteratura americana Giuseppe Nori, che ha raffinato il suo già pregevole lavoro corredandolo di una lucida prefazione, aggiornando e ampliando i riferimenti bibliografici relativi alle opere di Melville e agli studi critici nel nostro Paese. Nori ha anche tradotto le lettere (due delle quali inedite in italiano), chiarendone ogni dettaglio con un ricco apparato di note che forniscono al lettore le coordinate biografiche, letterarie e storiche in cui l’epistolario ebbe luogo.
La prima missiva di Melville reca la data del 29 gennaio 1851, l’ultima si colloca fra il 3 e il 13 dicembre 1852: siamo negli anni più intensi dell’attività artistica dei due grandi scrittori, e nel pieno del cosiddetto Rinascimento americano, in cui apparvero capolavori come La lettera scarlatta, Moby Dick o la balena, e opere notevoli quali Pierre o delle ambiguità, La casa dei sette abbaini, Il romanzo di Valgioiosa, solo per fermarci ai nostri due autori. Anche di questi romanzi si parla nelle lettere (qui compare la celebre frase riferita al Moby Dick “Ho scritto un libro malvagio, e mi sento immacolato come l’agnello”). Sono dunque documenti preziosissimi, “esercizi spontanei di immedesimazione psicologica in cui Melville usa l’amico come specchio per cercare e definire la propria identità letteraria”, testimonianza della sua evoluzione intellettuale, come nota Nori nella prefazione.
 Ma l’epistolario consente anche di vedere questi uomini alle prese con le quotidiane incombenze, di ricostruire alcuni momenti suggestivi dei loro incontri. Immaginiamo i due giganti delle lettere americane sprofondati in poltrona, davanti a un bicchiere di Porto o d’acquavite, a conversare sino a notte alta del cosmo e dei suoi inarrivabili misteri, impegnati tra un sigaro e l’altro in “magniloquenti discorsi ontologici”, tesi ad afferrare tutto quello “che si trova oltre la conoscenza umana”, come annotò Hawthorne nei suoi diari. Ecco Melville, i mobili occhi acuti che scavano nell’animo dell’amico, l’impetuoso gesticolare, scagliare le sue confessioni a cuore aperto come “onde tumultuose di pensiero contro i grandi silenzi geniali e ricettivi di Hawthorne” (mirabile notazione della moglie di questi, Sophia Peabody); e lo scrittore di Salem che argina “la schiuma e la furia” del più giovane compagno, con la grazia innata, il dire pacato, con “un sorriso”, riportandolo così a una “calma placida e fluttuante”, per citare ancora l’acutissima Sophia. O ancora, intravediamo come in un sogno vaporoso la casa di campagna dei Melville, a Pittsfield, immersa nel verde sino alle grondaie, circondata da antichi boschi e laghetti indiani, la “bella veranda” da cui si scorge in lontananza l’amato monte Graylock, dove Herman, seduto davanti alle sudate carte, si gode “la visione calma delle cose”, prima di lanciarsi nella caccia selvaggia della sua metafisica Balena.
Ma l’epistolario consente anche di vedere questi uomini alle prese con le quotidiane incombenze, di ricostruire alcuni momenti suggestivi dei loro incontri. Immaginiamo i due giganti delle lettere americane sprofondati in poltrona, davanti a un bicchiere di Porto o d’acquavite, a conversare sino a notte alta del cosmo e dei suoi inarrivabili misteri, impegnati tra un sigaro e l’altro in “magniloquenti discorsi ontologici”, tesi ad afferrare tutto quello “che si trova oltre la conoscenza umana”, come annotò Hawthorne nei suoi diari. Ecco Melville, i mobili occhi acuti che scavano nell’animo dell’amico, l’impetuoso gesticolare, scagliare le sue confessioni a cuore aperto come “onde tumultuose di pensiero contro i grandi silenzi geniali e ricettivi di Hawthorne” (mirabile notazione della moglie di questi, Sophia Peabody); e lo scrittore di Salem che argina “la schiuma e la furia” del più giovane compagno, con la grazia innata, il dire pacato, con “un sorriso”, riportandolo così a una “calma placida e fluttuante”, per citare ancora l’acutissima Sophia. O ancora, intravediamo come in un sogno vaporoso la casa di campagna dei Melville, a Pittsfield, immersa nel verde sino alle grondaie, circondata da antichi boschi e laghetti indiani, la “bella veranda” da cui si scorge in lontananza l’amato monte Graylock, dove Herman, seduto davanti alle sudate carte, si gode “la visione calma delle cose”, prima di lanciarsi nella caccia selvaggia della sua metafisica Balena.
Personalmente, l’emozione più intensa l’abbiamo provata con le ultime quattro lettere (agosto-dicembre 1852), in cui affiora il primo stallo creativo dello scrittore newyorkese, dopo il lungo periodo di fervore letterario che aveva prodotto sette romanzi in sette anni. Sono quelle passate alla storia come le “lettere di Agatha”, dove Melville, infiammato dal potenziale letterario della vicenda di una donna reietta (Agatha, appunto, una storia di abbandono e bigamia), appresa da un avvocato e per cui prova “uno spontaneo interesse”, ne raccoglie il materiale e ne informa l’amico, con una prima lunga missiva la cui scrittura erompe incandescente come lava da un vulcano, una sorta di flusso di coscienza dove, ad attestare l’urgenza del dire e l’emozione incontrollata, compaiono persino errori ortografici. Con essa Melville incita l’amico a farne un racconto, convinto che quella storia, per eccellenza materia hawthortniana, gli appartenga “di diritto”. Questa e quelle che seguono sono testimonianze invero preziose: “Hai uno scheletro di realtà vera attorno a cui costruire con pienezza e venatura di dettagli e bellezza”, “con la tua grande maestria”, una “storia di notevole interesse” gli scrive, infarcendo l’accorato appello con descrizioni di abbozzi d’un racconto: è come vedere “in diretta” l’immaginazione di Melville, all’opera nel mutare una vicenda di vita nell’esperienza estetica della realizzazione artistica. Filtrandola con la propria inventiva, lo scrittore delinea scene, suggerisce spunti narrativi, linee di sviluppo, indicandone i risvolti simbolici, i significati reconditi: par quasi il tentativo di una scrittura a quattro mani. Per il lettore è un’esperienza esaltante, come entrare nel laboratorio della scrittura melvilliana, udire una voce concitata, pervasa da un irrefrenabile furore creativo, che illustra la creazione artistica nel suo farsi.
Hawthorne, però, impegnato nella stesura della biografia del futuro presidente Franklin Pierce, suo compagno di studi, indugia, esprime “incertezza”, infine desiste, incoraggiando l’amico a scrivere lui stesso quel racconto. Nell’ultima, concisa lettera (dicembre 1852), Melville chiede che gli sia restituito il materiale che aveva con tanta speranza inviato all’amico, manifestando l’intento di porsi a quel cimento: “Mi sforzerò di rendere giustizia ad una storia così interessante della realtà”.
 Smarrita nell’andirivieni dell’“incertezza” e del rifiuto, la potenziale storia di Agatha non vedrà mai la luce. Il doloroso e impreveduto scacco pare sancire simbolicamente il destino di abbandono di quella donna, attesta la fine di un carteggio memorabile e, con il tempo, d’un’amicizia che aveva vissuto una stagione intensissima. Melville entrò in una profonda crisi, personale e letteraria, e da quel momento la sua arte prenderà pieghe ben più critiche e corrosive verso il mondo, il destino dell’essere umano, le problematiche irresolubili della storia, concentrandosi su figure di vinti, umili e derelitti, emarginate e marginali, vittime della potenza repressiva d’un potere spietato, nelle quali non è peregrino ravvisare i riflessi della vicenda di Agatha.
Smarrita nell’andirivieni dell’“incertezza” e del rifiuto, la potenziale storia di Agatha non vedrà mai la luce. Il doloroso e impreveduto scacco pare sancire simbolicamente il destino di abbandono di quella donna, attesta la fine di un carteggio memorabile e, con il tempo, d’un’amicizia che aveva vissuto una stagione intensissima. Melville entrò in una profonda crisi, personale e letteraria, e da quel momento la sua arte prenderà pieghe ben più critiche e corrosive verso il mondo, il destino dell’essere umano, le problematiche irresolubili della storia, concentrandosi su figure di vinti, umili e derelitti, emarginate e marginali, vittime della potenza repressiva d’un potere spietato, nelle quali non è peregrino ravvisare i riflessi della vicenda di Agatha.
Il libro si chiude con un’interessante appendice, in cui sono riportati passi dal Diario 1856-57 di Melville relativi alla sua permanenza a Liverpool, dove rivide l’amico un’ultima volta, brani dei Taccuini inglesi di Hawthorne relativi allo stesso incontro, che risulta così incrociato dai rispettivi punti di vista. Non ci si può non emozionare davanti alla descrizione che Hawthorne tratteggia del suo vecchio compagno, dopo anni di lontananza, e la conclusione cui giunge: “Possiede una natura assai elevata e nobile, e più degna dell’immortalità della maggior parte di noi”. Infine, vi sono i ricordi del figlio di Hawthorne, Julian, che andò a trovare Melville nel 1883, alla ricerca di notizie biografiche sul padre. Julian ci presenta un uomo invecchiato, rabbuiato, disincantato e annichilito dalla vita (“consumato come una vecchia grattugia”, aveva scritto Melville con un “presentimento” al caro Hawthorne), che non parlava volentieri di quel passato che pure per lui aveva rappresentato un momento di straordinaria intensità esistenziale. In quell’occasione apprese che Melville aveva distrutto le lettere del suo amico, al quale aveva dedicato la sua opera immortale, il Moby Dick, con queste parole: “In segno della mia ammirazione per il suo genio, questo libro è dedicato a Nathaniel Hawthorne”.