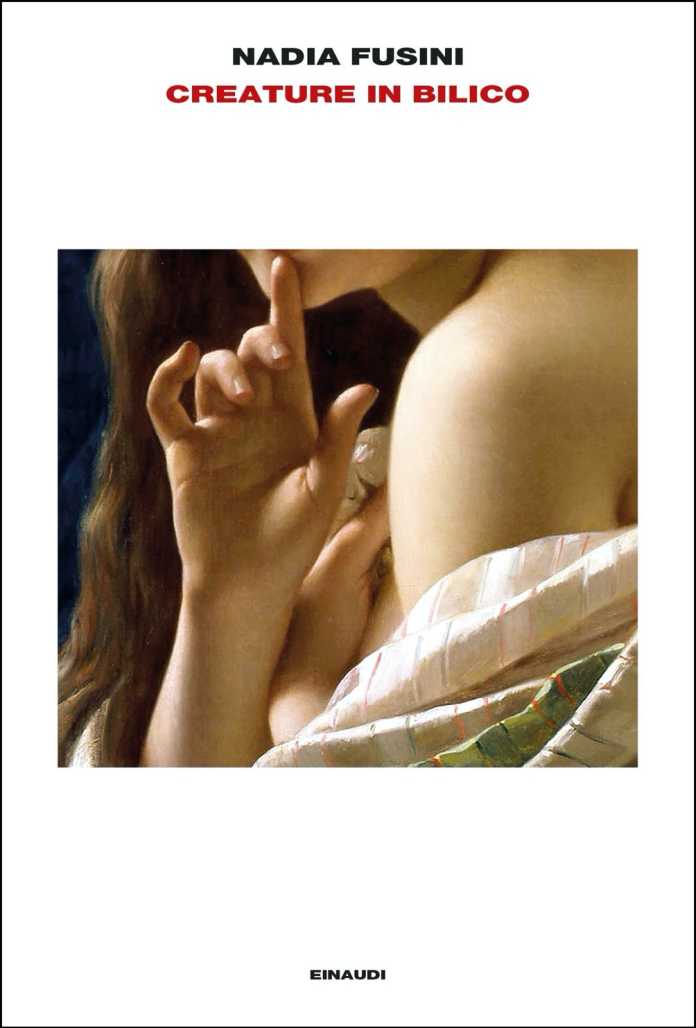Dalla saggistica alla narrativa, Nadia Fusini indaga da sempre la presenza delle donne in letteratura: scrittrici del calibro di Virginia Woolf e Katherine Mansfield, per citare qualche esempio, o ancora le eroine immortali dell’opera shakespeariana. Figure di grande modernità, un passo avanti rispetto alla loro epoca, e insieme portatrici di paure e desideri senza tempo. Come quelle riunite in Creature in bilico, la raccolta di racconti appena uscita per Einaudi, in cui si intrecciano le suggestioni di mito, epica e tradizione cristiana.
Undici storie, undici ritratti squisiti che prendono vita dalla prosa sontuosa di Fusini, lirica e intima. Si articolano in una lingua a tratti sostenuta, a tratti più distesa; sviscerano le complessità del femminile in dialoghi di ampio respiro, confessioni quasi sussurrate, osservazioni da lontano. Tanti sono gli elementi ricorrenti da uno all’altro, come il ricco repertorio di immagini legate all’acqua, ma a fungere da filo conduttore è il pellegrinaggio in quella zona franca tra l’abisso del caos e la luce della consapevolezza – lì dove camminano le protagoniste. Sono anime viandanti, ai margini, risulta chiaro fin dall’incipit del primo testo. Non rispettano convenzioni o la morale comune, perciò vengono considerate pazze o semplicemente ignorate. Si perdono spesso perché sanno che lo smarrimento è insito nel nostro destino: non c’è ordine o possesso fatto per durare, esiste solo una disforia multiforme, capace di manifestarsi nelle vestigia infernali di una città come Roma fino a inghiottire per intero l’umanità, in viaggio verso la morte-megera. “Mi metterò a camminare, mi aggiungerò all’esercito dei viandanti”, decide Ada dopo aver assistito a uno dei peggiori crimini concepibili, “vivrò per strada, tanto non c’è al mondo un posto che sia davvero mio”.
 Moderne Tiresia, queste donne oscillano tra oblio e conoscenza, racchiudono in sé il maschile e il femminile. Coltivano l’incertezza in un eterno presente, eppure si abbandonano alla disfatta perché non rimane altro. Alcune tentano di lasciare un’impronta nelle parole, nei corpi, negli sguardi – l’unica resistenza possibile, l’unica ancora dotata di significato. Questo lo avverte Agata, a cui è dedicata la vicenda al centro del libro, forse il suo culmine. Conserva dentro di sé l’amore proibito per il fratello, un sentimento così profondo da sopportare le assenze protratte di lui, i suoi modi distaccati. Giacomo sceglie un vagabondaggio costante, che si rivela inutile perché è solo un tentativo di fuga dalla sua natura; nell’apparente immobilità di Agata si annida invece il coraggio di guidare entrambi in una dimensione inedita, di rottura, dove si dissolvono le norme di genere e coesistono le estremità. Uno spazio dal sapore pericoloso ed esaltante, tanto da suscitare in chi legge la stessa ammirazione provata dall’uomo in contemplazione del vagare indomito di Dora: “Mi viene da pensare che andare alla deriva sia una forma di libertà”.
Moderne Tiresia, queste donne oscillano tra oblio e conoscenza, racchiudono in sé il maschile e il femminile. Coltivano l’incertezza in un eterno presente, eppure si abbandonano alla disfatta perché non rimane altro. Alcune tentano di lasciare un’impronta nelle parole, nei corpi, negli sguardi – l’unica resistenza possibile, l’unica ancora dotata di significato. Questo lo avverte Agata, a cui è dedicata la vicenda al centro del libro, forse il suo culmine. Conserva dentro di sé l’amore proibito per il fratello, un sentimento così profondo da sopportare le assenze protratte di lui, i suoi modi distaccati. Giacomo sceglie un vagabondaggio costante, che si rivela inutile perché è solo un tentativo di fuga dalla sua natura; nell’apparente immobilità di Agata si annida invece il coraggio di guidare entrambi in una dimensione inedita, di rottura, dove si dissolvono le norme di genere e coesistono le estremità. Uno spazio dal sapore pericoloso ed esaltante, tanto da suscitare in chi legge la stessa ammirazione provata dall’uomo in contemplazione del vagare indomito di Dora: “Mi viene da pensare che andare alla deriva sia una forma di libertà”.