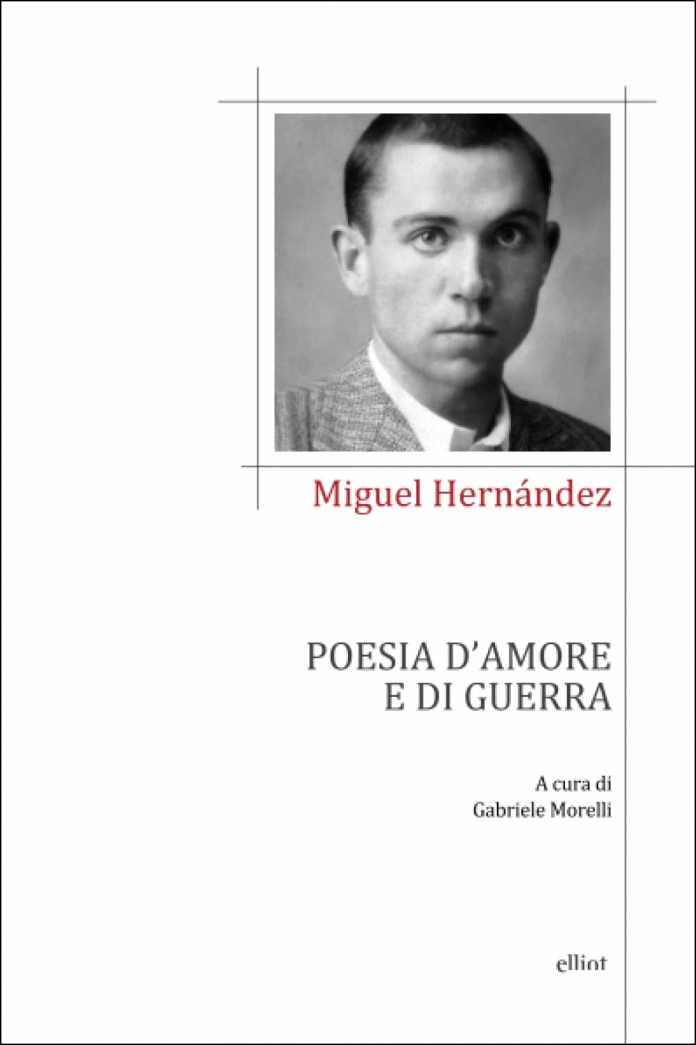A ottanta anni dalla morte di Miguel Hernández (1910-1942), il primo e forse più completo tributo dell’editoria italiana passa ora dalle mani di Gabriele Morelli, che è, del resto, un punto di riferimento inamovibile per gli studi italiani di iberistica riferiti al ventesimo secolo – con una particolare attenzione, poi, a quella Generazione del ’27 che Hernández effettivamente frequenta e convoca nei suoi testi, pur non appartenendovi del tutto e venendone talora respinto, in vita e, dalla critica, post mortem.
È stato, infatti, un autorevole poeta e critico spagnolo come Dámaso Alonso a giudicare Hernández un “geniale epigono” della generazione del ’27, e a configurarne così un ruolo marginale tanto rispetto a García Lorca, a Cernuda e a Alberti quanto rispetto alla Generazione del ’36 in cui Hernández è stato convenzionalmente incluso. È dunque alla controluce di questo verdetto che si deve leggere l’affermazione – del tutto appropriata, per quanto intimamente paradossale – di Luis García Montero, attuale direttore dell’Instituto Cervantes, che, nella nota introduttiva al presente libro, afferma che “l’anno più felice della vita di Miguel Hernández è stato il 1937”. In piena guerra civile, infatti, Hernández “si sposò, ebbe un figlio e, soprattutto, ebbe successo come poeta, il poeta della guerra, il poeta proletario”, aderendo, infine, il più possibile a quella iconografia che l’antologia pubblicata da Elliot riporta come titolo: Poesia d’amore e di guerra.
Sono in effetti questi i due fari della sua produzione, in particolar modo in quel Cancionero y romancero de ausencias, di pubblicazione postuma, che rivaleggia per importanza, entro la sua opera, con il più famoso El rayo que no cesa (1937). Fari che illuminano anche il percorso autoriale di Pablo Neruda – altro gigante della poesia in lingua spagnola ampiamente studiato e tradotto da Morelli – rendendolo, insieme a Vicente Aleixandre, un prezioso compagno di viaggio.
Compagni che si moltiplicarono, poi, nella guerra civile, ma che restarono pochi nella sua specifica traiettoria intellettuale, letteraria e culturale; quest’ultima, del resto, lo portò da un’eterodossa formazione neocattolica – sulla scia di José Bergamín e, soprattutto, di un “compagno dell’anima” (come si legge nella stupenda Elegia, da El rayo que no cesa) come Ramón Sijé, nella nativa Orihuela – fino alla militanza repubblicana durante la guerra civile, confermando sempre la grande passione e la grande intransigenza che spesso segnano i percorsi che alternano cristianesimo e marxismo.
A proposito di tale peculiarità, García Montero osserva correttamente che la presenza di Hernández, pure accettata nella sua mitografia, “è stata poco importante nelle ultime generazioni di poeti spagnoli”. Vi è certamente un’eccezione, continua García Montero, eccezione peraltro molto vicina alla storia di quest’ultimo, in quanto promotore prima del manifesto machadiano de La otra sentimentalidad (L’altra sentimentalità) e poi della cosiddetta poesía de la experiencia (poesia dell’esperienza): “uno dei migliori libri della nostra generazione, Paseo de los tristes, di Javier Egea. Negli anni Ottanta, Javier unì il Cancionero di Miguel Hernández con Le ceneri di Gramsci di Pasolini per cercare di capire ciò che accadeva in Spagna, ciò che a noi accadeva”.
Oltre al moto in parte di appropriazione e in parte di riconoscimento dell’importanza di un autore come Egea, che non è stato sempre del tutto allineato con le scelte estetiche di García Montero, resta di indubbia suggestione questo accostamento a Pasolini, rispetto al quale Hernández presenta sicuramente più differenze che analogie, ma che, per quanto riguarda la commistione di poesia e politica, presenta più o meno la medesima sorte, nella tradizione poetica successiva. Molto pasolinismo, cioè, nel dibattito poetico e letterario italiano, e al tempo stesso assai scarsa la filiazione letteraria direttamente legata alla produzione poetica dell’autore, una sorta di unicum giudicato sacro, o comunque inarrivabile e irripetibile.
Tra le molte differenze che sussistono tra Pasolini e Hernández, una appare molto potente, ancora oggi commovente. Diversamente da Pasolini e dalla sua continua competizione con gli altri autori e intellettuali della sua epoca, infatti, l’appello di Hernández è invece alla condivisione, come nella magistrale Llamo a los poetas (“Chiamo i poeti”): “Poiché sono di questa famiglia” sembra quasi gridare Hernández “siamo il sale della terra. / Così sensibili al clima come lo stesso sale, / una folata d’autunno ci lascia moribondi / seguendo quelli che sono sepolti”.
L’agonia di Hernández in carcere sarà, in realtà, molto diversa da questo ritratto esile e autoironico (si legga, ad esempio, Nanas de la cebolla, “Ninnananna della cipolla”, tenendo a mente la biografia dell’autore, e gli echi nerudiani lasceranno spazio a un racconto crudo e senza della repressione e del carcere: “Non sapere ciò che cambia / e ciò che accade”, la chiusa disperata), sigillando una vita molto breve, interamente dedicata, come appunto si diceva, all’amore e alla guerra. E anche alla musica, che rende i testi di Hernández quasi sempre cantabili, tanto in originale quanto, spesso, nell’abile traduzione di Morelli: un attributo, questo, che è proprio della poesia “del popolo”, il cui vento soffia in tutta l’opera di Hernández e non solo nel titolo di una sua raccolta del 1937, Viento del pueblo.
Un vento che altri non hanno sentito né sentiranno mai e che invece lui porta con sé dalla tempesta di El rayo que no cesa (“Cesserà mai questa folgore che abita / il mio cuore di fiere esasperate / e di fucine irate e fonderie / dove il metallo più fresco è marcito?”) fino all’ultima poesia raccolta in questa antologia dalla selezione chiara e probabilmente inimitabile. Come per effetto di un colpo di vento, “Eterna ombra” si chiude con l’apertura di uno spiraglio, nella notte della reclusione e dell’abiezione imposta dall’esercito franchista, poi vincitore, che a ottant’anni di distanza ancora fa passare un filo di luce: “Sono un’aperta finestra che ascolta, / dove vedo tenebrosa la vita. / Ma c’è un raggio di sole nella lotta / che lascia per sempre l’ombra sconfitta”.