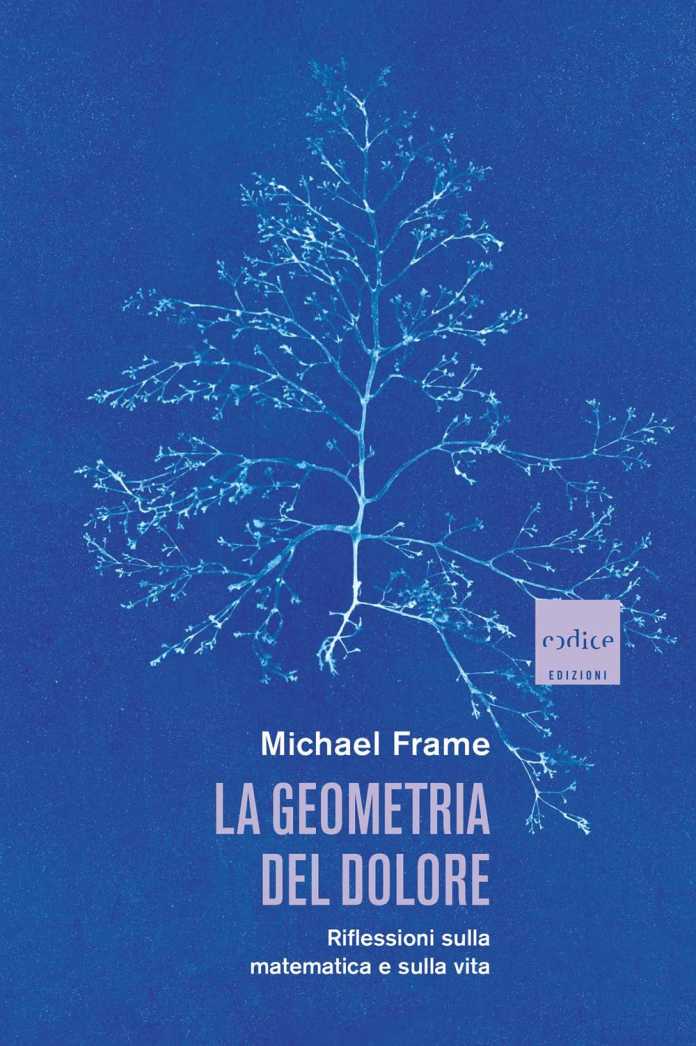Cosa c’entra la matematica con l’esperienza umana del dolore? A chi verrebbe in mente di rileggere le pagine di Godel, Escher, Bach in un momento di estrema sofferenza, in seguito alla perdita irreversibile di una persona cara? Probabilmente a un matematico. Michael Frame, per venti anni collega e amico di Benoit Mandelbrot, oggi professore in pensione a Yale dopo una vita dedicata allo studio della geometria frattale, sviluppa in questo agile volumetto l’idea che l’esperienza matematica possa aiutarci a relativizzare e a gestire il dolore, se non a evitarlo, impedendo di esserne completamente sopraffatti.
L’esperienza del dolore – non della tristezza o della melanconia – squarciando il velo trascendente della nostra percezione quotidiana, rivela infatti (come nient’altro) ciò di cui siamo fatti e di cui sono intessute le nostre vite. Secondo Frame ha in comune più di quello che sembra con un’esperienza apparentemente opposta come l’euforia per l’improvvisa “illuminazione” matematica o la piena comprensione di un difficile teorema. Entrambe sono infatti irreversibili, entrambe ci disarticolano e ci strappano dalla nostra comfort zone. L’autore le sperimenta entrambe da piccolo, in seguito a una grave perdita familiare dovuta a malattia, in una strana epifania che lo porterà a intraprendere la carriera del matematico invece che – come suggerirebbe un plot da supermercato – giurare a sé stesso di diventare un chirurgo o un biologo per salvare vite umane.
A partire dall’assunto che “la geometria è dappertutto” l’autore estende il parallelismo tra sviluppo geometrico e narratologico. Con questo non si intendono qui solo le storie che si srotolano all’infinito, attraverso i sentieri intrecciati di Borges o di Calvino, ma le storie che raccontiamo ogni giorno a noi stessi per “vivere”. Storie che la nostra vigile consapevolezza fa girare attorno alle ben poche variabili, su cui normalmente concentriamo l’attenzione nella nostra quotidianità diurna: le cose da fare, gli appuntamenti, gli ostacoli che abbiamo di fronte, quello che ci sta dicendo il nostro interlocutore.
Il dolore, osserva Frame, interrompe il flusso delle nostre emozioni, disegna nella sua curva una discontinuità non più componibile. Ma il dolore è anche frattale, la perdita di una persona cara è a sua volta scomponibile nella perdita delle sue qualità, dei gesti che in parte possiamo ritrovare negli altri. O, detto in termini geometrici, presenta una discontinuità meno drammatica e secante, non appena assumiamo un diverso sistema d’assi. “Una perdita irreversibile appare come una discontinuità, un salto, nel nostro sentiero attraverso lo spazio delle storie. Focalizzandoci su certe regioni specifiche, proiettando le nostre traiettorie in questi spazi, possiamo ridurre l’apparente magnitudine di questi salti, e di conseguenza trovare una via per confrontarci con la perdita emozionale e forse ridurne l’impatto.”
La geometria del dolore è, va detto, un altro libro che ti spiega come è bella la matematica in base al concept “come è bella la matematica”. Ma anche parecchio di più. Il saggio – che nell’edizione originale ha per sottotitolo “Riflessioni sulla matematica, sulla perdita e sulla vita” – ha l’indubbio pregio di mettere la linea emozionale rappresentata dall’autore e dal suo vissuto davanti a un progetto già in sé estremamente ambizioso, a conti fatti non diversamente abbordabile se non, appunto, con una notevole dose di leggerezza e sensibilità.
Alternando il registro autobiografico a quello più tipicamente divulgativo, Frame riesce a intrecciare – senza lasciare indietro nessuno (e men che meno quelli degli ultimi banchi con i crediti in matematica) – il tema filosofico della perdita e quello neurologico del dolore con la prospettiva scientifico-speculativo delle scienze “astratte”, della geometria, della fisica quantistica. Una prospettiva che, dovunque possa poi condurre, invariabilmente si apre su nuove possibilità e altri mondi, mentre ti offre il possibile conforto di un altrove.