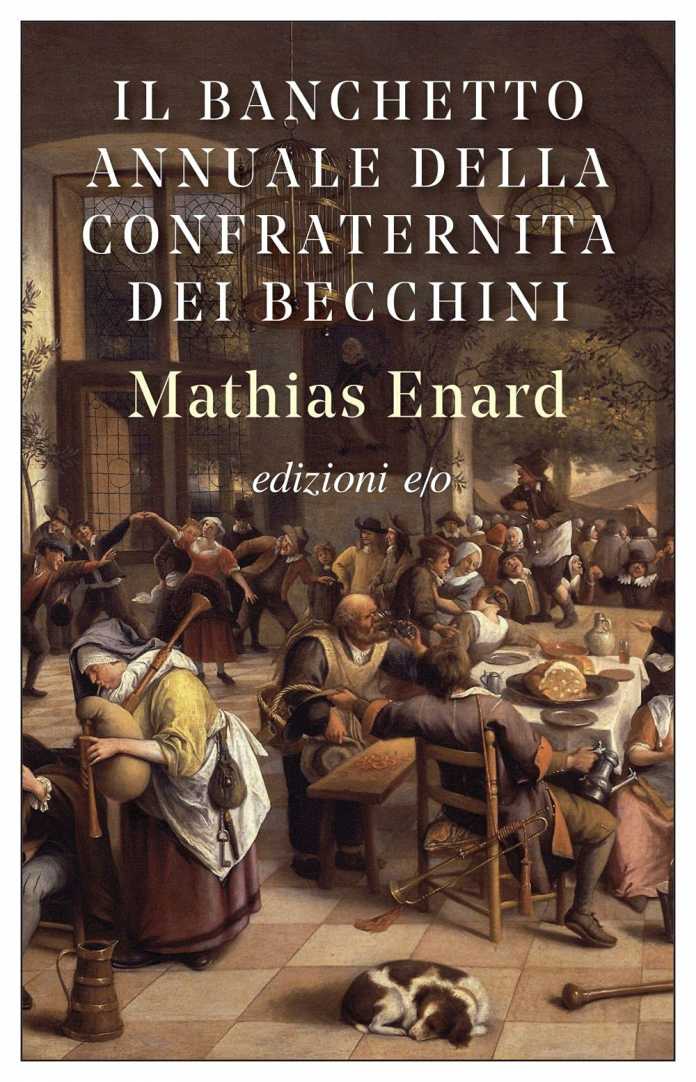Per un autore abituato a esplorare la vastità e la verticalità della scrittura come Mathias Énard, il ritorno ai luoghi natali non è cosa semplice, né si può ridurre a dinamiche esclusivamente autobiografiche. Come dimostra questo romanzo, per Énard (nato a Niort esattamente cinquant’anni fa) tornare a mappare il dipartimento delle Deux-Sèvres, incastonato fra l’Aquitania e i Paesi della Loira (e confinante con la Vandea, già consegnata ai libri di storia dalla rivoluzione francese), ha comportato di fatto la necessità di un’esplorazione a tutto campo, da cui la narrazione autobiografica è stata, in apparenza, bandita in ogni suo aspetto per lasciare posto ad altre tensioni, decisamente più feconde.
Il romanzo (che, in realtà, è una scatola cinese di diversi romanzi, o almeno di vari testi che potrebbero ambire tanto alla forma-romanzo quanto ad altre forme) si apre con il diario di David Mazon, un giovane dottorando parigino che si reca nelle Deux-Sèvres per il proprio progetto di antropologia della prossimità. La sua provenienza geografica, e di classe, in una Francia che si rivela tuttora ancorata al classico binarismo fra l’Île-de-France e il resto della nazione, contribuisce a un disorientamento pressoché completo, al quale i numi tutelari invocati dal giovane antropologo (da Bronislaw Malinowski a Claude Lévi-Strauss) non offrono alcun rimedio. Certamente David è affascinato dal possibile “ritorno alla campagna”, peraltro effettivamente compiuto da molti suoi coetanei, ma è in grado di capire soltanto una minima parte di quello che succede intorno a lui. Il lettore, d’altro canto, è sospinto all’interno del libro da una narrazione diaristica fortemente prosastica (ai limiti, sempre ben giocati, del triviale), in cui l’intreccio sentimentale è probabilmente prevedibile fin dalle prime pagine, ma vi sono anche alcune importanti derive verso il grottesco che aprono spiragli molto interessanti su quello che seguirà.
La seconda e la terza parte del libro narrano le stesse vicende lette nel diario ma dalla prospettiva degli altri personaggi, tornando così a insistere sulle scarse capacità interpretative di David, rivelando anche (con una naturalezza quasi disinvolta, considerando il fatto che il diario di David occupava già un centinaio di pagine) come tali personaggi siano reincarnazioni di vicende umane e animali che si sono avvicendate senza soluzione di continuità nel corso dei secoli nella zona delle Deux-Sèvres, della vicina Vandea e di alcune altre aree del mondo.
Gli intrecci che si sommano e si accavallano l’uno all’altro portano con sé una riflessione (che, pur nella sua eterogeneità di specie e nella sua rigogliosità prospettica, resta comunque, in ultima istanza, parzialmente antropocentrica) sulla vita e sulla morte che trova la propria elaborazione definitiva nella sezione centrale del libro, che reca lo stesso titolo dell’intero romanzo, et pour cause. “Il banchetto annuale della confraternita dei becchini”, infatti, è il cuore pulsante del libro, nel quale vita e morte continuano a essere evocate tanto dalle dimensioni rabelaisiane del banchetto in questione, quanto dai discorsi e dai racconti dei becchini di tutta la Francia che vi sono convitati. Nei primi racconti dei becchini, poi, fa capolino lo stesso Gargantua, a rafforzare anche in questo caso un legame che le numerosissime e invitanti prelibatezze del banchetto, nonché il loro abnorme godimento e spreco, potevano già indicare in modo preciso (grazie anche alla traduzione egualmente gustosa, e talvolta pirotecnica, di Yasmina Mélaouah).
Le successive tre parti del libro contribuiscono (anche grazie all’espediente, non sempre e non del tutto funzionale, della narrazione del protagonista come autore letterario e saggistico fittizio di opere altrettanto inventate), alla conservazione della cornice e allo scioglimento narrativo. È inevitabile, però, che l’attività degli occhi, delle orecchie, delle mani e, soprattutto, della salivazione di chi legge torni a più riprese verso il gioiello che Énard ha voluto incastonare al centro del testo e delle sue molteplici cornici.
Ciò non lo si deve a una lettura superficialmente edonista del testo, né alla fascinazione intellettuale che può scaturire dall’omaggio reso da uno dei maggiori scrittori francesi viventi a uno dei padri fondatori della sua tradizione letteraria (tra l’altro, in Italia e altrove, un po’ dimenticato). Il motivo è da intendersi come apotropaico, il più lucidamente possibile, per una narrazione che in questo ha i caratteri migliori, perché del tutto eterodossi rispetto al mainstream della letteratura post-pandemica; non si può non pensare, infatti, ai primi versi del prologo dell’opera di Rabelais e rilanciarli, così, a chi vorrà leggere quest’ultima fatica di Énard: “O voi che il libro a legger v’apprestate, / liberatevi d’ogni passione / e leggendo non vi scandalizzate, / ché non contiene male né infezione”.