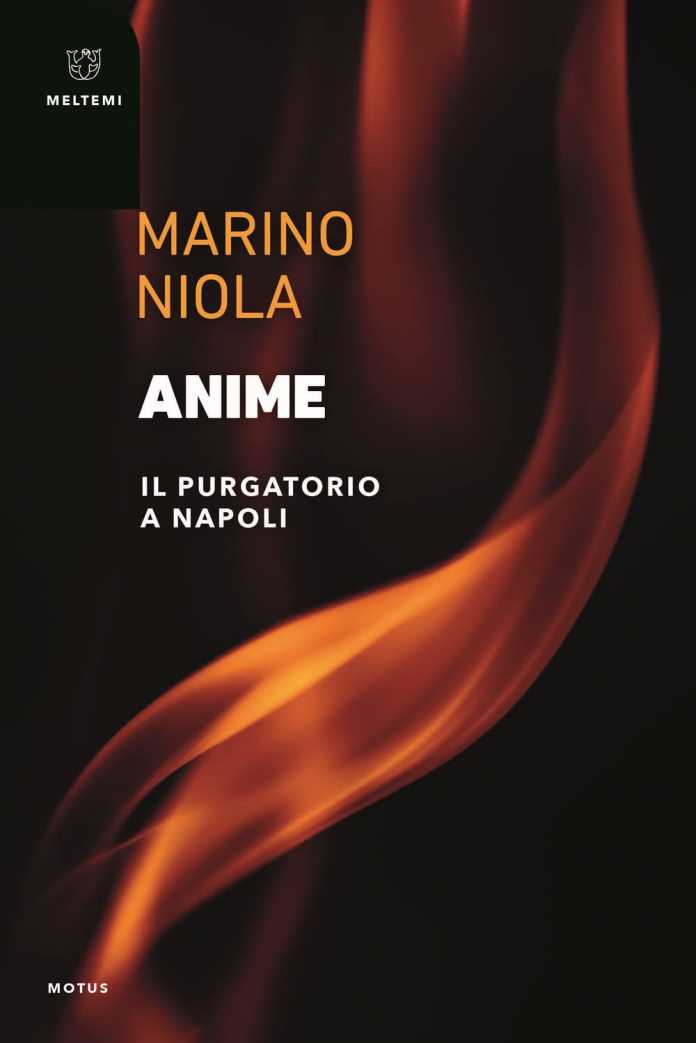“Chiudonsi i tempi a’ voti / di suppliche piangenti; / né godon l’are immunità da’ mali. / Da figli abbandonati / fuggon padri inumani; / e spirti battezzati / in povero squallor spiran da cani”. Sono alcuni versi di un’ode del poeta barocco napoletano Giacomo Lubrano – In nome del padre Carlo Fiorilli gesuita, Espostosi al servigio degli appestati (1692) – che celebra l’eroismo del padre gesuita durante l’epidemia di peste del 1656. Posto in conclusione di una bella antologia curata da Antonio Perrone per Carocci (Poesie d’amore e d’altri disastri. Antologia di liriche del meridione barocco, 2021), l’ode di Lubrano è anche un buon corollario per l’intendimento di un evento centrale nella storia culturale e politica di Napoli nel XVII secolo.
L’eroismo di padre Fiorilli, infatti, è posto in contrasto con le azioni, talvolta eticamente disdicevoli, della popolazione cittadina durante la pestilenza; inoltre, sotto i suoi occhi è ben chiara la tragedia di quegli “spirti battezzati” che “in povero squallor spiran da cani”. In altre parole, lo sguardo del gesuita Lubrano, attento ad alcune particolari implicazioni morali e religiose della vicenda e non ad altre, che invece sono al centro di un saggio più recente di Marino Niola, questo Anime. Il purgatorio a Napoli.
È in quello stesso frangente storico, infatti, che si consolida in modo definitivo l’immaginario del purgatorio che segnerà anche i secoli successivi della storia culturale della città, arrivando fino ai giorni nostri. Le anime dei corpi insepolti delle vittime dell’epidemia (così come tutti gli altri corpi anonimi e non battezzati che via via si accumuleranno nei secoli) sono infatti destinate al purgatorio, in attesa di poter ascendere al paradiso grazie alle preghiere di chi è in vita. Chi chiede l’intercessione divina per queste anime pezzentelle (o mendicanti, e non solo di un posto in paradiso: il testo di Niola spiega bene, e a più riprese, il nesso culturale tra povertà e morte, come anche tra infanzia e morte) ottiene altrettanto beneficio: nasce così una forma particolare di culto, legata alle capuzzelle, i teschi appartenenti a questi scheletri, riesumati dalle fosse comuni per ricevere le cure di altre e altri credenti.
 Concentrato in alcuni siti – la chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, la basilica di San Pietro ad Aram, le catacombe paleocristiane di San Gaudioso alla Sanità e gli ossari del cimitero delle Fontanelle – il culto delle capuzzelle è via di accesso privilegiata a Napoli come Partenope: “occorre penetrare nelle sue terre di mezzo, nella sua geologia fisica e sociale, nei vuoti del sottosuolo ma anche negli ipogei dell’immaginario”, scrive Niola, per andare al di là di un’immagine turistica, e ancor di più canonizzata, della città e della sua cultura materiale e materiale, come quella che si può ad esempio avere spostandosi di poco e visitando quella Cappella Sansevero dov’è conservato il Cristo velato (1753) di Giuseppe Sanmartino e “dove l’estetica diventa estatica, la fisica metafisica e la religione enigma”. Entrambe le citazioni appena proposte provengono dalle prime pagine del testo di Niola, dando conto non solo dell’oggetto dei suoi studi ma anche di un approccio stilisticamente godibile, eppure mai superficiale, a questioni che non sono soltanto antropologiche, ma culturali e filosofiche in senso lato.
Concentrato in alcuni siti – la chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, la basilica di San Pietro ad Aram, le catacombe paleocristiane di San Gaudioso alla Sanità e gli ossari del cimitero delle Fontanelle – il culto delle capuzzelle è via di accesso privilegiata a Napoli come Partenope: “occorre penetrare nelle sue terre di mezzo, nella sua geologia fisica e sociale, nei vuoti del sottosuolo ma anche negli ipogei dell’immaginario”, scrive Niola, per andare al di là di un’immagine turistica, e ancor di più canonizzata, della città e della sua cultura materiale e materiale, come quella che si può ad esempio avere spostandosi di poco e visitando quella Cappella Sansevero dov’è conservato il Cristo velato (1753) di Giuseppe Sanmartino e “dove l’estetica diventa estatica, la fisica metafisica e la religione enigma”. Entrambe le citazioni appena proposte provengono dalle prime pagine del testo di Niola, dando conto non solo dell’oggetto dei suoi studi ma anche di un approccio stilisticamente godibile, eppure mai superficiale, a questioni che non sono soltanto antropologiche, ma culturali e filosofiche in senso lato.
 Coerentemente, la ricostruzione è assai ampia e si avvale anche di un florilegio di testi finale che va dagli scritti ottocenteschi di Francesco Mastriani alla recente testimonianza dell’artista Rebecca Horn: pur non onnicomprensivo – sembrano mancare, a prima vista, le pagine di Walter Benjamin (giustamente richiamato in quarta di copertina per aver scritto Il dramma barocco tedesco proprio a Napoli) o di altri autori citati nel testo – restituisce certamente la complessità e la stratificazione del fenomeno in oggetto. Si pensi, tra i tanti possibili spunti, a uno dei cunti legati alle capuzzelle, quello del Capitano, che Niola riconduce brillantemente a quel topos del convitato di pietra che confluisce, ad esempio, nel Don Juan/Don Giovanni: “sarebbe fuor di luogo considerare la narrazione popolare come una versione indebolita del tema”, appunta Niola; anzi, “la storia del Capitano appare come una variante particolarmente strategica poiché, saltando le mediazioni letterarie e teatrali, va diritto al cuore del mito, contribuendo a mettere in luce come a perdere il seduttore non siano le donne, almeno in origine, ma i morti oltraggiati, non un insaziabile appetito sessuale quanto un’indiscreta indisciplina ontologica che gli fa confondere passato e presente, morti e vivi, ‘cibo celeste’ e ‘cibo mortale’”. Già Ernesto de Martino aveva messo in luce la centralità del banchetto nella ritualizzazione dell’elaborazione del cordoglio; Niola ha buon gioco nell’accostare all’opera dello studioso e intellettuale napoletano la posizione di un altro antropologo di grande levatura come il calabrese Luigi Lombardi Satriani, non sempre in accordo con il più illustre predecessore e dunque suo prezioso complemento dialettico.
Coerentemente, la ricostruzione è assai ampia e si avvale anche di un florilegio di testi finale che va dagli scritti ottocenteschi di Francesco Mastriani alla recente testimonianza dell’artista Rebecca Horn: pur non onnicomprensivo – sembrano mancare, a prima vista, le pagine di Walter Benjamin (giustamente richiamato in quarta di copertina per aver scritto Il dramma barocco tedesco proprio a Napoli) o di altri autori citati nel testo – restituisce certamente la complessità e la stratificazione del fenomeno in oggetto. Si pensi, tra i tanti possibili spunti, a uno dei cunti legati alle capuzzelle, quello del Capitano, che Niola riconduce brillantemente a quel topos del convitato di pietra che confluisce, ad esempio, nel Don Juan/Don Giovanni: “sarebbe fuor di luogo considerare la narrazione popolare come una versione indebolita del tema”, appunta Niola; anzi, “la storia del Capitano appare come una variante particolarmente strategica poiché, saltando le mediazioni letterarie e teatrali, va diritto al cuore del mito, contribuendo a mettere in luce come a perdere il seduttore non siano le donne, almeno in origine, ma i morti oltraggiati, non un insaziabile appetito sessuale quanto un’indiscreta indisciplina ontologica che gli fa confondere passato e presente, morti e vivi, ‘cibo celeste’ e ‘cibo mortale’”. Già Ernesto de Martino aveva messo in luce la centralità del banchetto nella ritualizzazione dell’elaborazione del cordoglio; Niola ha buon gioco nell’accostare all’opera dello studioso e intellettuale napoletano la posizione di un altro antropologo di grande levatura come il calabrese Luigi Lombardi Satriani, non sempre in accordo con il più illustre predecessore e dunque suo prezioso complemento dialettico.
 Se la menzione di Lombardi Satriani appare d’obbligo, a poche settimane dalla sua scomparsa, ancora molti altri sono i motivi di attualità del testo di Niola: se la gestazione del progetto (come testimoniano le numerose interviste incluse) ha inizio almeno vent’anni fa, è soltanto negli ultimi tempi che il progetto ha trovato concretezza, sospinto dalla drammaticità della situazione post-pandemica (con i suoi tanti corpi “insepolti”), ma anche, su tutt’altro piano, dalle politiche culturali della città. Da un lato, la prevista riapertura al pubblico del cimitero delle Fontanelle, a completare un possibile itinerario di cui fa già parte, da tempo, la chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco; dall’altra, le contaminazioni con l’arte contemporanea, come si può rintracciare nell’installazione site specific di Rebecca Horn presso il Museo MADRE, traccia del lavoro, anch’esso ventennale, dell’artista tedesca in rapporto con la cultura della città. In tutto questo, l’auspicio, espresso dall’autore e interamente condivisibile, è quello di “saper riconoscere il valore di un fenomeno a lungo misconosciuto o ‘folklorizzato’ con sussiegosa ironia” per poter giungere magari a un “utile, seppure tardivo, esercizio di autocritica culturale”.
Se la menzione di Lombardi Satriani appare d’obbligo, a poche settimane dalla sua scomparsa, ancora molti altri sono i motivi di attualità del testo di Niola: se la gestazione del progetto (come testimoniano le numerose interviste incluse) ha inizio almeno vent’anni fa, è soltanto negli ultimi tempi che il progetto ha trovato concretezza, sospinto dalla drammaticità della situazione post-pandemica (con i suoi tanti corpi “insepolti”), ma anche, su tutt’altro piano, dalle politiche culturali della città. Da un lato, la prevista riapertura al pubblico del cimitero delle Fontanelle, a completare un possibile itinerario di cui fa già parte, da tempo, la chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco; dall’altra, le contaminazioni con l’arte contemporanea, come si può rintracciare nell’installazione site specific di Rebecca Horn presso il Museo MADRE, traccia del lavoro, anch’esso ventennale, dell’artista tedesca in rapporto con la cultura della città. In tutto questo, l’auspicio, espresso dall’autore e interamente condivisibile, è quello di “saper riconoscere il valore di un fenomeno a lungo misconosciuto o ‘folklorizzato’ con sussiegosa ironia” per poter giungere magari a un “utile, seppure tardivo, esercizio di autocritica culturale”.