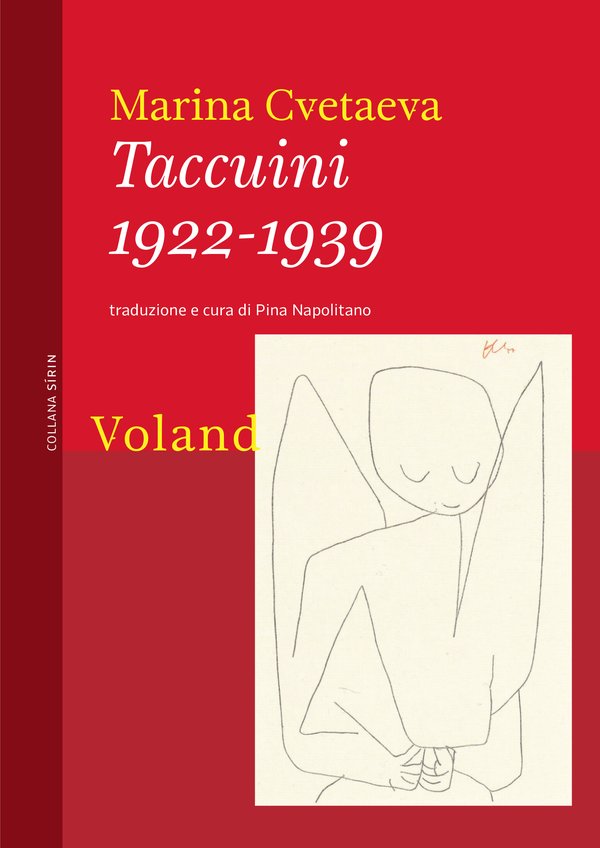Marina Cvetaeva visse di ricordi e desideri, costantemente a disagio nella realtà del presente; per lei l’isolamento nutriva la creatività. Da qui la messe di documenti con i quali cercava di colmare il vuoto che la separava dagli altri, e forse anche da sé stessa: le lettere, i taccuini. A questa scrittura diaristica, compresa nell’arco cronologico che parte dal 1922 e termina nel 1939, Voland dedica un volume tanto ostico quanto interessante, un testo frammentario nel quale introdursi come un archeologo alla ricerca di una chiave per decifrare un mondo ormai estinto. Un mondo, perché la personalità della Cvetaeva è smisurata. Il testo, quasi concepito come argine all’oblio e alla frantumazione, ci giunge in mille pezzi, metafora dello sgretolamento del presente. Una molteplicità di voci lo percorre, una mescolanza di tempi a disorientare il lettore. Come non bastasse tutto questo, la scrittrice usa una gran quantità di idiomi, dal francese al tedesco, quasi a sancire il proprio status di senza patria, costretta a un eterno vagare. Ogni nuovo indirizzo è “la fine di una vita e l’inizio di un’altra”, scrive. Leggendo queste pagine si ha l’impressione di sfiorare una esistenza fantasmatica, come ella stessa lambiva le vite degli altri senza mai intersecarle. Esemplare in tal senso l’infatuazione unicamente epistolare con Rilke. Un incontro concreto, pur desiderato, avrebbe mandato in frantumi i loro corpi e le loro anime, come reperti riportati incautamente alla luce ed erosi dal contatto con l’aria.
Creatura intessuta di sogni, Marina; le sue stesse poesie paiono provenire da inattingibili dimensioni oniriche. Creatura misteriosa inseguita dal destino, ciò che “involontariamente e immancabilmente, con il solo nostro apparire sulla soglia – suscitiamo”. Scrittura aforistica, minimale, colma di pregnanza. L’età moderna non tollera i lunghi respiri e allora, come nella musica di Anton Webern, tutto si asciuga, tutto diviene frammento. “Io ho il diritto di sognare / di fare sogni”, scrive Cvetaeva sintetizzando la propria più intima sostanza. “Voi capirete quando sarà passata, io prima che sia successo”. Come nella Cassandra di Christa Wolf, il dono della veggenza è la capacità poetica di andare oltre le apparenze, di sfuggire la corruzione imposta dal potere. Scrittura monologica quella della Cvetaeva, come del resto accade nelle lettere, dove il destinatario è solo un pretesto per dare libero sfogo ai turbamenti dell’io. Scrittura che aspira a dire tutto, che comprende ogni aspetto dell’esistenza, fino alle notazioni quotidiane apparentemente insignificanti, quasi timorosa di essere interrotta per sempre. Scrittura che muta i luoghi fisici dell’esilio, come Praga, in immagini di sogno e di mondi “altri”.
Il pensiero dell’inevitabile ritorno in patria, costante e ossessivo, si muta nella certezza di andare verso la fine. Le fattezze concrete appaiono “indizi terrestri”, dettagli che le sono di impaccio, che non piacciono alle persone. “Verrà un giorno in cui tutto si staccherà, cadrà”, afferma, quasi a voler sfuggire la propria sostanza corporea. Anche la strana patologia dell’orientamento che la affligge è forse un modo per perdersi, per eludere il reale, per trovarsi “non so dove”. Ecco, l’intero libro è una mappa senza via d’uscita, un puzzle da ricostruire, un tragitto irto di difficoltà ma disseminato di soddisfazioni all’interno di un’anima magnifica, multiforme e per questo inafferrabile.