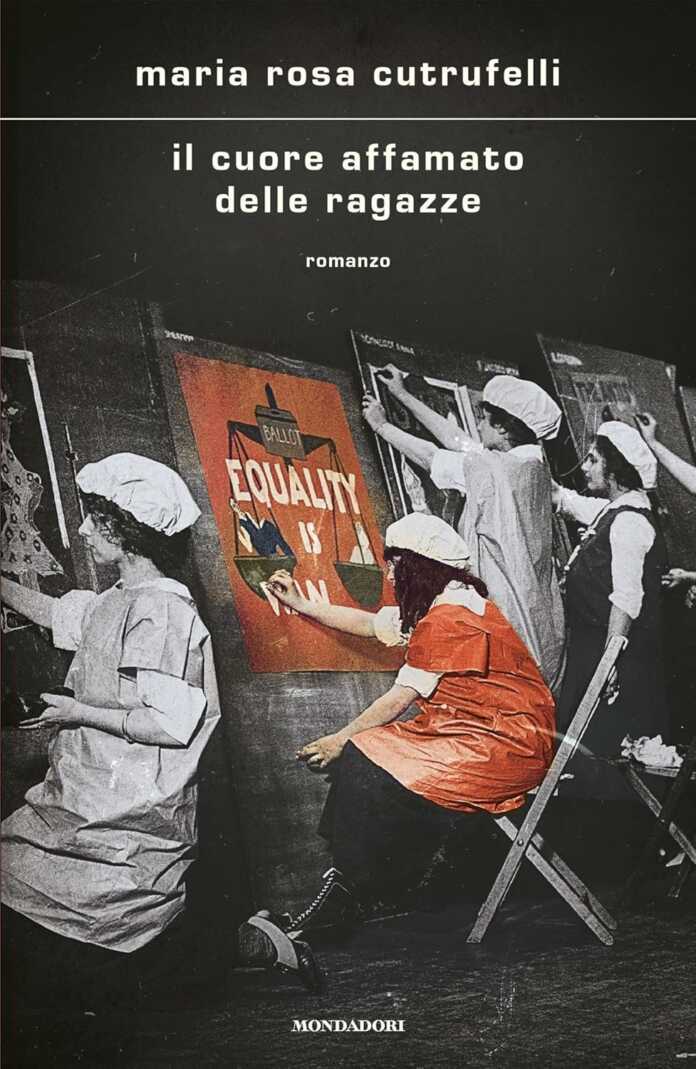Se non fosse un termine abusato direi che la storia che ci presenta Maria Rosa Cutrufelli con il suo ultimo romanzo è una storia importante. Alcuni scrivono storia con la S maiuscola per dare maggior rilievo al termine, ma basteranno poche righe per riassumere l’interessante argomento che la scrittrice decide di affrontare. Con l’escamotage di un’intervista su fatti passati la voce narrante – Etta, un’infermiera di origini italiane – ci porta indietro nel tempo, nell’America di inizio secolo scorso, precisamente nel 1910: sono passati solo vent’anni da quando la nave su cui viaggiavano i suoi genitori è sbarcata a Ellis Island, nella “terra promessa”, insieme a migliaia di altri migranti dalla Sicilia. Il perno della storia, però, ruota attorno all’anno successivo, alla giornata di sabato 25 marzo del 1911, quando va a fuoco la Triangle, una fabbrica di camicie di New York situata agli ultimi tre piani dell’Asch Building, grattacielo di dieci piani di ferro e acciaio, luci elettriche e macchinari, rifiniture in ghisa e colonne di pietra, e infissi protetti da materiale ignifugo, o almeno così si pensava.
Nell’incendio muoiono centoquarantotto persone, la stragrande maggioranza sono donne, per lo più giovani immigrate, in gran parte italiane, tra i sedici e i ventitré anni. Muoiono perché l’edificio avrebbe dovuto avere tre scale esterne di sicurezza invece ne ha solo una, muoiono perché in una città di grattacieli il corpo dei vigili del fuoco è dotato di scale che superano a malapena il sesto piano e le reti di salvataggio si rivelano inadeguate ma, soprattutto, muoiono perché a quel tempo i padroni, anche se ufficialmente sarebbe proibito e moralmente inaccettabile, chiudevano le operaie dentro i laboratori durante l’orario di lavoro, per impedire che portassero via pezzi di stoffa o facessero troppe pause andando magari spesso al bagno. Naturalmente ci fu un processo per accertare le responsabilità delle morti, ma i proprietari della fabbrica vennero assolti: l’assicurazione pagò loro sessantamila dollari per i danni subiti mentre il risarcimento a ogni famiglia fu di soli settantacinque dollari.
Il romanzo è senza dubbio un’opera di finzione ma gli eventi narrati sono fatti storici, così come buona parte delle persone che vi compaiono sono figure realmente esistite, benché non facciano parte della storia che viene raccontata di solito, quella con la S maiuscola. Viene descritta una realtà in cui il sindacato non ha ancora messo piede nella fabbrica e le operaie sono in balia dei reclutatori, “moderni” schiavisti che spadroneggiano, requisiscono le paghe delle ragazze e decidono quando consegnarle, spesso decurtate a loro piacimento. Siamo in un ambiente in cui c’è un ascensore con sedili di velluto riservato agli impiegati e ai clienti dei vari uffici, e un montacarichi per le operaie della Triangle che salgono ai laboratori con un trabiccolo in cui sono costrette a stare in piedi, il naso schiacciato contro la spalla di qualche compagna di viaggio. Siamo in un mondo in cui le macchine devono fornirle le operaie che lavorano con paghe da fame, orari disumani (almeno undici ore al giorno per sei giorni a settimana), in mezzo all’olio fetido degli ingranaggi delle Singer, alla polvere secca che annebbia la vista e senza un adeguato ricambio d’aria.
È un libro questo che sa di rivincita, perché è una voce femminile a raccontare di donne forti, coraggiose e tenaci. Come scrive l’autrice nella nota finale: «Ma c’è da considerare questo fatto, ossia che la Storia l’hanno scritta in prevalenza gli uomini. E si sa che gli uomini non sono molto interessati a ricostruire le vicende terrene del “secondo sesso” (tanto per citare De Beauvoir). In altre parole: le fonti esistono, come ha dimostrato la SIS (Società Italiana delle Storiche), per l’appunto, nei suoi trent’anni e più di vita (arricchiti da una rivista, “Genesis”, e da un premio biennale per una tesi di laurea.) Il problema, per gli storici (cioè per gli studiosi appartenenti al presunto “primo sesso”), è che bisogna saperle vedere, queste fonti. E soprattutto capire “dove” bisogna cercarle».
Un libro che sa di sorellanza. Veniamo a conoscenza delle cosiddette “brigate del visone”, un gruppo di signore dell’alta borghesia che, senza rinunciare a eleganti pellicce, scendono in strada per mostrare la loro solidarietà verso chi è in sciopero; una solidarietà attiva e battagliera: si schierano ai fianchi dei cortei per proteggere le scioperanti dalla polizia che, in loro presenza, non osa attaccare per il timore che una manganellata possa colpirle per sbaglio. Addirittura, non esitano a confondersi con le operaie e, all’occorrenza, a farsi arrestare per mettere in difficoltà i giudici e le alte sfere della politica; una strategia che porta a buoni risultati, dato che nessuno ama infastidire i mariti o i padri di quelle signore, uomini abituati a comandare: banchieri, imprenditori, costruttori – inevitabile domandarsi come mai, oggi, non esista più questo tipo di solidarietà.
È un libro che sa anche di Ken Loach regista che, con il film del 2000 Bread and Roses, narra gli scioperi dei pulitori a Los Angeles, riportando alla memoria lo slogan della leader femminista Rose Schneiderman, “il pane e le rose”, che contrassegnò la lotta del settore tessile nel 1912, per indicare il diritto delle donne a un salario equo ma anche a condizioni di lavoro dignitose e di rispetto; ossia, il diritto di vivere in un mondo in cui si possa godere anche della bellezza della vita senza essere annullate da una sistema in cui il lavoro diventa prioritario e l’unica possibilità di riscatto. Anche in questa occasione vengono in mente i giorni nostri, tempi in cui le ditte che ci pagano lo stipendio ci hanno sapientemente dotato di telefoni cellulari e computer portatili in modo da essere sempre a disposizione, anche durante i momenti di riposo o magari in malattia, in modo che il nostro tempo libero venga rosicchiato, senza quasi che noi ce ne accorgiamo, da un’attività lavorativa magari neanche retribuita.
È un libro che sa pure di anarchia: viene citato il quotidiano “Cronaca sovversiva”, giornale stampato in lingua italiana nel Vermont cui collaborarono anche Bartolomeo Sacco e Nicola Vanzetti, i due anarchici italiani condannati alla sedia elettrica; è un libro che sa di tante cose: amore, amiche del cuore che faticosamente riescono a interpretare correttamente i propri sentimenti ma, soprattutto, è un libro che sa di 8 marzo, anche perché nella memoria collettiva le date del 25 marzo e dell’8 hanno finito col coincidere (la leggenda vuole che proprio dall’incendio della Triangle sia nata l’idea di una giornata internazionale delle donne), ma l’importante credo sia ricordare che la denominazione “festa della donna”, che ancora viene usata, non è corretta: si tratta di una giornata di sciopero, una giornata in cui le donne dovrebbero astenersi dal lavoro produttivo, riproduttivo, salariato o gratuito di cura e dai consumi, e magari ricordare le tante molestie e discriminazioni che ancora subiscono sul posto di lavoro, una per tutte il fatto che le retribuzioni medie lorde degli uomini continuano a essere decisamente superiori a quelle percepite dalle donne, ovviamente senza mai dimenticare che non si può accettare qualsiasi sopruso in cambio di denaro.