Di recente è tornato in stampa Bompiani, pp. 288, 2018, euro 8,75 stampa, euro 6,99 ebook), e fortunatamente anche in formato digitale (a garanzia di una disponibilità a lungo termine), uno dei romanzi più importanti degli anni Trenta. Non solo dei nostri anni Trenta italiani, ma degli anni Trenta in generale, perché se c’è un libro che ha un’autentica dimensione internazionale, o come va di moda dire oggi, globale, quello proprio è L’uomo è forte, di Corrado Alvaro, pubblicato nel 1938.
Ci sono più ragioni per affermare questo. Intanto il contesto storico: questo romanzo ci presenta una società totalitaria in un paese indeterminato (niente all’interno del testo consente di identificarlo, anche se la censura fascista impose ad Alvaro e a Bompiani di farlo precedere da un’avvertenza nella quale si dichiara che la storia è ambientata in Russia); esce, non a caso, nel momento in cui l’Italia è ormai governata da Mussolini da sedici anni, la Germania è sotto il nazismo da cinque, il Portogallo sotto la dittatura di Salazar da altrettanto tempo, la Spagna è dilaniata da una guerra civile nella quale i franchisti appoggiati da Italia e Germania stanno lentamente prevalendo; aggiungiamo che un governo autoritario (e capeggiato da un militare) era rimasto al potere in Ungheria fin dal 1920. Nell’Unione Sovietica infuriava la Yezhovshchina, come si chiama in russo la Grande purga orchestrata da Stalin per eliminare qualsivoglia traccia di resistenza interna.
Insomma, il totalitarismo era la questione del giorno: e Alvaro la prendeva di petto, pur vivendo nel paese che aveva inventato la cosa e il nome, perché il primo a usare il termine totalitario fu Giovanni Amendola nel 1923, proprio per descrivere la peculiarità del fascismo. L’ottusità della censura italiana consentì poi ad Alvaro e alla Bompiani di farla franca, senza rendersi conto di come tutte le considerazioni che nel romanzo paiono attagliarsi perfettamente alla società sovietica potessero applicarsi anche a quella del littorio.
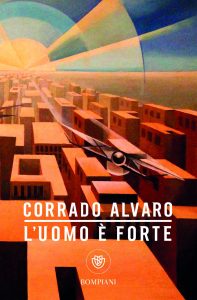 Ma la dimensione internazionale de L’uomo è forte sta anche nel fatto che gli anni Trenta, dopo l’ondata di sperimentazione, provocazione e iconoclastia che squassa il mondo dell’arte e della cultura a partire dai primi anni del Novecento con le varie avanguardie (che nel mondo di lingua inglese vengono pragmaticamente raccolte nel termine “modernismo”), vedono il ritorno a forme artistiche più convenzionali e di relativamente più facile fruibilità (col neoclassicismo stravinskiano in musica, per esempio, o la Nuova oggettività in Germania). La parola d’ordine non era più il rinnovamento totale (che includeva la distruzione delle forme tradizionali), ma il ritorno all’ordine (già proposto da Cocteau nel 1926) e l’impegno politico e civile. Sono gli anni in cui Steinbeck scrive Furore; in cui parte la carriera di George Orwell, con opere centrate su temi sociali come Senza un soldo a Parigi e Londra e La strada di Wigan Pier; anni in cui anche chi continua nella sperimentazione di nuove forme narrative, come John Dos Passos con la sua trilogia U.S.A., mette al centro della sua opera la critica a quel capitalismo che ha mostrato il suo volto con la crisi del 1929.
Ma la dimensione internazionale de L’uomo è forte sta anche nel fatto che gli anni Trenta, dopo l’ondata di sperimentazione, provocazione e iconoclastia che squassa il mondo dell’arte e della cultura a partire dai primi anni del Novecento con le varie avanguardie (che nel mondo di lingua inglese vengono pragmaticamente raccolte nel termine “modernismo”), vedono il ritorno a forme artistiche più convenzionali e di relativamente più facile fruibilità (col neoclassicismo stravinskiano in musica, per esempio, o la Nuova oggettività in Germania). La parola d’ordine non era più il rinnovamento totale (che includeva la distruzione delle forme tradizionali), ma il ritorno all’ordine (già proposto da Cocteau nel 1926) e l’impegno politico e civile. Sono gli anni in cui Steinbeck scrive Furore; in cui parte la carriera di George Orwell, con opere centrate su temi sociali come Senza un soldo a Parigi e Londra e La strada di Wigan Pier; anni in cui anche chi continua nella sperimentazione di nuove forme narrative, come John Dos Passos con la sua trilogia U.S.A., mette al centro della sua opera la critica a quel capitalismo che ha mostrato il suo volto con la crisi del 1929.
Negli anni Trenta anche un poeta come Hugh Wystan Auden deve fare i conti con la guerra civile spagnola, Hemingway simpatizza coi comunisti iberici (a differenza di Orwell) e un capofila delle avanguardie come Picasso dipinge Guernica. Nell’Italia fascista è più difficile scrivere opere di esplicito impegno politico e sociale, e non a caso due dei libri più rappresentativi del periodo escono fuori dal paese a opera di scrittori esuli, e parliamo di Fontamara di Ignazio Silone e Un anno sull’altipiano di Emilio Lussu.
L’eccezione che conferma la regola è proprio L’uomo è forte. Anche grazie agli accorgimenti adottati da Alvaro e da Valentino Bompiani, un romanzo perfettamente inserito nel contesto delineato riesce a passare tra le maglie della censura. E la sua dimensione europea l’attesta la traduzione francese di Alain Rozoy, che tra l’altro ripristina in parte il primo titolo del manoscritto, Paura sul mondo (abbandonato per acquietare la censura): in Francia il romanzo uscirà già nel 1940 come Terreur sur la ville. Solo nel 1949 verrà pubblicata la versione inglese, Man is Strong, tradotta da Frances Renaye, e viene il sospetto che un libro presentato come denuncia dello stalinismo potesse essere colpito, nell’Inghilterra della Seconda guerra mondiale, dallo stesso interdetto che fece ritardare la pubblicazione di un altro testo incentrato sul totalitarismo sovietico, La fattoria degli animali di Orwell (la sua fiaba politica era pronta nel 1944, ma uscì solo a guerra finita, dopo esser stata rifiutata da ben quattro editori: non si doveva offendere l’alleato sovietico).
 Ma di cosa parla L’uomo è forte? In sintesi: Roberto Dale, nato in un non ben specificato paese europeo, lo lascia coi suoi genitori nei primissimi anni di vita; trascorre giovinezza e adolescenza all’estero e diventa ingegnere. Nel frattempo la sua patria viene lacerata da una guerra civile tra due fazioni chiamate “Partigiani” e “Bande”. Sono i primi a prevalere, e a rifondare lo stato e la società, anche se le Bande non sono del tutto sconfitte, e praticano la guerriglia sul confine. Ci viene anche detto che, dieci anni prima dell’inizio della vicenda, Dale ha incontrato all’estero una diciottenne di
Ma di cosa parla L’uomo è forte? In sintesi: Roberto Dale, nato in un non ben specificato paese europeo, lo lascia coi suoi genitori nei primissimi anni di vita; trascorre giovinezza e adolescenza all’estero e diventa ingegnere. Nel frattempo la sua patria viene lacerata da una guerra civile tra due fazioni chiamate “Partigiani” e “Bande”. Sono i primi a prevalere, e a rifondare lo stato e la società, anche se le Bande non sono del tutto sconfitte, e praticano la guerriglia sul confine. Ci viene anche detto che, dieci anni prima dell’inizio della vicenda, Dale ha incontrato all’estero una diciottenne di
nome Barbara, venuta dal suo paese d’origine, ma tornatavi dopo poco tempo, disgustata dalla vita che conducono uomini e donne all’estero.
Il momento di svolta, per Dale, arriva quando visita il padiglione della sua nazione d’origine in un’Esposizione internazionale, e viene colpito da un gruppo statuario che “simboleggiava la nuova umanità nata da una sanguinosa rivoluzione”. Da quel momento prova anche lui disgusto per il paese d’adozione, per “le donne fragili e cascanti, sui tacchi troppo alti, preoccupate di piacere e di sembrare tutt’altre da quelle che fossero in realtà, con la bocca truccata da parer voluttuosa sotto la quale si scopriva la linea delle labbra strette e pettegole”. A questo mondo decadente Dale contrappone la società nuova della madrepatria, celebrata dalle lettere che gli spedisce Barbara; e così decide di tornare.
Appena arrivato, l’ingegnere incontra Barbara, che sembra attratta da lui, anche se Alvaro ci lascia intendere che forse è più l’aria d’esotismo dell’oriundo ad affascinare la donna. In tutto il romanzo ricorrono piccoli episodi che attestano il fascino esercitato da Dale, dai suoi abiti e dai suoi oggetti personali forestieri sulle donne che incontra, e già questo induce a sospettare che nel paese dominato dai Partigiani non siano tutte rose e fiori. Ben presto il protagonista di L’uomo è forte percepisce il clima di paura nel quale vive la popolazione della capitale, e vive il rapporto con Barbara come qualcosa di vietato: perché, come gli viene fatto capire ripetutamente, il solo fatto di essere tornato dall’estero fa di lui un uomo sospetto, pericoloso, da evitare – e al tempo stesso attraente. (C’è la Russia stalinista in questo, sì, ma anche la grottesca xenofobia fascista, che impose di chiamare lo sport “diporto” e il brandy “arzente” perché andavano evitate le parole forestiere…)
La vicenda si snoda nell’interazione di pochi personaggi: oltre a Barbara e Dale, il Direttore dell’Ufficio Tecnico Industriale che dovrà collocare l’ingegnere in qualche fabbrica; la sua segretaria, che vanta conoscenze importanti nel governo, e assai verosimilmente è una delatrice; e poi l’inquietante Inquisitore che appare ripetutamente intento a sorvegliare la coppia, incarnazione dell’apparato repressivo dello stato. Barbara è sempre più angosciata dall’attenzione che le rivolge l’Inquisitore, al punto di decidere di non vedere più Dale. Quest’ultimo, già oppresso dal clima di terrore che soffoca la città, viene divorato dal senso di colpa per aver involontariamente contribuito, parlando con la segretaria del Direttore, all’arresto di tre giovani incontrati nel locale degli Zigani che Dale visita di tanto in tanto, essendo i tre rei di esser stati troppo curiosi sul paese estero dal quale è tornato l’ingegnere. L’atmosfera del romanzo si fa sempre più opprimente e allucinata, con scene che hanno qualcosa dell’incubo più che di una qualsiasi varietà di realismo.
Soprattutto Alvaro scava nella psiche dei suoi personaggi, facendo balenare pulsioni irrazionali e nascoste. L’Inquisitore, per esempio, sembra essere intenzionato a compromettere Dale non solo per ragioni politiche, ma anche perché sotto sotto innamorato di Barbara; a sua volta Barbara, pur attratta da Dale, è prigioniera di tali sensi di colpa da non giungere mai a un rapporto sessuale con l’uomo, e alla fine andrà a denunciarlo all’Inquisitore. La segretaria risulterà alla fine una mitomane più che una spia, e anche il Direttore, apparentemente convinto della bontà della rivoluzione, sarà preda di una pulsione suicida, razionalizzata come esigenza di far sparire un uomo del passato come lui per far spazio alla nuova umanità.
Non sono il primo a dire che dentro questo romanzo c’è tanto Dostoevskij; l’influsso del russo (che Alvaro, molto attento alla cultura di quel paese, visitato nel 1935, conosceva benissimo) è evidente proprio nella psiche tormentata e contraddittoria dei personaggi, pronti a gesti estremi; uno di essi lo compie Dale quando uccide il Direttore, che lo ha convinto di far parte del complotto contro l’ingegnere. E sono proprio le paure e le ossessioni più o meno nascoste a rendere i personaggi manipolabili e utilizzabili; quando Dale viene ingannato dal Direttore e spinto a ucciderlo, diviene quel colpevole del quale ha tanto bisogno l’Inquisitore:
Si ricordi che noi ci interessiamo dei colpevoli. In alcuni casi, il delinquente opera ai fini più alti della giustizia, e la sua opera è necessaria alla società quanto l’esempio dei più fedeli e virtuosi cittadini. (…) Se mi fosse concesso dirlo, affermerei che noi amiamo il colpevole; noi lo seguiamo trepidamente; egli è l’amico e il compagno della nostra opera. Noi abbiamo bisogno di lui come egli ha bisogno di noi.
Infatti l’uccisione del Direttore consente al governo di scatenare un’epurazione su vasta scala (modellata sulle purghe staliniane), perché “si parlava di una congiura e di una grande rete di delitti ancora in progetto di cui si promettevano imminenti rivelazioni.” Il sospetto, l’estraneo, il colpevole diviene così funzionale all’apparato repressivo, e una volta che abbia svolto la sua funzione lo si può anche lasciare andare, come accade a Dale, che dopo il delitto fugge dalla capitale e viene solo accidentalmente catturato da un gruppo di Partigiani; quando rivela loro di essere l’assassino che la propaganda indica come capo della congiura non viene nemmeno creduto.
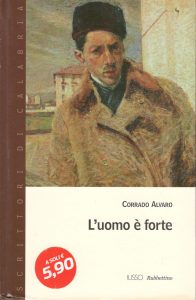 Proprio nelle parole dell’Inquisitore sopra citate si avverte l’influsso di Dostoevskij, in particolar modo del celebre discorso del Grande inquisitore nei Fratelli Karamazov, nel quale il frate che governa la sacra inquisizione spagnola spiega a un Cristo tornato sulla Terra a metà del Cinquecento che lo metterà al rogo perché è troppo pericoloso per l’ordine stabilito da corona e Santa Romana Chiesa; che una società cristiana solo di nome non può tollerare la forza dirompente della vera presenza di Gesù. Alvaro per certi versi va oltre lo stesso Dostoevskij, immaginando che l’eretico, il diverso, l’altro, sia funzionale ai regimi totalitari; siamo alla famosa faccia schiacciata dallo stivale che deve stare lì – per sempre – proprio per essere schiacciata, come spiegherà O’Brien a Winston Smith in 1984.
Proprio nelle parole dell’Inquisitore sopra citate si avverte l’influsso di Dostoevskij, in particolar modo del celebre discorso del Grande inquisitore nei Fratelli Karamazov, nel quale il frate che governa la sacra inquisizione spagnola spiega a un Cristo tornato sulla Terra a metà del Cinquecento che lo metterà al rogo perché è troppo pericoloso per l’ordine stabilito da corona e Santa Romana Chiesa; che una società cristiana solo di nome non può tollerare la forza dirompente della vera presenza di Gesù. Alvaro per certi versi va oltre lo stesso Dostoevskij, immaginando che l’eretico, il diverso, l’altro, sia funzionale ai regimi totalitari; siamo alla famosa faccia schiacciata dallo stivale che deve stare lì – per sempre – proprio per essere schiacciata, come spiegherà O’Brien a Winston Smith in 1984.
E poi c’è la prosa di Alvaro. Tormentosa anche quella; irrequieta e intermittente. Come in questo passo preso dalla scena dell’omicidio:
Dale teneva d’occhio l’uscio della stanza. Non poteva uscire: vibrava tutto ancora di quella violenza, come se la macchina che aveva abbattuto l’uomo la avesse staccata da lui stesso, forse dal suo cuore che gli sfuggiva ancora in avanti. Era divenuto una forza pari a quella del fulmine, terribile e onnipotente. Sedette sul divano, con gli stessi gesti di tutti i giorni; difatti si ravviava i capelli scomposti. Scorgeva un’ombra distesa sul pavimento, con quell’assurda immobilità, e disse: “Sembrava più piccolo”.
Questo incedere convulso delle frasi, questo saltare dall’interiorità all’esteriorità è tipico della scrittura di Alvaro. Come risulta anche dal carteggio tra lo scrittore e Valentino Bompiani, c’era ancora molto in questo stile della prosa d’arte o prosa poetica che dominava nella letteratura italiana di inizio secolo, quando molti letterati rifiutavano il romanzo, sentito come forma ormai superata (un esempio nobile di questo tipo di prosa lo trovate nel Castello di Udine di Carlo Emilio Gadda).
Su richiesta di Bompiani, Alvaro dovette rendere la scrittura più romanzesca, inserire frasi e periodi che manifestassero con più immediatezza la narrazione; come gli faceva notare l’editore, il romanzo appariva “tanto ricco di sostanza lirica da aver bisogno d’essere lievemente diluito”, e lo scrittore accetta di riempire gli spazi bianchi che separano un momento dall’altro sulle pagine del manoscritto con “qualche facile passaggio” che renda la lettura meno impervia. Il risultato è affascinante: una specie di narrazione espressionistica, una sorta di colata magmatica che manda bagliori rossastri nella notte dell’anima e della civiltà.
Infine, attenzione alle date. Pubblicato nel 1938, L’uomo è forte giunge sei anni dopo Il mondo nuovo di Aldous Huxley, e quattordici anni dopo Noi di Evgenij Ivanovič Zamjatin; vien da chiedersi fino a che punto Alvaro avesse presenti questi modelli. Ma le affinità più evidenti, a ben vedere, questo romanzo le ha con 1984 di Orwell. La storia d’amore proibita tra Winston Smith e Julia ricorda molto quella tra Dale e Barbara; l’Inquisitore sembra un prototipo del mefistofelico O’Brien, apparentemente complice della coppia e in realtà ufficiale della Psicopolizia; la stanza n. 3, dove l’Inquisitore riceve in diversi momenti sia Dale che Barbara sembra prefigurare la terribile stanza 101 dove Winston incontrerà la cosa che teme di più; Barbara rinnega e tradisce Dale come Winston rinnegherà e tradirà Julia; e in entrambi i romanzi si rimane col sospetto che l’incontro tra i due amanti sia stato orchestrato dalle autorità per farli cadere entrambi. E poi, il colpevole che – come abbiamo visto – è funzionale alla giustizia (se tale si può chiamare) non prefigura il ruolo che la Fratellanza e l’odiato Goldstein avranno nel romanzo orwelliano? Ovviamente è impensabile che lo scrittore britannico potesse accedere al testo di Alvaro nella traduzione inglese del 1949 (1984 venne pubblicato quell’anno, ed era stato scritto nel 1948); però viene da chiedersi se il creatore della più celebre distopia del XX secolo non abbia letto la traduzione in francese, uscita, come si è detto, nel 1940.
Dovessimo scoprire che la nostra povera letteratura italiana, che secondo alcuni è priva di romanzieri, non solo non ne è sprovvista, ma ha anche fornito modelli ai grandi narratori stranieri del secolo scorso. Dovessimo scoprire che la vetusta tesi secondo la quale l’Italia non avrebbe avuto il romanzo perché non ha avuto una borghesia è – come tante massime tramandate e ripetute meccanicamente – una grossolana semplificazione. Dovessimo scoprire che – come al solito – nei suoi momenti migliori questo porco paese è capace non solo di arraffare idee e modelli dall’estero, ma di appropriarsene, di trasformarli, farli suoi e poi rivenderli alle altre culture. Come abbiamo fatto, una trentina d’anni dopo l’uscita di L’uomo è forte, col western. E come riuscivamo a fare proprio in quegli anni Trenta, quando Fontamara di Silone era preso a modello dagli scrittori politicamente e socialmente impegnati inglesi e americani. Dovessimo scoprire, infine, che la facile, pigra e grossolana svalutazione di tutte le cose di casa nostra è un’altra faccia della nostra malattia nazionale…
In ogni caso, è bene rileggere questo romanzo, che resta uno dei cupi e disperati monumenti del secolo breve, al tempo stesso documento storico e caposaldo della narrativa europea. Anche per rendere giustizia a Corrado Alvaro, per troppo tempo legato solamente al suo pur bello Gente in Aspromonte e marginalizzato come “autore regionale”, lui che era cosmopolita come il suo personaggio, l’ingegner Dale, e che come Dale il totalitarismo l’aveva visto dall’interno, non solo in Unione Sovietica ma anche nella nostra Italietta in camicia nera.



