Il castello è il vero protagonista della saga di “Gormenghast” di Mervyn Peake, la trilogia di cui Tito di Gormenghast è il primo romanzo. In Italia il libro è pubblicato da Adephi nella traduzione di Anna Ravano.
Il castello di Gormenghast è un luogo decadente, pieno di polvere, in rovina, sempre sull’orlo del crollo. È anche un luogo pieno di vita e vite, il contenitore vetusto e fragile di modi di essere bizzarri e poco adatti al mondo. Il Castello è la millenaria residenza della stirpe dei De’ Lamenti, passata di padre in malinconico figlio, fino ad arrivare al riflessivo e mesto Conte Sepulcrio, amante dei libri e del silenzio, un uomo solitario che vorrebbe solo poter trascorrere le sue giornate nell’amata biblioteca di sua costruzione. Ma non può. Sepulcrio De’ Lamenti è il padrone, l’uomo più potente di Gormenghast, e dovrebbe essere il più libero, ma la sua vita è regolata in ogni suo istante e aspetto da riti millenari e simbolici, che solo il decrepito officiante comprende. In più, Sepulcrio ha un cruccio speciale: potrebbe essere il primo Conte De’ Lamenti a non poter dare discendenza diretta visto che ha solo una figlia femmina.
Per fortuna, questo gli viene risparmiato. Nelle primissime pagine del romanzo, lo sguardo del lettore sul castello segue il serpeggiare di una grande notizia: è finalmente nato l’erede tanto atteso, un piccolo maschio, Tito De’ Lamenti. Nella polverosa penombra, il secco primo servitore Lisca, fedele e amareggiato, annuncia l’epocale notizia al custode che vive abbandonato e quasi dimenticato nella Galleria delle Sculture. Lo seguiremo poi nelle barocche e sovrabbondanti cucine, piene di cibi, vini, passioni e salse, perché ognuna delle stanze del Castello di Gormenghast è un barocco mondo a sé. Poi avanti per intricati corridoi e stanze oscure a conoscere l’ansiosa tata, l’incolta e indomita sorella adolescente di Tito, Fucsia, e la poderosa Gertrude dai capelli rossi, madre snaturata e moglie spaventosa, fino a conoscere il protagonista innocente di questo serpeggiare di voci e sguardi: l’ignaro e bruttino Tito, viso sgraziato e occhi viola, portatore di cambiamento e depositario di tradizione, il Settantasettesimo Conte di Gormenghast. Fra rivalità, intrighi e polverosa tradizione, la vita di Tito non si preannuncia facile, e la sua nascita mette in pericolo i delicati equilibri che reggono il pesante e fragile mondo del castello.
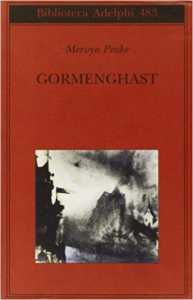 Fin dalle prime pagine emergono potenti gli elementi dominanti di questo romanzo: il minuzioso ritratto di un castello, che più che un luogo è un modo di vivere, e personaggi indimenticabili e unici. È una prosa ricca e non sempre facile che ricorda un po’ quella di Edgar Allan Poe, e l’iniziale lentezza è essenziale per stabilire l’atmosfera di Gormenghast. Il corpo principale del castello fu costruito millenni prima del giorno in cui inizia il romanzo, e ognuno dei Conti di Gormenghast ha aggiunto una sua ala, formando alla fine un vero e proprio labirinto pieno di bizzarri corridoi e ali spesso semi distrutte sempre strampalate, come la stanza delle radici, dominata da un intreccio colorato e inestricabile quasi impossibile da percorrere, o la stanza dei gatti, abitata da centinaia di gatti persiani bianchi, che aggraziati e selvatici si muovono come correnti minacciose di un fiume sul pavimento blu.
Fin dalle prime pagine emergono potenti gli elementi dominanti di questo romanzo: il minuzioso ritratto di un castello, che più che un luogo è un modo di vivere, e personaggi indimenticabili e unici. È una prosa ricca e non sempre facile che ricorda un po’ quella di Edgar Allan Poe, e l’iniziale lentezza è essenziale per stabilire l’atmosfera di Gormenghast. Il corpo principale del castello fu costruito millenni prima del giorno in cui inizia il romanzo, e ognuno dei Conti di Gormenghast ha aggiunto una sua ala, formando alla fine un vero e proprio labirinto pieno di bizzarri corridoi e ali spesso semi distrutte sempre strampalate, come la stanza delle radici, dominata da un intreccio colorato e inestricabile quasi impossibile da percorrere, o la stanza dei gatti, abitata da centinaia di gatti persiani bianchi, che aggraziati e selvatici si muovono come correnti minacciose di un fiume sul pavimento blu.
Le stanze introducono e mettono in rilievo i personaggi che rendono indimenticabile il romanzo. Sono personaggi delineati con precisione, che lentamente assumono caratteristiche nettissime, quasi fossero elementi naturali e parti di un paesaggio. In un castello non vive e soffre solo la nobiltà, ma anche il popolo che lo circonda e i servitori che vivono in funzione dell’aristocrazia. Polverosi e aridi scultori del legno circondano il castello, immutabili e resistenti come cactus. Il primo servitore Lisca, lungo e dinoccolato, scricchiolando come un ramo secco, si contrappone silenzioso e tetro all’immenso cuoco, pieno di animato grasso e sguaiate canzoni, il maligno re delle sovrabbondanti cucine. L’ansiosissima e incapace tata tenta di controllare la torturata Fucsia, adolescente trascurata e ribelle, selvatica come i boschi in cui passeggia e dedita a grandi slanci di generosità ma anche a potenti e divertenti attacchi d’ira (“Odio le cose, odio tutte le cose!”). Il giovane apprendista Ferraguzzo, scaltro e cattivo, ma talmente capace e furbo da non poter non attirare ammirazione, si muove nell’ombra. Le rimbambite e inquietanti sorelle gemelle del Conte Sepulcrio, Cora e Clarissa, vestite sempre di viola, meditano la loro vendetta sull’immensa cognata Gertrude, forse la più grottesca delle creature del castello, che passa il suo tempo a ignorare il marito e trascurare i figli, mentre sussurra paroline dolci al suo airone preferito e nutre trampolieri sminuzzando briciole sui propri capelli.
Su tutto questo vociare e tramare domina incontrastato il Rito, il vero, odiato ma indiscusso sovrano della vita di Gormenghast, un insieme di cerimonie e gesti che regola la vita del castello da millenni, ma il cui significato sembra essersi ormai perso. Il conflitto fra cambiamento e tradizione è al centro del romanzo. Codificato in enormi e polverosi tomi, il Rito ha una risposta e un’incomprensibile cerimonia per ogni situazione. Quasi ogni passo del Conte è dettato dal Rito e spesso a dover partecipare a strane e lunghissime cerimonie studiate in ogni dettaglio sono tutti gli abitanti del castello, confusi e annoiati. Eppure, nessuno sembra mai ribellarsi al Rito, poiché è il Rito che regge e regola le loro vite. Per annoiati o indispettiti che siano, i personaggi non contestano mai il Rito, terrorizzati all’idea dell’ignoto e del cambiamento. Ma il cambiamento è inevitabile, e piccoli spifferi sono già percepibili nei angusti e soffocanti corridoi che nascondono scaltri arrampicatori sociali e strani neonati dagli occhi viola.
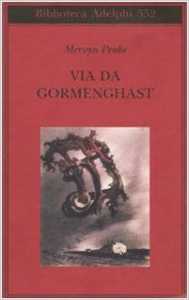 Il conflitto fra tradizione e cambiamento sembra particolarmente significativo se si prende in considerazione l’anno di pubblicazione del libro: il 1946. L’autore, l’inglese Mervyn Peake, scrive in una vecchia Europa, dominata da tradizioni e vecchie rivalità, e assiste alla distruzione portata dalla Seconda Guerra mondiale e alla resistenza a un inevitabile cambiamento sociale e politico. Era un’epoca di particolare fermento letterario e innovazione stilistica in un’Inghilterra con divisioni sociali ancora tradizionali e rigidissime e appena uscita da una guerra che avrebbe cambiato la percezione del concetto di società, cultura e arte. Più o meno in contemporanea, usciranno molti capolavori imprescindibili ancora oggi e che raccontano la medesima tensione: 1984 di George Orwell e molte fra le più belle poesie di T. S. Eliot.
Il conflitto fra tradizione e cambiamento sembra particolarmente significativo se si prende in considerazione l’anno di pubblicazione del libro: il 1946. L’autore, l’inglese Mervyn Peake, scrive in una vecchia Europa, dominata da tradizioni e vecchie rivalità, e assiste alla distruzione portata dalla Seconda Guerra mondiale e alla resistenza a un inevitabile cambiamento sociale e politico. Era un’epoca di particolare fermento letterario e innovazione stilistica in un’Inghilterra con divisioni sociali ancora tradizionali e rigidissime e appena uscita da una guerra che avrebbe cambiato la percezione del concetto di società, cultura e arte. Più o meno in contemporanea, usciranno molti capolavori imprescindibili ancora oggi e che raccontano la medesima tensione: 1984 di George Orwell e molte fra le più belle poesie di T. S. Eliot.
La trilogia di Gormenghast è considerata da molti una delle miglioie opere moderne del genere fantasy, e questo fa capire subito quanto sia particolare e difficile da classificare questo libro. In realtà, il romanzo non contiene nessuno degli elementi generalmente associati al genere: niente dragoni, nessun unicorno, gnomo, fata, nessuna magia e nessuno che sparisce o fa sparire cose. Gli occhi viola di Tito sarebbero davvero poco per poterlo chiamare fantasy. Eppure, non sembra strana la pulsione a classificarlo così. Lo stile barocco e l’ambientazione gotica creano una “sensazione” di fantasy pur in assenza di elementi classici del genere. L’atmosfera è tanto bizzarra e potente da far sentire che quello di Gormenghast è un altro mondo, anche se non sembrano esserci segni che sia davvero così. Anche senza poteri o bacchette, i personaggi sono talmente caratteristici e strani che sfiorano il leggendario. Sia il castello che i personaggi sono delineati da Mervyn Peake in modo chiarissimo, tanto da poterli immaginare in tutti i loro dettagli. Il libro è talmente unico nel suo genere da aver creato la tentazione di definirlo come un genere a sé: il “gormenghastly”.
La corposa bibliografia di Mervyn Peake, se si esclude la trilogia di Gormenghast, è sostanzialmente ancora inedita in Italia. Risultano tradotti in italiano solo i racconti “Captain Slaughterboard Drops Anchor” (tradotto come “Capitan Scannatutti”) del 1939 e “Letters from a Lost Uncle (from Polar Regions)” (tradotto come “Lettere dal Polo Nord”) del 1948, raccolti nel volume Lettere dal Polo Nord, traduzione di Angela Ragusa, Mondadori, pp. 157, e The Rhyme of the Flying Bomb (trad. it. La ballata della bomba volante) del 1962, tradotto da A. Zuccuti per Interlinea, pp. 78.



