È incredibile osservare quanto, ancora oggi, la barriera linguistica influisca sulla fortuna di un autore: quante voci, quanti modi di vedere il mondo ci lasciamo sfuggire solo perché espressi in un idioma a noi estraneo! E quanto più ricchi saremmo se una traduzione incisiva li porgesse con generosità al nostro sguardo! Suscita riflessioni di questa natura l’annuncio del Premio Nobel per la Letteratura 2020, conferito alla poetessa statunitense Louise Glück, in patria destinataria di prestigiosi riconoscimenti e qui da noi quasi sconosciuta, proprio perché alla resa italiana delle sue opere si sono dedicati pochissimi – benché meritori – studiosi. Questa lacuna editoriale risulta tanto più spiacevole se si considera che la poesia dell’autrice americana, con la sua scarna essenzialità, si caratterizza per la sua immediatezza, per la notevole leggibilità, per l’ironia pungente attraverso cui non teme di pronunciare il vero che si annida oltre l’apparenza.
Ispirata dalla figura numinosa di Emily Dickinson per la vocazione intima del suo dettato, Louise Glück viene accostata spesso, suo malgrado, anche alle muse del Novecento confessionale americano, Sylvia Plath e Anne Sexton; in realtà, la sua voce, che pure acquista consistenza dalla tradizione poetica del passato, si distingue per la sua originalità e per la fiera ostinazione con cui si sottrae al canone e a qualsiasi altra etichetta vincolante. La sua frequentazione con il tragico non le impedisce di conservare un ammirevole equilibrio, che le consente di stagliarsi di fronte all’abisso con la fiducia di chi saprà governarlo: con la sua opera, Louise Glück sembra in effetti suggerirci che la parola è lo strumento conoscitivo di cui dispone il poeta per accettare l’ombra senza lasciarsene sedurre, senza soccombere fatalmente dinanzi al buio dei propri tormenti.
La produzione poetica della scrittrice statunitense pare configurarsi come un discorso ininterrotto sull’oltre e, per questo, trova nel mito classico la sua profonda e vitale radice. La sua abilità consiste nell’estrarre dal nucleo delle favole antiche la loro valenza immaginifica e durevole, per proiettarle con un singolare cortocircuito nella contingenza del quotidiano: temporaneamente spogliati della loro cifra di assoluto, i personaggi della mitologia rivivono in una dimensione ordinaria, che tuttavia non cede alla banalità, e riacquistano così autenticità agli occhi del lettore. Valga, tra tutti, l’esempio della sua Circe: in un monologo sornione e puntuto, la maga spiega che, quando trasforma gli uomini di Ulisse in porci, non opera una trasformazione, ma ne fa emergere l’intima sostanza; messi poi da parte gli incantesimi, la dea riesce persino a intravedere la possibilità di una vita a due con l’eroe, un’esistenza felice perché fatta di bisogni semplici; tuttavia questa speranza, nell’istante stesso in cui è espressa, viene sgretolata dalla tempestosa immagine del mare che ineludibilmente richiama il re di Itaca. Senza minimamente essere sconvolta dalla separazione che incombe, Circe mantiene un’invidiabile lucidità, poiché “ogni maga è / nel profondo una persona pragmatica”. La concretezza che la orienta non la priva però dello spessore che la rende immortale: in due versi che suonano come una sentenza, Louise Glück offre al lettore il significato nodale dell’episodio del mito – solo chi è in grado di accettare il limite e di sfidarlo potrà andare oltre e comprendere così in profondità l’autentica sostanza delle cose.
Il potere di Circe
Non ho mai trasformato nessuno in un maiale.
Alcune persone sono maiali; io faccio in modo
che somiglino a maiali.
Sono stanca del tuo mondo
che lascia che l’esteriore mascheri l’interiore. I tuoi uomini non erano malvagi;
la vita indisciplinata
ha fatto loro questo. Come maiali,
sotto le cure
mie e delle mie donne, loro
si sono addolciti subito.
Allora ho rovesciato l’incantesimo, mostrandoti la mia bontà
così come il mio potere. Ho visto
che avremmo potuto essere felici qui,
come lo sono gli uomini e le donne
quando i loro bisogni sono semplici. Nello stesso respiro,
ho previsto la tua partenza,
i tuoi uomini, con il mio aiuto, sfidare
il mare urlante e scrosciante. Tu pensi
che poche lacrime mi sconvolgano? Amico mio,
ogni maga è
nel profondo una persona pragmatica; nessuno che non sappia affrontare il limite
vede l’essenza. Se volessi soltanto tenerti,
potrei tenerti prigioniero.
(Louise Glück, da Meadowlands. Traduzione a cura di Bianca Sorrentino, in Mito classico e poeti del ’900, Stilo Editrice, 2016)
Nel Novecento riscattato dalle rivoluzioni socio-culturali, la Circe di Louise Glück può finalmente liberarsi di trucchi e sortilegi e ribadire una ferma consapevolezza di sé, rivendicando, da un lato, il proprio potere e, dall’altro, la propria magnanimità: lei è una donna che, senza finte modestie, dichiara al proprio uomo che, qualora avesse voluto, avrebbe avuto i mezzi necessari per tenerlo legato a sé; tuttavia chi considera intollerabili le gabbie dorate in cui gli altri, a volte, si rinchiudono preferisce rinunciare a fingere che i propri bisogni siano semplici: anche così non ci si lascia impietosire da lacrime bugiarde.
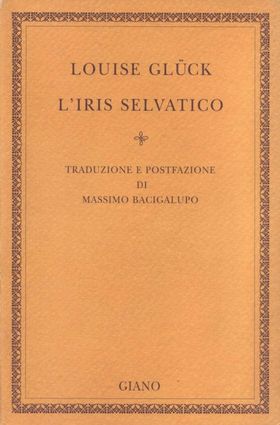
È selvatica, Louise Glück, proprio come l’iris che dà il nome alla raccolta (The Wild Iris, pubblicata in Italia da Giano nel 2003 con la traduzione di Massimo Bacigalupo) che le è valsa il Premio Pulitzer nel 1993 e in cui il giardino si fa metafora dell’esistenza, scrigno colmo di simboli; tra questi segni l’autrice si muove con grazia, li riconosce e senza fatica li lascia emergere. Fiori, stagioni e momenti del giorno si fanno a un tempo interlocutori e voci dotate di autonomia poetica: in uno slancio metafisico, essi rimandano continuamente a significati trascendenti, in virtù dei quali vita e morte, Dio e natura si intrecciano in un viluppo inestricabile che dentro i suoi nodi sa trattenere, insieme ai tormenti, anche il desiderio di eternità. Il conflitto tra opposti, immortale motivo della poesia, incoraggia così un vivace scambio dialettico che solo di rado può ricomporsi in una sintesi rassicurante: il talento di Louise Glück consiste, in effetti, proprio nel saper distinguere il momento in cui è necessario rivelare verità ipocritamente taciute e quello in cui, al contrario, la complessità è tale da richiedere il ricorso al non detto. Spesso i ribollenti interrogativi che la sua poesia pone costringono i lettori a un istante di esitazione, provocano una impercettibile frattura che pure destabilizza. Ciononostante, non mancano le vette in cui la preghiera viene esaudita e la risposta di Dio si manifesta attraverso il Creato, giungendo lì dov’era attesa:
Tramonto
La mia grande felicità
è il suono che fa la tua voce
chiamandomi anche nella disperazione; il mio dolore
che non posso risponderti
in parole che accetti come mie.
Non hai fede nella tua stessa lingua.
Così deleghi
autorità a segni
che non puoi leggere con alcuna precisione.
Eppure la tua voce mi raggiunge sempre.
E io rispondo costantemente,
la mia collera passa
come passa l’inverno. La mia tenerezza
dovrebbe esserti chiara
nella brezza della sera d’estate
e nelle parole che diventano
la tua stessa risposta.
(Louise Glück, da L’iris selvatico, Giano, 2003. Traduzione a cura di Massimo Bacigalupo)
Se questa silloge è animata da una tensione verso l’alto, verso la dimensione celeste abitata dalla presenza divina, la raccolta del 2006 Averno (tradotta in Italia da Massimo Bacigalupo per i tipi della Libreria Dante e Descartes/ Editorial Parténope nel 2019) propone il movimento opposto, esortando il lettore a una vera e propria discesa agli inferi. Qui la materia mitologica è dichiarata sin dal titolo, riferito infatti a quel lago craterico situato in Campania che, secondo gli antichi, costituiva l’accesso al regno oltremondano. Ancora una volta l’allusione classica serve all’autrice per conferire universalità al suo discorso; tuttavia l’aldilà che Louise Glück dipinge si svincola presto dall’immaginario antico, per assomigliare sempre più all’inferno che quotidianamente abitiamo, quello plasmato sulle inquietudini insanabili che scavano il fondo buio del nostro dolore. Ciò che, più di tutto, sembra tormentare la poetessa nella sua ricerca intorno al ‘dopo’ è il distacco tra anima e corpo, l’addio alle cose care che resteranno per sempre in un altrove, condannandoci al pianto amaro della nostalgia. Nel racconto mitologico, Didone ed Euridice hanno stabilito nel vuoto la loro eterna dimora, compiendo una scelta fatale o subendola; ma è Persefone a dettare il passo di questa silloge, lei vagabonda tra due mondi, contemporaneamente regina ed esule, amante e figlia, vergine e preda:
Persefone l’errante
(…) Dicono
che c’è una spaccatura nell’anima umana
che non fu costruita per appartenere
interamente alla vita.
(…)
(Louise Glück, da Averno, Libreria Dante e Descartes/ Editorial Parténope, 2019. Traduzione a cura di Massimo Bacigalupo)
La scissione che lacera la creatura del mito è lo iato che ospita le nostre stesse contraddizioni, quelle che soltanto la poesia sa chiamare per nome, sfidando con coraggio le leggi del tempo. Louise Glück si fa interprete di questa urgenza: conoscerne i traguardi e accoglierne i vibranti interrogativi è l’occasione che oggi finalmente ci viene offerta.



