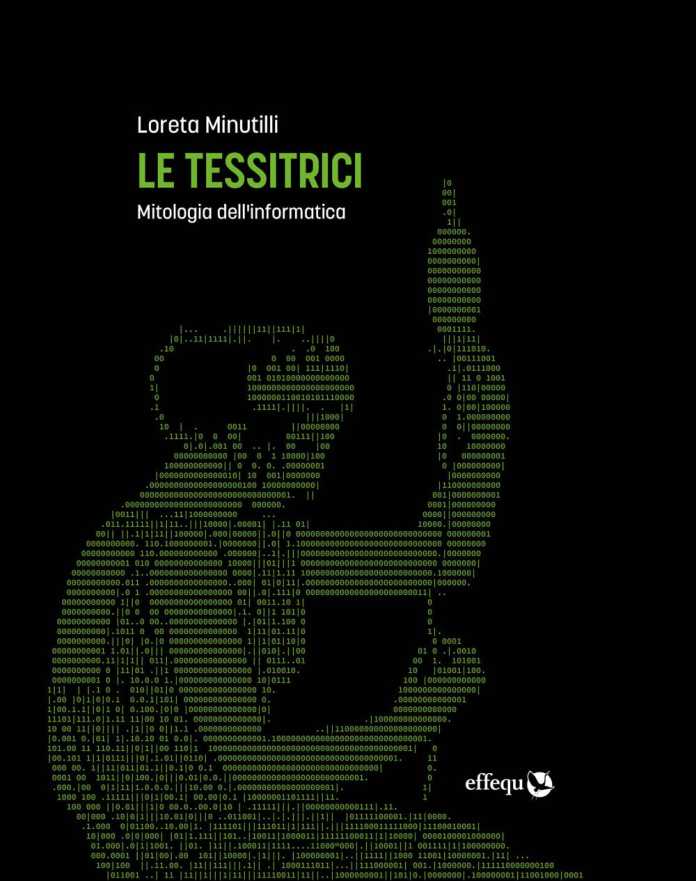Penelope è una figura femminile che si può amare ma anche odiare. Perché non sceglie uno dei Proci? È vero che non saranno stati troppo svegli, se hanno creduto che una donna potesse metterci trent’anni per tessere il sudario di Laerte. Ma, insomma, erano 108. Ulisse abbandona Penelope per ben più del tempo giustificato della guerra, si perde nei suoi viaggi, nella curiosità, nella sete di conoscenza, mentre la moglie vive in una reggia assediata, con decine di uomini che gozzovigliano alle sue spalle. Di Penelope, più che di altre figure del mito, viene da chiedersi se sia stata davvero così. Se non abbia voluto piacere, se non abbia ceduto, se non abbia pensato di rifarsi una vita, se sia stata soprattutto la paura a frenarla (di perdere la buona reputazione, di essere punita). Se davvero non riconosca subito il marito quando torna. Non a caso, è una delle figure mitologiche più riscritte, in antico e in età moderna. E la sua tela è la più celebre di tutte.
 In un saggio curioso e originale Loreta Minutilli ricostruisce le storie di alcune donne pioniere nella storia dell’informatica e in particolare nella nascita della programmazione, individuando nell’arte della tessitura – un sapere femminile per tradizione – l’origine epistemologica e pratica dell’informatica moderna. Il funzionamento dei precursori del computer, macchine giganti progettate e costruite da uomini, era ispirato al meccanismo a schede perforate del telaio meccanico Jacquard (presentato nel 1801). Oltre a questo, tessere e programmare sono lavori assonanti in quanto ripetitivi, dove un errore si paga e che necessitano rigore e pazienza. Un lavoro che nell’America degli anni Quaranta/Cinquanta era ritenuto preferibile affidare a una donna, perché un uomo non sprecava il proprio talento in calcoli reiterati. E così i primi “computer” furono alcune giovani laureate in matematica reclutate dall’esercito americano per lavorare al funzionamento dell’ENIAC, per il calcolo balistico delle traiettorie dei proiettili. Quando il termine passerà dal designare le persone che lavorano alle macchine stesse, quelle donne saranno chiamate operatrici ma di fatto sono state le prime programmatrici di software. Solo in una fase più recente il profilo del programmatore, riconosciuto come mestiere creativo e d’ingegno, è diventato (come è tuttora) principalmente maschile.
In un saggio curioso e originale Loreta Minutilli ricostruisce le storie di alcune donne pioniere nella storia dell’informatica e in particolare nella nascita della programmazione, individuando nell’arte della tessitura – un sapere femminile per tradizione – l’origine epistemologica e pratica dell’informatica moderna. Il funzionamento dei precursori del computer, macchine giganti progettate e costruite da uomini, era ispirato al meccanismo a schede perforate del telaio meccanico Jacquard (presentato nel 1801). Oltre a questo, tessere e programmare sono lavori assonanti in quanto ripetitivi, dove un errore si paga e che necessitano rigore e pazienza. Un lavoro che nell’America degli anni Quaranta/Cinquanta era ritenuto preferibile affidare a una donna, perché un uomo non sprecava il proprio talento in calcoli reiterati. E così i primi “computer” furono alcune giovani laureate in matematica reclutate dall’esercito americano per lavorare al funzionamento dell’ENIAC, per il calcolo balistico delle traiettorie dei proiettili. Quando il termine passerà dal designare le persone che lavorano alle macchine stesse, quelle donne saranno chiamate operatrici ma di fatto sono state le prime programmatrici di software. Solo in una fase più recente il profilo del programmatore, riconosciuto come mestiere creativo e d’ingegno, è diventato (come è tuttora) principalmente maschile.
Le donne raccontate sono poco o per nulla note, specialmente in Italia. Autodidatte o che hanno avuto un accesso difficile al mondo della ricerca, a lungo ricordate come mogli o assistenti di qualcun altro. Eccetto le prime due (Ada Lovelace, figlia del poeta Byron; una celebre attrice degli anni Trenta, Hedy Lamarr) tutte lavorarono a progetti militari statunitensi nel secondo dopoguerra: le programmatrici dell’ENIAC (un precursore dei moderni computer); Grace Murray Hopper, che scrisse quello che oggi è considerato il primo manuale di programmazione al mondo; Arianna Wright Rosenbluth, co-inventrice dell’algoritmo di Metropolis, fondamentale per implementare le funzioni dei primi computer. Tutte, in qualche modo, hanno subito l’effetto Matilda, quel fenomeno per cui le scoperte o invenzioni effettuate da una donna finiscono per essere attribuite principalmente a un uomo. La questione è stata evidenziata per la prima volta negli anni Novanta e ha preso il nome dall’attivista per i diritti delle donne Matilda Joslyn Gage. Spesso è correlata al matrimonio; in molti casi, cioè, il lavoro femminile è oscurato a favore del marito, che firma le pubblicazioni e riceve la maggior parte dei riconoscimenti, tanto da far supporre quasi, come scrive l’autrice, che “la cancellazione sistemica parte da prima: sposare una collega molto competente è un modo comodo per eliminare una rivale e appianare la competizione”. Il racconto di ciascuna di queste figure (estrose quelle di Lovelace e Lamarr, minimaliste le programmatrici americane) è contaminato dalla biografia di una donna della mitologia greca. Oltre all’immancabile Peneolope, c’è Aracne, che fu trasformata in ragno da Atena, indispettita dalla sua superiorità nel tessere. Filomena, che fu violentata da Tereo (il marito di sua sorella maggiore) il quale poi, di fronte alla volontà della donna di denunciare la violenza (un proposito particolarmente coraggioso nella Grecia mitologica dove tutti gli dei, Zeus in primis, erano stupratori), le tagliò la lingua e la imprigionò. A quel punto Filomena inizia a tessere, tessere il racconto, tessere la vergogna. Non si capisce come si procuri il telaio e in quale modo costruisca la narrazione, come in tutti i miti ci sono dei “buchi di trama” (anche questo accumuna miti, tessitura e informatica: i bug). Sta di fatto che trova il modo di trasmettere la conoscenza attraverso un lavoro ripetitivo. La sua vendetta finale è nota e tremenda: ucciderà il figlio di Tereo e glielo darà in pasto. Poi ci sono le Danaidi, le 50 figlie di Danao che non vogliono sposare i figli di Egitto, fuggono e invocano l’aiuto del re di Argo Pelasgo; sono “Le supplici” della tragedia di Eschilo e un caso di sorellanza ante-litteram. Anche in questo caso la conclusione è una vendetta terribile e nell’Ade le donne saranno condannate a un lavoro senza termine: colmare d’acqua, in eterno, delle giare senza fondo. E infine Pandora, la prima donna artificiale, costruita da Efesto e mandata da Zeus agli uomini come punizione per la colpa di Prometeo. Con un vaso da non aprire. Che poi lei ovviamente apre, diffondendo tutti i mali del mondo eccetto la speranza (questo secondo la versione più nota). Tessere non serve solo a far passare il tempo e a confezionare utili indumenti. Nel mito la tessitura spesso è la strada per la salvezza, come nei casi di Filomena e di Penelope. Una donna che tesse da sola è un modo per cavarsela in situazione difficili, definire uno spazio di libertà là dove si è state relegate e marginalizzate.
Le vite reali raccontate da Minutilli non terminano con le vendette tremende del mito. Sono storie di cui molto resta da raccontare, spesso perché le protagoniste stesse non hanno detto molto, e come le storie del mito possono essere disfatte e riscritte. Tutte hanno qualcosa che lascia interdetta l’autrice: il fatto, ad esempio, che a un certo punto queste donne brillanti abbiano abbandonato la carriera per diventare mogli e madri e non abbiano mai parlato con rimpianto del lavoro di un tempo né denunciato l’ “effetto Matilda”. Come mai Hedy Lamarr non cita nella sua biografia il suo lavoro da inventrice, ovvero l’unica cosa fatta “che esistesse al di là del suo corpo”? La perplessità dell’autrice è uno degli aspetti più interessanti del libro, perché introduce un elemento di soggettività, e quindi di riflessione su un piano non teorico ma individuale e relazionale e perché esplica un problema che talvolta le donne hanno con altre donne (e non solo quelle di generazioni precedenti).
“Vorrei trovare nella storia di queste donne un modello, una via di fuga che legittimi il mio desiderio di sentirmi valida fuori da un destino di moglie e di madre. E invece tutto quello che trovo è confusione, dei tentativi di vivere al proprio meglio, di adattare il mondo a sé senza rimanerne schiacciate. Ma forse, per essere delle buone scienziate femministe, dovremmo imparare a essere più comprensive con i nostri modelli. Dovremmo tirare fuori le nostre madri dal silenzio e ascoltare quel che hanno da dire senza fare domande e senza pretendere risposte.” Ascoltare e raccontare, senza giudicare, è un modo per sfumare il confine tra passato e futuro: due categorie spesso troppo ferme che ci impediscono di ricevere i benefici di un tempo pensato come circolare. Nel finale del saggio si suggerisce una possibilità di comprensione più autentica dell’oggi, ottenuta mescolando il passato con il presente: la necessità di mettere in discussione il passato; riscriverlo, domandarsi il perché delle scelte e degli accaduti; immaginare quello spazio inventato “in cui le tessitrici hanno imparato a programmare e le programmatrici si sono sedute al telaio”.