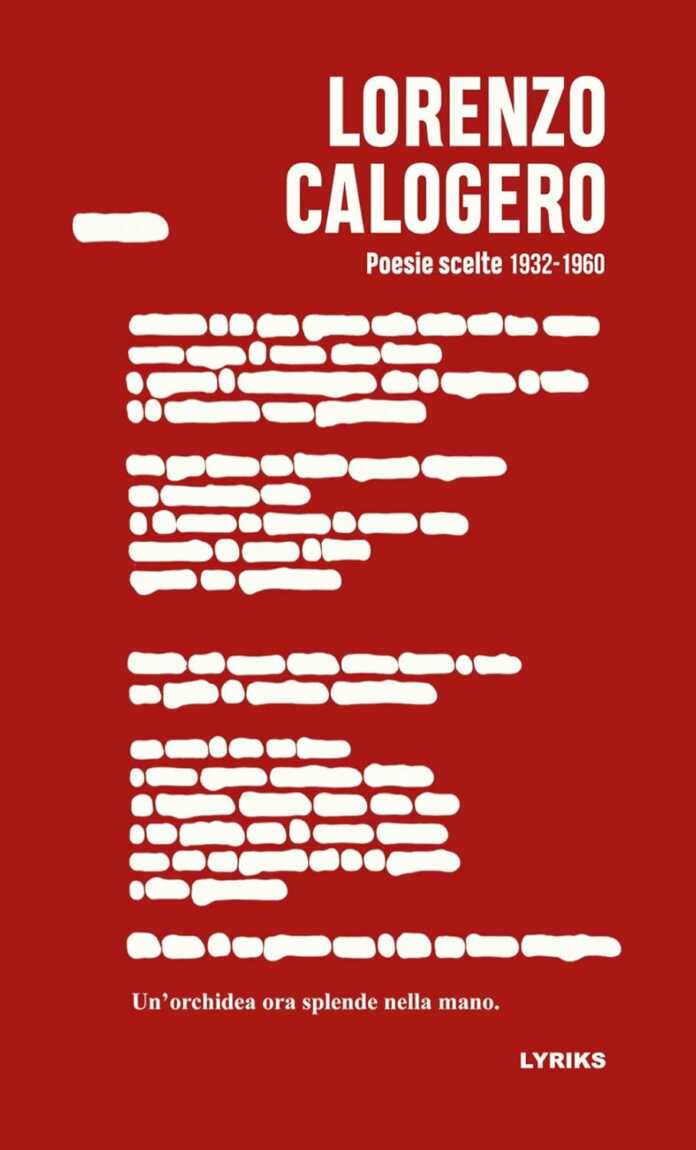C’è una frase che appartiene ai quaderni del fondo di Lorenzo Calogero in cui il poeta afferma che «l’impossibilità di scrivere poesia proviene principalmente dall’accorgersi di non possedere dei simboli che siano validi universalmente (..) attraverso cui si compone e si trasmette la comunicazione». È curiosa per un poeta che ha praticato così strenuamente una poesia che ha fatto della verticalità simbolica, che per brevità definiremmo orfica, ermetica (ma è possibile anche un’altra lettura) e del groviglio referenziale, la sua caratteristica. Il fatto è che Calogero ha vissuto sulla propria pelle un dramma della intransitività, non solo per il suo stile, un flusso a-logico semantico-sintattico (basti un esempio da Avaro nel tuo pensiero in cui si passa da riferimenti geometrici a naturali e tra questi ultimi prima il mare, poi i monti, poi si passa all’onirico: «Sopra mormorii quadrati/ di onda in onda, sopra una vetta antica/ perduta, di gennaio, i tuoi sogni/ sono oggi esigui»).
Tuttavia l’intransitività che soffrì Calogero era biografica. Non si vuole qui dare un taglio confessional, ma evidenziare che il poeta fece di una condizione consapevole («Ripopolo il tempo mio con ombre/ stanche e parlo da solo») tutta la sua attività di compilatore di pagine e pagine, centinaia di quaderni e manoscritti, un immenso unico biografema della non-comunicazione. Mai riconosciuto in vita, ebbe attenzione dopo morto negli anni ’60, poi di nuovo silenzio, poi alcune pubblicazioni da Donzelli più di dieci anni fa, ma di fatto la sua è una presenza che regolarmente sprofonda nell’ombra.
A riproporre un poeta prima non ascoltato, poi più volte dimenticato, un nuovo volume dall’enorme corpus dei suoi scritti: Poesie scelte 1932-1960, curato da Nino Cannatà, con prefazione di Aldo Nove, raccoglie anche una parte di testi fino ad ora inediti (tradotti in inglese da John Taylor) e un elegante copertina con un’opera espressamente dedicata al poeta da Emilio Isgrò. Una scelta che, se analizzata sul piano testuale, si rivela essere un frutto tardo-ermetico, per lessico e immagini, in linea con un certo manierismo lirico. Tuttavia c’era in lui – tra consapevolezza e istinto, molto altro e vale la pena rileggerlo o scoprirlo anche attraverso questo volume.
Nato a Melicuccà, in provincia di Reggio Calabria nel 1910, di famiglia benestante, si laurea in Medicina (ma con pratica di medico travagliata), una vita pressoché in solitudine e una sofferenza psichica con diversi ricoveri per crolli nervosi. Pubblica a sue spese alcune raccolte, scrive a poeti, editori, giornalisti, non riceva mai risposta e chi lo fa si nega o risponde negativamente. Succederà con il gruppo di “Frontespizio” negli anni ’30 e con Carlo Betocchi. La sua poesia divenne un esercizio solitario che si perde in un vapore (immagine ricorrente). Sicuramente è un poeta che guarda all’ermetismo, di quel movimento ci sono gli stilemi e un certo manierismo, immagini simboliche, e un lessico prezioso, alto. Le sue strofe dal cumulo immaginifico in versi di misura tradizionale mostrano però pian piano col tempo spezzature in emistichi, forzati dalla punteggiatura, da una sintassi contratta (“So rarefatta onda con aria”), ipermetrie, rime distribuite e più ancora reiterate assonanze, anche in modo ossessivo e ingenuo (la ricorsività di termini come “traccia” “vano” “vuoto” “nubi” ecc.). Quel che accade a Calogero però è una sorta di attivazione di una metamorfosi perenne delle sue immagini ricorrenti, seguendo un istinto compositivo, creando un infinito impromptu (nel jazz pensiamo a Martin Feldman).
Costruisce i versi con immagini naturali ma senza naturalismo, senza sensualità, più come parte del caos di pensieri associati e poi dissociati. Né impressionismo né espressionismo, la costante variazione delle combinazioni associative dissolvono il tessuto allegorico di una individuabile referenzialità a favore di una concatenazione analogica spesso senza logica. La scrittura in Calogero era più un sismografo che restituisce l’onda di un essere che si svuota con punte di consapevolezza («Più non riconosco/ una larvata presenza di essere»). Più che calligrafia, il testo poetico è un regesto psicofisico che – come aveva scritto Caproni – contiene una “disperazione ormai così alta, e calma, da non conservare più traccia di dolore”. Calogero deborda verso una materia vuota di linguaggio, fatto di poche occorrenze ripetute e variate e combinate fino a creare un conglomerato di “arabeschi” di cui scrisse con grande intuizione Sinisgalli (da matematico deve averci visto un’ampia lavagna di calcolo, in cui cercare una formula della materia).
Egli scrisse sempre, per decenni, riempiva il silenzio di carte e quaderni (oggi nel Fondo Calogero dell’Università della Calabria ci sono circa 800 quaderni e un totale di circa 15.000 versi inediti). Anche quando ottenne un riscontro (il premio Villa San Giovanni nel 1957) con l’ennesima raccoltina autopubblicata, Come in dittici, con prefazione di Sinisgalli, che era anche in giuria, non seguì alcuna proposta editoriale. La vita si fece sempre più complicata, con ulteriori ricoveri, crolli nervosi, lutti. Morì nel 1961 e solo con la pubblicazione di due raccolte postume dell’editore Lerici (nel 1962 e nel 1966) ci furono attenzioni, recensioni. Possiamo allora rileggere Calogero fuori da consuete categorie letterarie storicizzate (lo giustificherebbe certo il piano testuale) ma va notato il complesso e la continuità della sua operazione di scrittura. Calogero fece di sé stesso, come avviene per la body art, un artista perenne impegnato a creare una unità psicofisica del vivente con l’opera. Qualche anno fa Massimiliano Gioni diresse una Biennale Arte Venezia intitolata “il palazzo enciclopedico”, ospitò una serie di artisti non canonici, che lavorarono tutta la vita a loro progetti, tra il dilettantesco e il sublime, senza mai entrare in contatto con il mercato dell’arte. Anche Calogero costruì con il suo “inframondo” poetico un buco nero in espansione, materia oscura e scritta, che divenne una dimensione parallela e invisibile.
Nonostante la storia di sofferenza psichica. la sua poesia può essere definita “sintomo” prendendo il significato che gli dà il critico d’arte Didi-Huberman, leggendo gli artisti irregolari della Biennale di Gioni: “sintomo” in senso “critico e non clinico” ovvero “segno disruptivo, che annuncia visivamente qualcosa di non ancora visibile”. Di questo non vedere sono molti i riferimenti in Calogero (“Scrivo e non vedo” o “perché qui e non altrove/invisibile sia e duraturo un segno”). La sua perenne macchina celibe di computazione di versi durò decenni, parallela a movimenti poetici, fino a lambire gli inizi della stagione della Neoavanguardia e del gruppo ’63. Ebbene proprio mentre dominavano i poematici disturbi della rappresentazione, il lavoro sulla palus dell’inconscio, Calogero, lontano da essere un caso psichiatrico o dal volerlo rivendicare, fu un poeta che voleva essere solo poeta, aderendo con tale dedizione al suo “lavoro interno” da farne installazione di un altrove, scrivendo nella sua trance mosso dal demone dell’analogia che tuttavia faceva perdere ogni riferimento dell’ἀνάλογος. Di fatto la sua scrittura essicca la retorica poetica che usa, utilizzando la facies del poetese tardo ermetico che è presentissima per campioni (di fronte al “vespero” il poeta cerca “ciò che nel deserto suo rossore/ a me apparve oggetto trepido/ d’un segno” e cose simil-simboliste). Ma la sua pratica analogica è così rizomatica, ipnotica, decentrata: con le logiche sintattiche sconnesse, Calogero è come se disidratasse la parola della poesia anche dal “simbolico”, togliendo gli appigli per dedurre di cosa le metafore siano simbolo. Un deserto di significanti che si apre sul confine radicale di un andamento sintattico-semantico che sottrae ogni significato percepibile alla sua poesia.
Pur essendo formalmente un lirico, questo procedimento non si basa sull’asse negativo del processo di auto-individuazione tipico della lirica moderna post-Rimbaud (l’Io è un Altro per capirci) ma diventa più riflesso di una “fluttuazione cognitiva” (Caterina Verbaro) data da una compulsiva pratica automatica della scrittura che tenderà ad evolversi in modo metamorfico (tanto che via via si avvicinerà a un certo surrealismo moderato), ma non a caso ricevette l’attenzione di Amelia Rosselli. Ci si consenta l’azzardo – che può trovare proprio Nove come ponte ideale – ma in questo procedere “macchinico” e generativo di suoi formulari metaforici, Calogero fa in altro modo quel che faceva Balestrini con gli elaboratori. Lo farà più come un rituale ossessivo, svuotante, approdando a una scrittura di testi che si fanno simil-connotativi ma di fatto indipendenti dal significare.
La sintassi è la sua principale novità, scrisse di lui Amelia Rosselli che – se certo empatizzava anche nello specchio convesso della persona, comprendendone lo stato d’animo – trovava che la novità stilistica di Calogero fosse soprattutto la sua grammatica: “la sua plasticità, ed estrema attenzione ad una sintassi di logica indiretta” scrive Rosselli in un saggio degli anni ’80 ora raccolto in Una scrittura plurale, saggi e interventi critici (Interlinea) e che per l’autrice di Variazioni belliche forse provenivano dai primi studi di Calogero di Ingegneria (come, singolarmente, era ingegnere-matematico Sinisgalli, ma anche la stessa Rosselli al procedere matematico della musica aveva guardato impostando il suo Documento). Questa diversa intelligenza data da questa logica alternativa è – nell’artificio della combinazione linguistica – domanda e interrogazione di un’alterità che (come i tanti corrispondenti epistolari di Calogero) non ha mai da fornire una risposta che sia comunicabile se non nell’incessante interrogare della versificazione di Calogero e fuori dal linguaggio comunicativo e simbolico, forzando quest’ultimo a costruire un algoritmo-codice capace di penetrare in quell’altrove di fronte al quale Calogero è sempre stato come una porta chiusa, una lettera mai arrivata. Che sia il mondo di morti, che sia suo sembiante alieno e finalmente salvo dall’infelicità terrestre in cui è rimasto imprigionato, che sia una lingua che abiterà il mondo a venire, quello che dobbiamo ancora scoprire, questo è qualcosa che non si potrà dire che abitando quel codice.